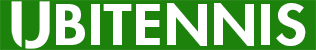Racconti
#TennisDiPeriferia: le mie racchette da tennis, le compagne di una vita

Cambiare racchetta da tennis scandisce la nostra vita tennistica come fidanzate e mogli segnano la nostra vita di coppia. C’è chi ne cambia tante, chi poche. C’è poi chi è tradizionalista e chi è futurista. Spesso non si sceglie quella giusta ma le racchette, comunque, ci accompagnano sempre, loro sì mano nella mano
Spesso crediamo che dipenda tutto dalla racchetta. La guardiamo quando un nostro colpo esce male dal piatto corde, la ignoriamo quando invece tiriamo un vincente. Le racchette ci accompagnano nella nostra vita tennistica e con loro o si è mariti fedeli o compagni fedifraghi. Non ci sono vie di mezzo: o si gioca con la stessa per anni, magari solamente aggiornandola con l’evoluzione del modello se la casa madre non la stravolge, oppure la si cambia con la stessa frequenza dei flirt in età scolastica. Una cosa è certa: cambiare racchetta è un po’ lasciare un pezzo di sé in qualche armadio o in qualche forum di vendita online. Quel tennis lì, non tornerà più a farsi vedere in campo.
In principio fu una Yamaha. La mia prima racchetta da tennis era bruttina e, non so perché, all’età di quattordici anni scelsi proprio un modello Yamaha, il marchio famoso per le pianole e per i motori, non di certo per le racchette da tennis. Ad ogni modo la mia prima scelta fu una Focus 20, un telaio mezzo profilato e molto flessibile, al quale, come se non fosse già brutto di suo, pensai bene di abbinare una accordatura di quelle che più da principiante non si può: la multicolore. Col senno del poi, era giusto: all’epoca non sapevo giocare a tennis, non avevo capito il tennis. La mia esperienza era quella del muro e il muro era quello del garage di casa, che ai lati aveva due pareti, una lunga e una corta, che davano su un piazzale. Ho passato intere estati a tirare palline addosso a quel muro assieme a mio fratello, giocando come nello squash, pregando i miei genitori di non parcheggiare più lì la macchina. Sulla parete che rimbalzava le nostre pallate emettendo un suono tonfo, che perdurava per ore a intervalli regolari, avevamo inchiodato una fettuccia di stoffa a mo’ di rete. Da precisi amanti del tennis quali eravamo, la fettuccia inclinava leggermente verso il centro del muro, a quota 91 centimetri, come se alle estremità della stessa ci fossero dei paletti a sorreggerla: io e mio fratello ci eravamo costruiti il nostro campo da tennis.
E comunque quella Yamaha, con il fodero rigorosamente corto a lasciare scoperto il manico, mi sembrava la racchetta più bella del mondo. Solo che non sapevo usarla. Prima di quell’acquisto, io e mio fratello, più piccolo di qualche anno, avevamo raccattato delle vecchie racchette di legno trovate in casa, le classiche Maxima Torneo di ogni famiglia anni ‘80, per usarle nel nostro campo-muro. Nostro padre giocava qualche volta a tennis, quando veniva il cognato da Roma che invece era un discreto tennista. Zio Franco, così si chiamava, portava racchette e palline per tutti, e quindi prima del pranzo della domenica si andava tutti assieme al campo comunale del paese, dove un anziano custode era gelosissimo di quel manto in terra rossa calcato solo da poche decine di persone. Siamo negli anni ’80 e il tennis è ancora uno sport di élite.
Giocavamo talmente tanto durante le nostre noiose estati al paese, noi che abitavamo anche in campagna e quindi lontani dallo struscio del corso comunale, che mio padre si convinse a portarci da un maestro a prendere lezioni di tennis. Noi eravamo eccitatissimi. E quindi io e mio fratello, che aveva scelto una Prince come prima racchetta, fummo “dislocati” per molti pomeriggi in un complesso sportivo di un paese vicino, dove oltre ai quattro campi da tennis c’erano un campo da calcio e una grande piscina. Due di questi campi erano in terra battuta e fronteggiavano altri due, in cemento. Iniziammo a prendere lezioni sul duro e solamente molti anni dopo capiremo l’importanza di aver iniziato a gestire i rimbalzi della pallina su questi manti molto americani, una rarità all’epoca, nell’Italia del tennis rosso.
Il nostro maestro era un insegnante scolastico ed era stato buon tennista in passato. Amava il tennis classico, quello dell’impugnatura unica di nome Continental che, come recita la prima regola del manuale del tennis, è l’unica con la quale puoi eseguire tutti i colpi del gioco. Lo ricordo sempre vestito di bianco, con la sua enorme e leggera racchetta profilata, a gestire lo scambio mentre con la mano sinistra raccolta al cuore teneva fino a quattro palline contemporaneamente, pronte per essere immesse in gioco. Era sempre vestito Nino Cerruti, una marca che era anche nel tennis allora. Il nostro maestro doveva essere stato sponsorizzato da questo brand perché, sia in campo che fuori, dopo la doccia, lo vedevo sempre vestito a firma Cerruti, completino o tuta che fosse.
Prendere una lezione di tennis non è entrare in campo e provare subito a tirare la pallina. Passano un bel dieci minuti prima di usare quella racchetta fiammante che tanto ci aveva eccitato all’acquisto. Si ascolta il maestro che ti spiega come eseguire i movimenti giusti, come mettere le gambe nella maniera giusta, e come la racchetta debba seguire un giro preciso, pena l’esecuzione sbilenca del colpo. Non erano lezioni individuali e quindi si imparava il tennis alla vecchia maniera: istruttore da una parte e fila indiana dall’altra, con gli aspiranti tennisti ansiosi di colpire le quattro palline di rito, cercando di non ciccarle per allungare la permanenza in campo. Quando si sbagliava si tornava indietro, verso i teloni e si era costretti ad eseguire i movimenti a vuoto. Una pratica che ci sembrava inutile e noiosa ma che invece era propedeutica – se fatta bene, cosa che non facevamo quasi mai – a “metabolizzare” la giusta esecuzione dei nostri swing. Passammo un’estate intera a prendere lezioni e a socializzare con altri bambini wannabe-tennisti, imparando a far uscire dalla nostra racchetta i colpi in maniera fluida e piatta, cercando di sbagliare poco. Continuammo a prendere lezioni anche d’inverno, visto che quei due campi contigui in cemento venivano coperti da un pallone pressostatico. Dopo qualche mese avevamo raggiunto un buon livello di gioco, specie mio fratello, ma eravamo ancora lontani dal diventare tennisti discreti.
La cosa si fece più seria con il passare del tempo, e la Yamaha diventò quindi vetusta, finendo frantumata durante una delle nostre partite nel campo-garage sotto casa. Era diventata già da un po’ la seconda racchetta a mia disposizione, perché nel frattempo io e mio fratello avevamo cambiato circolo e acquistato due nuove racchette. Tutto era diventato più serio nel volgere di pochi anni. La passione per il tennis durava – anche se io l’alternavo al calcio – e a un certo punto mio padre si poté permettere di pagarci qualche lezione da un maestro più titolato. Iniziammo sempre d’estate, dopo scuola, che all’epoca non era ancora un problema. Il campo era di fronte a un negozio di articoli sportivi. Internet era ancora roba militare perlopiù e quindi non c’era altra possibilità che scegliere il proprio telaio da una bella parete di racchette. Il mio idolo e modello di gioco era Thomas Muster, e quindi la scelta della racchetta era obbligata: una Head. Invece di acquistare però la sua Prestige pro 600 rossa, mi feci influenzare – io giovane figlio della televisione – da questi nuovi modelli profilati che promettevano tantissima potenza rispetto alle pesanti racchette a sezione costante dei professionisti. Io, che volevo solo squarciare la pallina con la forza e l’esuberanza di ogni teenager, scelsi una Head Genesis piatto 660 dal paintjob fantasia: una padella. A rivederla con gli occhi di oggi, quando la mia racchetta è una elegantissima Wilson Blade ’93 dal profilo costante e piena di nero, realizzo che fui capace di toppare la scelta della racchetta per la seconda volta consecutiva.
All’epoca le racchette si acquistavano senza provarle, andando a intuito e seguendo i consigli di chi ne sapeva di più. Quella Head si rivelò una scelta sbagliata anche perché non era adatta al mio gioco. Il maestro tanto titolato non era molto al passo con i tempi e, come tutti gli insegnanti della zona, non aveva aggiornato il modello d’insegnamento. E quindi si stava in campo con lui da una parte e noi dall’altra, con il cesto a portata di mano e noi a colpire senza continuità di gioco.
(La Fit qualche anno dopo cambierà radicalmente le linee guida di insegnamento del tennis, adeguandosi alla modernità, dopo essersi resa conto che per molti anni in Italia non si insegnava tennis correttamente)
A forza di studiare il mio idolo in televisione – ma in generale tutta la nuova generazione di tennisti moderni – avevo capito che dovevo girare l’impugnatura, ovvero impugnare con la faccia della racchetta che guarda a terra mentre “stringo la mano” al manico, nella più classica delle prese “Western”. Ero pronto quindi per esasperare la rotazione in top spin. Come Thomas Muster, ovviamente. Ben presto le lezioni che prendevo con questo maestro, che giocava con una Dunlop Max 200G come McEnroe e Steffi Graf, e che veniva pagato trentasei mila lire all’ora per dirmi “non esasperare”, divennero inutili. Anche perché io avevo capito che il tennis si stava evolvendo e lui, che era stato ex giocatore di serie B, insegnava ancora il diritto con la Continental. Eravamo a metà anni 90, Muster vinceva il Roland Garros e diventava numero uno al mondo facendo compagnia ai piani alti della classifica ai tennisti dal gioco classico, gli Stich, Edberg, Becker e Sampras.
Giocare esasperato in top spin impugnando “full Western”, colpendo di fatto la pallina sempre con la stessa faccia della racchetta, anche con il rovescio, era impossibile con una profilata. Le stecche arrivavano copiose, così come le rotture di corde. Iniziai comunque a sviluppare un senso estetico del tennis, almeno a livello embrionale. Non nei movimenti di diritto e rovescio però, ancora sgraziati e strappati e che erano riproduzioni in scala di efficacia dei gesti di Muster. All’epoca, inoltre, ero arrabbiato con madre natura: non mi aveva fatto mancino e non avevo di certo il talento di Volkov, tennista russo che dopo un incidente ripartì da zero re-imparando a giocare a tennis con il braccio sinistro. Ad ogni modo vincere partite non era decisamente nei miei programmi. Dopo un’altra estate di lezioni, a settembre, prima di ricominciare la scuola, ero pronto per il debutto in società: il torneo. Mi iscrissi a una gara fuori provincia e mi unii ad altri miei compagni di circolo per un pomeriggio intero da passare fuori città, visto che il giudice arbitro programmò le nostre partite tutte in una giornata. La faccio breve: vinsi. Incontrai un altro esordiente come me in un campo pessimo e poco illuminato. Iniziammo in tardo pomeriggio per finire in orario di cena. Vinsi al terzo set dopo aver vinto il primo, perso il secondo per il braccetto e vinto il terzo solo rimandando la palla di là; al diavolo il mio gioco e i bei punti: volevo vincere. Al turno dopo incontrai un mio coetaneo, già classificato C4. Riuscii a fare un game, dopo che avevo rotto le corde della mia Head Genesis, finendo per giocare con una Wilson Hammer che mio padre si era fatto portare da un suo collega durante un viaggio negli Usa. Inciso: un’altra pessima racchetta. Ad ogni modo presi una bella lezione e tornai a casa. Il salto di qualità era ancora molto lontano. Non ero minimamente un tennista e neanche colpivo molto bene. Colpivo con forza ma non avevo un’idea di gioco, un colpo caratteristico, una tattica da adottare in campo: ero come una tela di Pollock quando in questo sport per vincere bisogna essere precisi come Mondrian.
Intanto la Head continuava a collezionare le ammaccature. Non prendevo più lezioni, e, non so come, convinsi i miei genitori che servivano racchette nuove, una coppia di racchette questa volta, necessarie per fare i tornei. Fortunatamente, quella volta il senno si manifestò e senza indugiare minimamente scelsi le Head Prestige Pro 600, roba seria. Presi la versione col passacorde verde, sempre perché la usava Thomas Muster. Ancora una volta mi incaponii nel non fare la cosa giusta per migliorare il mio tennis: le acquistai manico L5 e tirai le corde (buone, questa volta, delle Miller) a 28 chili. Una Head rigidissima ancora made in Austria (e non in Cina come oggi) con manico enorme. Praticamente una clava. Ovviamente non cambiò nulla. Ero un perdente, incapace di pensare al di là del singolo punto che si stava giocando. Strategia e tattica erano due sconosciute per me, al pari di vittorie consecutive nei match di torneo. Ogni tanto vincevo qualche partita, ma nella categoria Under 18 altro non ero che un nome da pescare per un facile primo turno, dove il pericolo maggiore era schivare qualche mia pallata da fondo campo. La mia carriera di wannabe-tennista si interruppe di lì a poco e nessuno se ne accorse, tantomeno il tennis.
Le racchette finirono nell’armadio, il calcio agonistico mi assorbiva completamente e giocavo a tennis solamente d’estate, per fare da sparring partner a mio fratello che invece era diventato quello bravo a giocare dei due, un talento puro, nato e cresciuto – purtroppo – in provincia. Non risbocciava mai l’amore per il tennis, anche perché ci mettevo sempre troppo tempo, rispetto alla voglia a disposizione, per imbroccare più di qualche colpo di fila. Gli anni passavano, arrivò il lavoro, gli spostamenti e tutto quello che comporta una maturità che sportivamente era scandita solamente dalle corse sul campo da calcio. Finì anche il tempo del calcio ad un certo punto, in concomitanza con i trent’anni, l’età in cui mi ero stufato di sacrificare le domeniche mattina sui campi polverosi di prima categoria e promozione. Non contemplavo però una vita senza sport e quindi mi chiesi: perché non riprovare con il tennis? Erano passati dieci anni e le mie Head Prestige verdi erano sempre lì. Nel frattempo, Federer dominava il tennis e io neanche me ne ero accorto.
Mio fratello aveva proseguito la sua carriera ed era diventato istruttore. Io tornai in campo e resettai completamente tutto quello che pensavo di sapere. Prese, ovalizzazioni, metodi di insegnamento e apprendimento: tutto era cambiato e quindi toccava iniziare daccapo. La cosa importante però era aver sviluppato le capacità coordinative nell’età giusta, l’adolescenza, perché propedeutiche a tutto quello che si vorrà fare successivamente. E quindi dopo numerosi allenamenti e poche partite i miei movimenti vennero resettati e resi competitivi, con una presa di diritto che non era più full western ma semi-western, e un rovescio che non aveva mai perso la sua naturale fluidità d’esecuzione e che anzi, con qualche accorgimento, migliorò ancora di più. Prima di acquistare racchette, le prime pagate con i miei soldi, dovevo avere certezza che le avrei utilizzate. Dopo un gran torneo giocato con le Prestige 600 verdi sfibrate, decisi che era ora di acquistarne di nuove. All’epoca la Head aveva in commercio l’ultima grande Prestige mai prodotta, la versione Liquidmetal. Comprai ovviamente quella, versione 630 a livello di piatto corde, un po’ più grande della 600. L’acquisto si rivelò perfetto.
Il fatto che il mio primo vero tennis, quello vincente nei tornei – neanche tanto poi – coincise con l’acquisto della racchetta giusta, fu solo una casualità. Di lì in poi non sbaglierò più l’acquisto di una racchetta, anzi. Fui costretto a “toppare” solamente quando, per contratto, ovvero la fornitura gratis di racchette per un anno, fui “costretto” a utilizzare la versione Flexpoint della Prestige, successiva alla Liquidmetal, telaio che si rivelò peggiore ma neanche di molto rispetto al precedente. Dopo qualche anno passato a fare tornei e a diventare istruttore, dopo essermi costruito una classifica decente, cambiai nuovamente racchetta. Provai la nuova versione della Prestige, la Microgel, e quando avevo quasi scelto di comprarla decisi di fare il grande passo: accasarmi con la Wilson. Giocavo la serie C con un club e a tutti i giocatori venne proposto il contratto con il marchio americano. Io non avevo mai considerato le Wilson, racchette usate dai giocatori di talento nella mia ottica, i vari Sampras ed Edberg, fino a Federer. Le Head, in gioventù, erano le racchette dei giocatori tutto corsa e top spin, i vari Muster, Mancini, Perez-Roldan e via dicendo (con le dovute eccezioni: Ivanisevic, Leconte e anche McEnroe che per un periodo provò la mitica Prestige rossa). Ad ogni modo vinsi la mia riluttanza e scelsi la Wilson Blade K-Factor piatto 93, una delle racchette migliori degli ultimi dieci anni, un telaio esigente che voleva essere maneggiato da braccia forti e con i movimenti giusti.
I risultati migliori arrivarono in quel periodo, quando oramai la racchetta era anche il riflesso della mia personalità. Del mio attrezzo mi interessava anche l’estetica, ambito nel quale prediligevo l’eleganza del nero se possibile. Inoltre, già da qualche anno, avevo imparato tutto quello che mi serviva sapere per quanto riguarda le corde da abbinare al telaio. Nella mia borsa da campo, nera, non mancava infatti la matassa grande del monofilamento di turno, ovviamente con il calibro giusto. In quel periodo, mi confortava l’assenza di matassine multicolori sul mercato. Poco importa se qualche anno dopo prenderò l’evoluzione della Wilson Blade, raccogliendo gli scarti del fratello più bravo che mi rifilerà il modello Blade BLX per tornare a Prince, il suo primo amore. Il mio gioco era già diventato indipendente dalla racchetta da qualche anno. Ogni tassello dell’universo che compone un tennista, particelle diverse fra loro posizionate secondo un ordine che determina la nostra univocità sui campi di gioco, era andato nel posto giusto. E io di racchette, tutto sommato, non ne avevo cambiate poi molte.