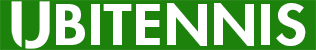Rubriche
I 48 anni di Claudio Pistolesi: “Il mio campo da tennis è il mondo”
Intervista a Claudio Pistolesi in occasione del suo 48esimo compleanno. L’ex n. 71 del mondo e oggi stimato allenatore, nonché rappresentante dei coach nel Players Council dell’Atp, ci parla della sua attività in Florida e dell’arte del coaching. Ricordi del passato e considerazioni sul presente da parte di un tennista che è stato maestro nel coniugare agonismo e insegnamento… senza frontiere

Un dritto fulminante, grinta da vendere, contributo prezioso alla nazionale di Coppa Davis, nonché l’arte del coaching. Stiamo parlando di Claudio Pistolesi che, oggi, 25 agosto, spegne 48 candeline. Stimato e celebre allenatore a livello internazionale, Pistolesi da 5 anni svolge il ruolo di rappresentante dei coach nel Player Council dell’Atp, eletto ben 3 volte dai suoi colleghi, contribuendo così ad aumentare il prestigio dell’Italia nell’ambito del tennis internazionale. Una carriera tennistica intensa quella dell’ex tennista giocatore romano che, dopo gli anni dell’agonismo, continua a dedicarsi al tennis mettendo a disposizione la propria esperienza a favore di campioni affermati e giovani promesse della racchetta.
Campione del mondo junior nel 1985, nel 1987 Claudio, allora n. 150 del mondo, si aggiudica il torneo di Bari, avendo la meglio su Aaron Krickstein e sconfiggendo in finale il connazionale Francesco Cancellotti. Nello stesso anno si issa al n. 71 della classifica Atp, suo best ranking. L’anno seguente, al torneo di Montecarlo – partendo dalle qualificazioni – sconfigge nuovamente Krickstein per realizzare poi il suo miglior exploit in singolare superando l’allora n. 2 del mondo Mats Wilander con lo score di 2-6 7-6 6-2; approda così ai quarti di finale, fermato poi da Martin Jaite. Nel 1989 Pistolesi vanta altri due scalpi illustri, quello dell’allora n. 6 del mondo Kent Carlsson, al torneo di Nizza, e del fuoriclasse argentino Guillermo Vilas, sconfitto al Roland Garros al suo ultimo match nel circuito. In carriera Claudio ha la meglio, solo per citarne alcuni, su tennisti del calibro di Muster, Bruguera e Rosset. Giocatore estremamente solido da fondocampo, dotato di un dritto devastante e fulmineo, Pistolesi ha recato un prezioso contribututo alla nazionale di Coppa Davis, partecipandovi per 6 stagioni consecutive (dal 1986 al 1991) e disputando 4 singolari (2-2). Da sottolineare, soprattutto, il suo prezioso contributo da titolare nel tie del 1991 svoltosi a Bari contro la Danimarca, in cui l’Italia si salva dalla retrocessione in serie B. Claudio Pistolesi si mette inoltre in luce nel 1985 per aver conquistato, insieme a Paolo Canè e Michele Fioroni, la Coppa De Galea, una sorta di Coppa Davis under 21 sconfiggendo in finale gli Stati Uniti.
Nonostante un profondo attaccamento a Roma, sua città natale, e all’Italia, l’azzurro ha sempre dimostrato una certa propensione per gli spostamenti e le esperienze professionali all’estero. Ed è anche in nome di questa costante volontà di allargare i propri orizzonti tennistici che, a partire dal 1996, Claudio decide di dedicarsi al coaching, in Italia e all’estero, conferendo alla propria carriera una dimensione sempre più internazionale. Sono ormai tanti i nomi celebri che si sono affidati alla sua guida, a cominciare dall’ex n. 1 del mondo Monica Seles che, con Claudio come sparring, conquista nel 1996 l’Australian Open, suo ultimo trofeo slam. Nel 1997 il tennista azzurro si ritira definitivamente dalle competizioni. Dopo l’esperienza con la Seles, Claudio allena Ai Sugiyama e Takao Suzuki, trascorrendo così molti anni in Giappone. Ricordiamo, inoltre, il sodalizio con Anna Smashnova, ex n. 15 del mondo (di cui è stato anche il marito) e Davide Sanguinetti. Dal 2006 al 2009, Pistolesi è l’allenatore di Simone Bolelli, portando il talentuoso tennista di Budrio al n. 36 Atp, suo best ranking. Tra il 2010 e il 2011 segue lo svedese Robin Söderling (allora n. 5 del mondo) che, insieme a Claudio, si aggiudica per la prima volta in carriera 3 tornei in una stagione (Brisbane, Rotterdam e Marsiglia). Il coach romano seguirà poi Marius Copil, Daniela Hantuchova e Gioia Barbieri. Stabilitosi in Florida, Claudio segue giovani promesse in un centro di allenamento alla Bolles School di Jacksonville, in una partnerships con il celebre ex campione e coach Brian Gottfried. Nello stesso tempo, ormai da alcuni anni, affianca Alberto Castellani in seno alla GPTCA (Global Professional Tennis Coach Association), certificata dall’Atp, nella preparazione dei nuovi aspiranti allenatori.
Insomma, professionista eclettico e appassionato, Claudio Pistolesi è, insieme ad Alberto Castellani e Riccardo Piatti, il coach azzurro che più si è messo in luce in ambito internazionale. Ma, ora, spazio alle sue parole… e tanti auguri!
Come si è svolto il passaggio dalla carriera di tennista professionista a quella di allenatore?
Non c’è un momento preciso in cui ho deciso di diventare un coach, perché stavo ancora giocando. All’epoca pensavo di giocare ancora qualche anno; ma, poi, gli eventi che mi hanno portato ad essere lo sparring di Monica Seles e il coach di Takao Suzuki, hanno fatto sì che anticipassi il mio ritiro di un paio d’anni. Inoltre, avendo subìto un’operazione all’ernia del disco nel 1994, a 27 anni, avevo perso un po’ in velocità e in spinta che, per me, erano fondamentali, condizioni che costituiscono quella che oggi viene definita la physicality. Ci sono voluti 9 mesi per riprendermi, ora sarebbe più facile ma all’epoca la scienza era più indietro e sapevo che difficilmente avrei fatto meglio di quanto avessi realizzato precedentemente e, quindi, quando ho avuto la possibilità di lavorare prima come sparring e poi come coach, l’ho presa al volo.
Avrei voluto riprendere gli studi. Infatti a 18 anni avevo provato a fare l’università ed avevo dato anche un esame nella facoltà di Scienze politiche. Ma era davvero molto difficile conciliare le due cose perché all’epoca ero già n. 130 Atp e, a causa dello scollamento totale e della disorganizzazione che c’era – e c’è tutt’oggi in Italia – tra il mondo accademico e il mondo sportivo, era molto complicato portare avanti gli studi universitari. Quindi l’idea era di ricominciare a studiare oppure di fare il maestro e il coach. Negli anni ’90 non c’era tanto la figura del coach come invece c’è adesso. Allora stava cominciando a svilupparsi ed ero ancora uno dei pionieri di questo lavoro, seguendo soprattutto Alberto Castellani che è stato il mio coach ed è stato uno dei primi a fare questo, seguìto a ruota da Riccardo Piatti. E infatti, ancora oggi veniamo considerati insieme – Pistolesi Castellani e Piatti – i pionieri di questo mestiere in Italia. Poi l’hanno fatto in tanti ma non mi sembra che nessuno ci abbia mai raggiunto in quanto a risultati. Speriamo che succederà. Oggi sono rappresentante dei coach, eletto dai miei colleghi, nel Players Council Atp. Sono stato eletto per tre volte, quindi svolgo questo ruolo da 5 anni; il prossimo anno, a Wimbledon, ci sarà di nuovo l’elezione, quindi avrò fatto in tutto sei anni. Per 4 anni il mio presidente è stato Roger Federer, cosa di cui vado molto fiero.
Un pensiero che mi dava fastidio era andare presso un circolo. Vedevo infatti che molti dei miei predecessori, dopo aver smesso di giocare, facevano la Scuola maestri. Io l’ho fatto un po’ con Roberto Lombardi, che mi manca molto. Feci un corso di tecnico nazionale Fit e, siccome era stata cambiata la regola per la quale chi era stato in Coppa Davis poteva diventare automaticamente Maestro Fit, ho dovuto seguire questa preparazione. Ma mi ha fatto piacere farlo poiché c’era Lombardi. Lo feci perché me lo aveva chiesto Roberto che lo fece insieme a me, con molta umiltà. Ottenni dunque la targa di tecnico nazionale Fit. Nonostante questo, pensavo sempre che la mia esperienza da professionista fosse internazionale quindi il mio campo era il mondo, non l’Italia. Non ero ancora sicuro di voler vivere in Italia, ero disponibile a viaggiare, non ero sposato, avevo 33 anni. Attraverso il tennis, la mia vita si è basata sugli spostamenti e i viaggi; infatti, non sono mai stato fermo più di due anni nello stesso luogo, mi spostavo spesso. Ed ecco che c’è stata la svolta in Giappone dove mi sono fermato a lungo poiché allenavo Takao Suzuki, n. 1 del suo paese, e Ai Sujiyama, che era la n. 1 tra le donne. Infatti mi chiamavano “n. 1” perché allenavo i primi due tennisti del paese, cosa alquanto eccezionale. E, per questo, infatti, sono stato anche capitano della squadra Giapponese nella Hopman Cup a Perth. Mi sono quindi orientato verso un’esperienza internazionale e questo ha segnato tutto il prosieguo della mia vita fino ad oggi. Sono trascorsi quasi 20 anni di coaching, poiché era il 1996 quando ho cominciato a lavorare con Monica Seles e Suzuki. Questo però non mi ha impedito di allenare anche giocatori italiani, come Davide Sanguinetti e Simone Bolelli; inoltre, pochi sanno che ho allenato per quasi un anno anche Paolo Lorenzi, nel 2004, e devo dire che furono mesi molto belli. Tra le donne, ho seguito Mara Santangelo e, l’anno scorso, Gioia Barbieri.
Se oggi diventassi nuovamente il coach di un giocatore o giocatrice italiani, come imposteresti il tuo lavoro? Tenendo conto anche soprattutto del lavoro svolto con Simone Bolelli – che con te ha raggiunto il best ranking – e considerando la tua dimensione di allenatore internazionale…
Sì, è vero, il n. 36 raggiunto da Simone resta tutt’oggi di gran lunga il suo best ranking. Ma un giocatore come lui vale più del n. 36, negli ultimi 7 anni poteva arrivare nei primi 15 poiché non è assolutamente inferiore a Seppi e Fognini, ma è ancora in tempo a farlo. Con un tennista italiano farei esattamente quello che faccio con gli stranieri, io non guardo al passaporto. Ho bisogno di avere la base in America perché ora vivo qui negli Stati Uniti. Come avevo fatto con Gioia Barbieri che, all’inizio aveva accettato ma poi ha cambiato idea, spiegandomi le sue ragioni in una bellissima mail. Mi ha spiegato che non se la sentiva di stabilire la sua base in America poiché è molto attaccata alla sua famiglia e all’Italia, cosa assolutamente legittima e la capisco perfettamente.
Certo, da una parte, per un giovane, il fatto di stabilirsi in America, sarebbe più difficile perché significherebbe uscire dalla cosiddetta comfort zone: capisco che si stia meglio a casa e nel proprio ambiente. Però, secondo me, un tennista deve essere abituato a stare fuori dalla comfort zone, perché si tratta di viaggiare tantissimo, di andare verso una realtà tecnica e di crescita, di parlare le altre lingue e di confrontarsi con giocatori stranieri. Penso che un tennista debba poter trascorrere una grossa parte dell’anno fuori casa. Lo ha dimostratato, ad esempio, Flavia Pennetta che si allena a Barcellona da molto tempo e ormai ci vive. Così come ha fatto la Errani; e anche Fognini si è stabilito a Barcellona ormai da tantissimo tempo, ma ci sono tanti esempi. Non per scarso patriottismo ma, poiché la natura del tennis è questa, cercherei, come prima cosa, di far mantenere ad un giovane giocatore una dimensione internazionale, restando quindi legati all’Atp o alla Wta come istituzioni, perché il diritto a giocare lo dà la classifica e non altre cose. Per quanto riguarda il programma specifico, dipende a seconda dei vari casi: c’è chi lavora particolarmente sulla preparazione fisica, sulla programmazione dei tornei; è importante capire su quale superficie ci si esprima meglio. Poi ogni ragazzo o ragazza è diverso dagli altri e bisognerebbe creare un programma “su misura”. Però di certo darei un’impronta internazionale, così come la mia vita è internazionale; la base sarebbe in America. Chiederei di avere un rapporto professionale con le istituzionali italiane, soprattutto quando si tratta di Coppa Davis o Fed Cup. Per professionale intendo che si parli da pari a pari, che ci si metta d’accordo se inserire o meno nel programma la Coppa Davis o la Fed Cup a seconda del programma di lavoro scelto.
Saresti disposto un giorno a diventare il capitano della nazionale di Coppa Davis o Federation Cup ?
Se un giorno ci fossero le condizioni, certamente mi farebbe molto piacere diventare capitano di Coppa Davis o di Fed Cup, anche perché ho partecipato per 6 anni alla Davis come giocatore. Non solo. Nel 1985, insieme a Paolo Cané e Michele Fioroni, ho vinto la Coppa De Galea, una specie di Coppa Davis under 21, sconfiggendo in finale la squadra statunitense composta da Reneberg, Luke Jensen e Pierce, che ha fatto quarti a Wimbledon. E non è stato facile perché le squadre erano forti. Il team cecoslovacco, ad esempio, era composto da Novacek, Korda e Vajda. Per la Francia invece giocavano Benhabiles, Fleurian e Champion.
Sono stato molto contento, inoltre, di essere il capitano della squadra italiana dei Giochi del Mediterraneo e della Coppa Europa nel 2005, occasioni in cui, tra l’altro, ho approfondito la conoscenza di Bolelli; questa esperienza ci ha aiutato entrambi a conoscerci meglio e l’anno seguente, infatti, quando Simone cercava un coach, ha chiamato me e sono diventato il suo allenatore. All’epoca era n. 250, non era conosciuto e poi è diventato n. 36.
Se avessi la possibilità di diventare il capitano di Coppa Davis o di Fed Cup, come imposteresti il tuo lavoro e quale sarebbe il tuo marchio di fabbrica?
Inserirei gli appuntamenti della nazionale nel programma dei ragazzi e non viceversa. Punterei alla massima trasparenza e apertura verso i giocatori e i loro coach, abolendo qualsiasi punizione diretta o indiretta se un giocatore decide di non parteciparvi, perché se non vogliono venire è inutile forzarli. Cercherei di parlare con i loro coach, con i ragazzi e i loro manager per fare gioco di squadra, per realizzare un progetto insieme, su cui ci si possa mettere d’accordo insieme. La cosa che mi piacerebbe di più sarebbe che i ragazzi che eventualmente convocherei venissero perché mossi dal piacere di giocare in nazionale, contenti di partecipare. Il mio messaggio sarebbe che noi siamo qui, siamo a loro disposizione e che, se partecipano, ovviamente siamo molto contenti. Ma se non vengono, non succede assolutamente nulla, per noi rappresenterebbero comunque sempre l’Italia e avrebbero sempre il nostro tifo. Se poi i ragazzi riescono anche ad organizzarsi per fare insieme il doppio nei tornei come stanno facendo ora Bolelli e Fognini, tanto di guadagnato, è una cosa molto positiva. Ecco, questo sarebbe il mio atteggiamento: tranquillo, aperto, propositivo, di supporto e, soprattutto, non invadente. Ovviamente tutto questo vale anche per la squadra femminile.
In che cosa consiste, nello specifico, il tuo ruolo di coach oggi nella realtà del tennis in Florida?
Io sono in partnerships come coach con la JTCC (Junior Tennis Champions Center) che ha una serie di scuole, la cui sede principale, College Park, si trova a Washington. È uno dei centri migliori che ha fatto emergere, ad esempio, giovani talenti come Francis Tiafoe e Denis Kudla e che ha tantissimi ragazzi molto forti dai 13 ai 18 anni. Si tratta di una vera e propria fucina di talenti. Però ha anche una scuola all’interno della Bolles School, qui in Florida, a Jacksonville, un centro d’allenamento diretto da Brian Gottfried con il quale sono in partneships. Quando i ragazzi hanno bisogno del bel tempo per giocare outdoor e devono spostarsi in Florida, vengono ad allenarsi qui da noi e noi, a livello indoor, andiamo a Washington, il centro si trova a circa mezz’ora dalla Casa Bianca. Il liceo di Bolles è molto famoso negli Stati Uniti a livello accademico e culturale (qui ha studiato il primo americano che è andato nello spazio) e ci sono stati molti premi Nobel, tant’è che chi esce da questo liceo, ha la possibilità di entrare a College prestigiosissimi come Harvard o Yale. Ma, anche per quanto riguarda lo sport, grazie all’eccezionale sensibilità e cultura sportive negli Stati Uniti, le strutture sportive sono fenomenali e molto belle. Qui c’è la pista d’atletica con il campo da calcio e da football americano; abbiamo 8 campi da tennis, il campo da basket coperto, la mensa e gli alloggi per i ragazzi. C’è veramente tutto. Si ha la possibilità di imparare l’inglese e gli studenti stranieri, durante le settimane qui da noi, possono imparare come funziona il College, l’Admission. L’accesso al College infatti non è una cosa così automatica, non basta solo giocare bene a tennis. Bisogna studiare e ottenere la Maturità con voti abbastanza alti per essere ammessi. Andiamo anche direttamente in visita ai College per chi pensa al College come un’opportunità futura. Oppure c’è semplicemente la possibilità di allenarsi qui. Ci sono tantissimi tornei in Florida. Quindi, ci sono davvero tante opportunità perché c’è la visita ai College, si possono disputare i tornei e ci si può allenare con me che, come ho detto, sono in partnerships con Brian Gottfried, che è l’head coach di questa scuola. Brian è una delle persone più amate in assoluto nel mondo del tennis; non è stato solo un grande campione (n. 3 in singolare e n. 2 in doppio) e un grande coach (ha infatti allenato Michael Chang, MaliVai Washington, Todd Martin), svolgendo un grande lavoro come coach per l’Atp allenando tantissimi ragazzi. Ma è, soprattutto, una persona eccezionale, gli vogliono tutti bene. Pochi lo sanno, ma lui è stato il primo allievo di Nick Bollettieri e gli è quindi molto affezionato.
Si respira tennis in Florida. Come dicevo, ci sono tantissimi tornei, non solo il Masters 1000 di Miami. Qui siamo a nord della Florida, a Jacksonville, quindi si va facilmente a Cherleston, dove c’è un Family Circus femminile; poi ci sono tanti tornei junior, tanti da 10.000 e 15.000 $ e numerosi Challenger. Quindi, chi viene qui, ha una base operativa eccezionale e anche molto economica perché qui costa tutto poco ed è anche tutto vicino; ci si può recare ai tornei anche con la macchina spendendo poco poiché la benzina costa cifre molto modiche. Inoltre, ci sono molti campi pubblici e, molto spesso, in questi campi, si possono fare delle sessioni di allenamento gratuitamente o, al massimo, pagando circa 2 dollari a sessione ma, spesso, ci si può allenare diverse ore liberamente. La Contea infatti deve provvedere all’attività pubblica dei cittadini e, quindi, deve mettere a loro disposizione le strutture. Insieme ai campi da tennis c’è il campo da basket, da baseball, da calcio, ci sono le piscine pubbliche. Insomma, qui ci sono davvero tanti vantaggi e ci si può concentrare sul tennis. Per esempio, non ci sono i circoli. Il concetto di Circolo Tennis, con cui bisogna essere tesserati per giocare, qui non esiste. Per esempio, se io volessi partecipare a un torneo Over 45, potrei farlo semplicemente come tesserato della Federazione americana, pagando una semplice quota d’iscrizione. Non devo appartenere a un circolo che a sua volta deve essere affiliato alla Federazione. Qui ci sono poi i Country Club, molto spesso associati al golf e molto esclusivi, ma costituiscono una realtà particolare. Altrimenti ci sono moltissimi “Park”, i celebri campi pubblici appunto. E poi ci sono le strutture delle scuole pubbliche, delle high school e dei college pubblici, in cui chiunque può andare a giocare. Insomma, qui lo sport è di tutti e il tennis è di tutti.
Qual è per te la qualità essenziale che deve possedere un coach?
Per me è molto molto importante il ruolo del coach inteso come educatore e come insegnante. In molti paesi come gli Stati Uniti, l’Australia, la Germania e la Francia, la figura dell’insegnante viene molto valorizzata, cosa che accade sempre meno in Italia. Ricordo perfino che in Giappone l’unica categoria esentata dall’inchinarsi davani all’Imperatore è quella degli insegnanti. In Italia invece la situazione degli insegnanti sta vivendo un vero e proprio dramma che si ripercuote anche sul tennis perché l’importanza degli insegnanti, e quindi dei coach, oggi viene sminuita. Infatti, il maestro di tennis del circolo deve seguire gli ordini che vengono dalla dirigenza. La condizione necessaria per fare il lavoro di insegnante, coach, maestro, allenatore – qualunque sia la denominazione – è l’autonomia, che deve essere assolutamente totale. Autonomia con cui si lavora, per poi prendersi ovviamente le responsabilità di quello che si fa; ma è la condizione essenziale e imprescindibile per svolgere questo mestiere. E, purtroppo, in Italia non è così, sia nelle scuole che in ambito sportivo.
Tre giorni fa era il compleanno di un grande campione, Mats Wilander, che tu hai battuto nel 1988 al torneo di Montecarlo…
Credo che Mats, guarda caso, sia il Presidente onorario del centro di allenamento di Washington perché c’è la sua foto. Infatti, per modestia, ho smesso di dire che l’ho battuto (ride). Wilander è una persona eccezionale. Insomma, è capitato che io facessi la partita della vita contro di lui, a Montecarlo. Mi piace molto tutto quello che sta facendo, mi piacciono i suoi commenti, la sua rubrica “Game, set & Mats”, molto carina. È un personaggio molto positivo, simpatico, molto umile, sorride sempre. È uno che andava in “guerra” sempre con la forchetta di plastica, non aveva un’arma particolare che facesse male agli avversari ma, alla fine, riusciva comunque a vincere. Aveva un grande senso tattico e la capacità di fare le scelte giuste; è da prendere come esempio. Certo, la vittoria con lui è quella che mi è rimasta più addosso e che tutti ricordano e, anche se ce ne sono state altre con altri giocatori, è certamente quella più importante per me.
Se diventassi commentatore tecnico e avessi anche tu una rubrica televisiva, come svolgeresti questo ruolo? Quale sarebbe la tua caratteristica?
Innanzitutto mando un abbraccio affettuoso a Lucia Blini e a Giampaolo Gherarducci, con cui su Italia 1, per ben 5 anni, ho commentato le semifinali e finali maschili e femminili del Foro Italico in diretta, in diretta, in chiaro, quindi abbiamo fatto il commento davanti a milioni di persone. Credo che, per la famosa finale tra Federer e Nadal del 2006, abbiamo ottenuto circa 3,5 milioni di ascolti. Quindi è un’esperienza che ho già vissuto e la mia caratteristica era e sarebbe quella di far “entrare” i telespettatori in campo, nel senso che spiegherei loro il self talking del giocatore, che è qualcosa di molto interessante che penso di poter interpretare e leggere molto bene. Vista anche la mia esperienza di coach, cercherei di “entrare” nella testa dei due antagonisti, sottolineando i punti importanti, portando l’attenzione su cosa potrebbe pensare il tennista prima di giocare il punto e sulla sua tattica; cercherei di capire e spiegare cosa pensa durante il gioco e al cambio campo. Insomma, tenterei di “portare in campo” le persone che assistono alla partita, mi piacerebbe dar loro l’impressione di disputare loro stessi il match e coinvolgerli attraverso la lettura del self talking dei giocatori e la spiegazione tecnica e tattica di quello che stanno vedendo. Ad esempio, è importantissimo, tra le altre cose, far notare sempre la posizione che un giocatore adotta in campo, dove si piazza con i piedi. Credo di aver svolto molto bene quel lavoro e ricevetti molti complimenti anche da giornalisti illustri. Mi ero anche imposto di dare una regolata al mio forte accento romano, tant’è che i miei parenti quasi non mi riconoscevano in televisione perché cercavo di parlare con un accento più “milanese”, per scandire meglio le parole. Credo di essermi organizzato molto bene ed è un peccato che la cosa sia finita. Lucia Blini e Giampaolo Gherarducci – con cui commentai anche la finale Coria-Nadal – sono due persone accezionali che saluto e a cui mando un abbraccio carissimo.