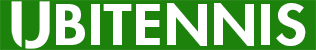Libreria
La Piccola Biblioteca di Ubitennis. Vitamina. Sandro Veronesi (seconda parte)
Speciale “venerdì letterari” di Ubitennis. Per gentile concessione pubblichiamo integralmente “Vitamina” (oggi la seconda parte, venerdì scorso la prima) di Sandro Veronesi

Finisce un racconto e comincia Smash, un libro in cui quindici autori italiani contemporanei si confrontano col tennis. Oggi Sandro Veronesi, premio Strega e Campiello, si congeda da Ubitennis con il finale di Vitamina: Tennis, provincia e doping artigianale. (PPZ)
Qui potete trovare la prima parte
Veronesi S., Vitamina, in A.A.V.V., Smash. 15 racconti di tennis, La nave di Teseo, 2016.
“Pronto, mamma?”
“Ciao, nì. Com’è andata?”
“Ho passato i primi due turni.”
“Bravo!”
“Ho battuto la testa di serie numero 8.”
“Bravo!”
“Un capolavoro tattico, potremmo definirlo.”
“Bravo!”
“La racchetta l’ha spaccata lui. Diglielo al babbo.”
“Certo che glielo dico.”
“Domani gioco con un gruppo B. È alla mia portata. Posso arrivare nei quarti.”
“Bravo.”
“Diglielo al babbo.”
“Certo che glielo dico.”
Per la terza notte consecutiva non dormii. Di nuovo quella gran sete, anche se a cena, da bravo atleta, mi ero fatto fare un riso in bianco. E poi l’esaltazione di essere finalmente diventato forte, come avevo sognato per tanto tempo – perché ormai non c’erano più dubbi, avevo fatto il salto di qualità. Ormai avevo conquistato i punti per diventare gruppo B, e se avessi continuato a lavorare sodo l’anno successivo sarei anche potuto diventare gruppo A, e poi approdare alla categoria juniores da classificato. Avrei giocato in coppa Facchinetti, il mio nome avrebbe cominciato a preoccupare gli avversari. “Oh no, mi è toccato Veronesi…”
L’indomani arrivai al campo con un bell’anticipo per fare un buon riscaldamento, ma ero un po’ stanchino. Fin dai palleggi mi accorsi che qualcosa non andava. Avevo le gambe molli, la vista offuscata, la bocca secca, sudavo come un malato. La situazione si era rovesciata rispetto ai giorni precedenti, all’improvviso il campo dell’avversario s’era rimpicciolito e quello immenso era il mio. Il mio avversario aveva gli occhialini di metallo, e quelli con gli occhialini di metallo mi innervosivano. Era un gruppo B di Bologna, giocava in casa e di sicuro avrebbe goduto di un arbitraggio scandalosamente favorevole. In più c’era un gran vento, e anche il vento m’innervosiva, perché danneggiava i giocatori d’attacco come me. In pochi minuti tutta quella forza che avevo assaporato, quella sicurezza, quella serenità, si erano dissolte, e non riuscivo a tirare dentro due colpi di fila.
Onestamente, le stazioni di quella Via Crucis le ho dimenticate, ed è meglio così. Dirò solo che per tutto il primo set (0-6) mi sforzai di rimanere tranquillo, ma in cuor mio sapevo che nessun corretto comportamento in campo avrebbe potuto sottrarmi a ciò che stava succedendo, perché la mia nevrastenia non era la causa del giocar male, ne era solo l’effetto: la causa era più profonda, più nera e imperscrutabile, aveva a che fare col destino. Il mio ricordo torna a farsi nitido nel momento dell’umiliazione suprema, con la mia Dunlop in terra spaccata in due, il piatto con le corde da una parte, il manico dall’altra, l’arbitro che mi dà il terzo warning, l’espulsione, il pubblico che mi deride, l’avversario che gongola tranquillo in fondo al suo minuscolo rettangolo di gioco e la calda sensazione di pace di chi si ricongiunge al proprio destino. Ero tornato a casa.
Poi, la scena più terribile di tutte, quella che non sarà mai possibile cancellare: mentre esco dal campo mandando tutti affanculo, uno sguardo terreo che mi accompagna – l’unico, in quella folla ostile, che tradisca un’ombra di compassione: mio padre. Aveva preso un giorno di ferie per venire a vedermi, aveva fatto cento chilometri di autostrada.
Passano gli anni. Ne passano cinque, ne passano dieci, ne passano venti e poi venticinque, fino ad arrivare a una limpi da mattina di maggio alla fine del secolo. Nel frattempo tutti i destini sembrano essersi compiuti: io ho lasciato la mia città e mi sono trasferito a Roma, sono diventato uno scrittore e un padre di famiglia – un uomo piuttosto diverso da quello che pensavo di diventare quando avevo quattordici anni. Ho smesso del tutto di giocare, eccezion fatta per un periodo nel quale ho frequentato il campo dell’Hotel Holiday Inn sull’Aurelia nuova insieme a un mio caro amico e altri amici suoi, per gio care dei doppi assatanati e senza bellezza. Anche lì, per inciso, il mio tennis si distingueva per la sua fallosità, tanto da farmi soprannominare “Boom Boom Mancini”, in riferimento non ad Alberto César Mancini, il tennista argentino che aveva vinto gli Internazionali d’Italia ed era arrivato fino al numero 8 del mondo, bensì a Ray, il pugile americano, soprannominato per l’appunto “Boom Boom” per la potenza delle sue bordate: e per un tennista, non c’è bisogno di dirlo, essere paragonato a un pugile non è un gran complimento. Poi il mio amico si è ammalato gravemente e quei doppi sull’Aurelia non si sono fatti più. Poi è guarito, e lui ha ricominciato, ma io no, non l’ho fatto, ho smesso del tutto di giocare, ed è stata una liberazione.
Luca Ciardi ha smesso molto presto di fare tornei ad alto livello ma non ha affatto chiuso col tennis: continua a frequentare il circolo per divertimento e a giocare (e vincere) i campionati dei dottori commercialisti. Gianluca Rinaldini, invece, dopo quella finale persa con lui ai campionati italiani under 15 è diventato un fortissimo juniores e poi è passato professionista, arrivando fino al numero 123 del ranking mondiale e giocando al Roland Garros e a Wimbledon, dove a eliminarlo è stata gente come Složil o Tim Gullikson – ma all’età di ventisei anni un incidente d’auto lo ha inchiodato sulla carrozzina a rotelle con una paralisi alle gambe. “Ever since”, dice oggi la voce a lui dedicata su Wikipedia – stranamente solo in inglese, perché la voce in italiano non c’è.
Ma torniamo a quella mattina di maggio, quando Wikipedia ancora non esisteva. È domenica; fa già caldo; sono tornato a Prato per il weekend con la mia famigliola, come spesso faccio, per trovare i miei genitori. Non so bene perché mi è venuta voglia di andare al circolo, dopo tanto tempo, a salutare i vecchi amici, ma quando arrivo trovo tutti in religiosa concentrazione sul campo centrale. È in corso un incontro di Coppa Italia e si sta disputando il match decisivo tra il nostro numero uno, un cinquantenne ex seconda categoria scivolato strategicamente tra i non classificati, e il numero uno avversario, un giovanissimo arrotino dal fisico possente, destinato l’anno prossimo a una classifica di un certo riguardo. Il nostro ha vinto il primo set e sta lottando punto per punto nel secondo. Mi sistemo in tribuna vicino ai vecchi amici che però mi salutano appena, tanto sono presi dalla partita. Luca Ciardi non c’è, ma c’è il dottorino, ormai trionfalmente vecchio. Ai cambi di campo si discute.
SEGUE A PAGINA 2