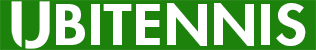Libreria
La Piccola Biblioteca di Ubitennis. Rod Laver: God Save the Green
La questione GOAT, il tennis dei gesti bianchi. La transizione del tennis Open o, semplicemente, con uno dei più grandi di sempre. Ecco recensite le memorie di Rod Laver, Mr. Grande Slam. Con prefazione di Roger Federer

Laver R. (con Writer L), Le mie memorie – Trad. Montrasio E, prefazione Federer R., Edizioni Mare Verticale, 2015, pagg. 421
Rod Laver si ritirò dal tennis nell’aprile del 1979 (anche se continuò per parecchi anni a giocare nel circuito senior). Io, al tempo, avevo 14 anni e ho ricordi sbiaditi di Rocket, come lo chiamavano allora. Ricordo vagamente qualche apparizione in TV, ma lo spazio dedicato al tennis dai canali nazionali era, in quegli anni in bianco e nero, riservato ai giovani campioni emergenti, Connors, Borg e McEnroe su tutti. Laver aveva fatto il suo tempo. Molti anni dopo cercai su YouTube i filmati dei match più famosi dell’unico tennista della storia del tennis capace di aggiudicarsi per due volte, nel 1962 da dilettante e nel 1969 da professionista, tutti i 4 titoli del Grande Slam nello stesso anno. Guardando quei filmati capii in modo inequivocabile qualcosa che già sapevo ma su cui non avevo mai soffermato veramente l’attenzione, ovvero che il tennis ai tempi di Laver era sport infinitamente diverso da quello odierno e non solo per tipo di gioco, tecnica, materiali, metodi di allenamento, ma anche per l’ambiente (sociale, culturale, economico) in cui quel tennis era immerso. Di questo ci si può rendere conto anche leggendo l’autobiografia di questo immenso campione. Anzi, è proprio Rod a sottolineare in molte parti del libro l’enorme divario che separa il tennis dell’epoca dei ‘Fab Four’ con il tennis dell’epoca sua.
Laver organizza il racconto in modo cronologico ed equilibrato. La sua vita, agonistica e non, viene suddivisa in quattro parti ideali (infanzia e primi approcci al tennis; anni da dilettante; anni da professionista; dopo il ritiro) e a ognuna Laver dedica molto spazio, ritenendo, giustamente, che sia ciò che ha preceduto la sua attività agonistica, sia ciò che ha fatto dopo il ritiro abbiano avuto un’importanza centrale nella sua vita. Una vita, lo scoprirà il lettore fin dalle prime pagine, interamente ed esclusivamente consacrata al tennis. Giusto per fugare ogni dubbio in tal senso, a pagina 47 Rod scrive: “A quattordici anni la decisione fu molto semplice, dopo che il preside mi annunciò che avrei dovuto ripetere il secondo anno per tutte le lezioni che avevo perso a causa della malattia. Chiusi i libri una volta per tutte e mi misi in cerca di un lavoro, con la speranza di poterlo adattare alle esigenze del tennis. Ero certo che il tennis sarebbe stato la mia vita (…) Mamma e papà si dissero assolutamente d’accordo”.
Il piccolo Rod, nato a Rockhampton il 9 agosto 1938 nello stato di Queensland, nord-est dell’Australia, respirò e mangiò tennis fin dall’infanzia. Leggiamo infatti che: “Vivevamo a Langdale, un ranch di 9.300 ettari per l’allevamento dei bovini, a un’ora di macchina dalla cittadina di Marlborough, situata a 96 km a nord di Rockhampton. Mio padre, cresciuto a Gippsland nello stato di Victoria, era cresciuto in una famiglia di tredici figli, otto dei quali erano maschi, e pertanto i fratelli Laver erano sempre riusciti a comporre quasi un’intera squadra di football o di cricket e quattro coppie per le gare di doppio nei tornei di tennis locali” (pag. 22). Il tennis, dunque, faceva parte del DNA della famiglia Laver ed era inevitabile che in mezzo ai canguri, alle strade bianche, a quegli immensi spazi disabitati senza televisione, con la sola radio che permetteva di rimanere collegati al resto del mondo, Rod iniziasse a colpire le prime palline da tennis su un campo fatto in casa, ricavato niente meno che dalla terra dei formicai: “Fin da quando avevo cominciato a muovere i primi passi, lo sport preferito di papà era il tennis e lui aveva deciso che sarebbe diventato il nostro sport. A quello scopo i miei fratelli trasportavano grandi quantità di terra dei formicai (…) e di terreno argilloso, ne ricoprivano il cortile, recingevano il perimetro con un filo di ferro, innalzavano una rete, tracciavano delle linee… ed ecco il nostro campo da tennis” (pag. 24).
I capitoli più interessanti del libro sono, a mio giudizio, il sette (Voglio sognare), l’otto (Il mio primo Grande Slam), il nove (Anni da nomade), il dieci (Se è martedì… allora dev’essere Khartoum) e il dodici (La rivoluzione degli Open). Questi capitoli coprono la parte centrale del libro, da pag. 109 a pag. 249, e vanno dal 1962, anno del primo Grande Slam di Laver, al 1968, anno in cui inizia l’era Open nel tennis. All’interno di questo arco temporale assistiamo a numerosi cambiamenti sia nella parabola tennistica di Rod, sia nel mondo del tennis, che proprio in quel decennio visse un periodo particolarmente vivace e ricco di stimoli. Era un mondo in ebollizione. Vale la pena ripercorrere brevemente quel decennio così come ce lo propone Rocket. Scopriremo molto non solo sul tennista Laver, ma anche sull’uomo Laver.
Nel 1962 Rod è un giovane tennista di 24 anni già affermato nel circuito dilettantistico (quello, per capirci, che gestiva i tornei del Grande Slam, della Coppa Davis e tutti i principali tornei del mondo). Nel ‘60 aveva vinto l’Australian Open e nel ’61 Wimbledon. Rod non era più una promessa, era una realtà. All’interno del racconto di questo anno straordinario, accanto ai resoconti delle partite che lo portarono alla gloria perenne, le parti più interessanti sono quelle in cui Laver analizza il proprio gioco e parla del suo modo di interpretare il tennis in quegli anni. Sul proprio gioco: “Possedevo tutta una gamma di servizi, spesso a uscire, che avevo imparato a non far prevedere ai miei avversari. Nel servizio avevo deciso di non sacrificare la precisione, a vantaggio di velocità e potenza. Avevo capito che, se imprimevo un po’ di top spin o di slice alla palla, avrei sbagliato ben poche prime e non avrei dovuto contare su una debole seconda di servizio. Possedevo un tocco vellutato nelle mie volée smorzate e con il rovescio ero in grado di giocare sia con un aggressivo top spin, sia con un più controllato slice, a seconda della situazione. (…) Giocavo sia di diritto, sia di rovescio utilizzando molto il polso e imprimendo così alla palla un buon top spin che mi consentiva anche di realizzare dei buoni lob offensivi. La tecnica dei miei colpi si fondava su rapide rotazioni di spalla, un preciso swing e un timing accurato. (…) Sotto rete, giocavo delle volée molto potenti e soprattutto quella di rovescio era particolarmente efficace (…) affrontavo bene anche le palle basse dei miei avversari e adoravo schiacciare tutte quelle che mi arrivavano dall’alto” (pag. 111).
Sulla posizione in campo: “Avevo anche migliorato la mia posizione in campo. Fino a quel momento, gli avversari con una buona risposta mi avevano creato grossi problemi e, pertanto, avevo lavorato molto per scendere a rete e giocare al volo, invece di farmi cogliere impreparato nella cosiddetta ‘terra di nessuno’. Essere più veloce e in miglior forma rispetto all’avversario mi era di grande aiuto” (pag. 112). Sull’atteggiamento mentale: “In campo ero imperturbabile, proprio come lo ero mentalmente e nella mia gestualità. Se un colpo non era dei migliori, non ci rimuginavo sopra: faceva già parte del passato. Non puoi riprenderti un punto perso, anche se continui a pensarci con ossessione. (…) Di rado instauravo un contatto visivo prolungato con il mio avversario, né esternavo alcuna reazione ai suoi comportamenti. In campo rimanevo distaccato e privo di emozioni. (…) Ciò che intendevo fare con il mio rifiuto di stabilire un contatto con il mio rivale era evitare che mi coinvolgesse mentalmente, interrompendo, in tal modo, la mia concentrazione” (pagg. 113-114). Sul tennista a 360 gradi: “L’immagine e lo stile di un giocatore che si presenta in campo dipendono esclusivamente da lui. Per quanto mi riguarda, l’educazione di mamma e papà e la successiva influenza di Charlie e Hop (Charlie Hollis e Harry Hopman i suoi primi allenatori. Hopman, tra l’altro, fu figura fondamentale per lo sviluppo del tennis in Australia, ndA) avevano fatto sì che cercassi sempre di apparire al meglio. (…) Durante un tour di solito mi portavo cinque magliette, due paia di pantaloncini, due di calzini e due di scarpe, che mantenevo di un bianco candido, stringhe comprese. Facevo il bucato di corsa, in qualunque lavanderia pubblica trovassi sul mio cammino ma, più spesso, nel lavandino del bagno della mia stanza d’albergo” (pagg. 114-115).
Alla fine di quello straordinario 1962 Laver passa al professionismo. Oggi non ci rendiamo conto di come fosse allora il tennis, diviso tra dilettanti e professionisti. La separazione era netta, impossibile qualsiasi contatto, o si stava di qua o si stava di là, non era permesso a un professionista partecipare a un torneo riservato ai dilettanti. L’ambiente dei dilettanti (e soprattutto i suoi dirigenti) si considerava, ed effettivamente era, il depositario della gloriosa storia del tennis nella sua matrice tradizionale. Controllava moltissimi tornei fra cui spiccavano, come si è detto, gli Slam e la Coppa Davis. Dalle parole di Laver scopriamo che i tennisti che passavano al professionismo erano considerati alla stregua di traditori, di coloro che avevano rinnegato i valori fondanti della nobile arte della racchetta. Il professionismo, comunque, era praticato da molto tempo prima del “salto” di Laver. Esisteva dalla fine degli anni Venti e grandi nomi come Suzanne Lenglen e Big Bill Tilden, al culmine delle loro carriere, diventarono professionisti. Con sincerità, Laver dice di essere passato al professionismo per guadagnare. Detto così non fa una gran bella impressione ma se leggiamo il racconto di Rod capiamo che aveva motivi più che validi. Il tennis dilettantistico non permetteva, nemmeno ad altissimi livelli, di potersi mantenere con il tennis in modo dignitoso. Malgrado molti dei più forti tennisti dilettanti ricevessero compensi sotto forma di rimborsi spese o espedienti analoghi, le cifre erano irrisorie, soprattutto se paragonate ai guadagni dei top player di oggi. Rod aveva deciso di fare del tennis la sua professione e per vivere agiatamente e mettere su famiglia era necessario passare al professionismo. E lo fece, senza rimpianti e con grande successo.
Il primo anno da professionista, però, fu molto duro. Laver si trovò catapultato in un mondo completamente diverso rispetto a quello che conosceva e dove aveva trovato i primi successi. Se nel circuito pro ritrovò degli amici, come Ken Rosewall e Lew Hoad, e grandi campioni passati al professionismo da tempo, come l’estroso e geniale Pancho Gonzales, i primi tempi della nuova vita ebbero su di lui un impatto traumatico. Ecco cosa racconta Rod in proposito: “ … nessuno mi aveva preparato all’abissale divario tra gli standard di gioco amatoriali e quelli professionistici, un divario che avrei dovuto colmare con un duro lavoro, per dimostrare a me stesso che il mio passaggio non era stato il frutto di una decisione disastrosa” (pag. 157). Nel circuito pro Laver non solo trovò un livello molto migliore di gioco, ma le condizioni in cui si svolgevano i tornei (che costringevano i tennisti a veri e propri tour de force attorno al mondo) erano a volte surreali: “Non era facile abituarsi a viaggi che non finivano mai, a partite contro professionisti esperti che, più volte la settimana, disputavano per soldi incontri occasionali. Alcune volte giocavamo su campi famosi, al coperto o all’esterno, in erba, terra battuta e cemento, come al Madison Square Garden o al Longwood Cricket Club. Ma ci confrontavamo anche su superfici improvvisate, abbozzate e delimitate in tutta fretta, in sale di centri ricreativi, palestre scolastiche, teatri e sale da concerti, stadi su ghiaccio e fienili. In Sud America giocammo nelle arene per le corride” (pag. 154).
Oggi sembra incredibile, ma era proprio così, e Laver fu il numero uno dei professionisti per alcuni anni. Un’esistenza da nomadi, insomma, ma orgogliosa e consapevole del proprio valore e della necessità, per farsi apprezzare dal pubblico, di dare sempre il meglio di sé stessi, anche quando le condizioni in cui dovevano vivere erano particolarmente difficili: “Generalmente smettevamo di giocare attorno a mezzanotte o all’una del mattino e andavamo a dormire verso le tre nella camera d’albergo da 15 dollari (…). Alle sette eravamo già in piedi, pronti a mandar giù un hot dog o un hamburger in qualche ristorante da quattro soldi, poi salivamo nelle due station wagon (…) e ci mettevamo in strada per raggiungere la destinazione successiva. Il nostro campo in tela, simile a un tendone da circo, veniva arrotolato e sistemato sul camion che lo trasportava nella sede prestabilita. Dopodiché, recuperavamo un po’ di sonno, accendevamo l’interesse del pubblico del luogo attraverso interviste radio e televisive (…), andavamo a farci un’idea del campo sul quale avremmo giocato, quindi ci mettevamo all’opera” (pag. 162).
Poi, nel 1968, iniziò l’era Open. I tennisti professionisti furono ammessi a giocare i tornei del circuito amatoriale, quindi anche gli Slam e la Coppa Davis. Si è trattato, come ci racconta Rod, di un processo graduale ma irreversibile che ha portato al tennis di oggi. E fu così che Laver, nel 1969, conquistò il secondo Grande Slam, questa volta battendo avversari anche più forti rispetto a sette anni prima, visto che grandi tennisti professionisti come Ken Rosewall, Lew Hoad e John Newcombe (che sarà numero uno del mondo tra giugno e luglio del 1974) parteciparono a tutti i tornei più importanti. Questo libro celebra, tra le altre cose, la grande epopea del tennis australiano dagli anni ’50 agli anni ’70, una scuola che ha dominato in lungo e in largo nel mondo fino all’arrivo dei grandi campioni dell’era Open: Connors, Ashe, Borg, Vilas, McEnroe per citarne alcuni. È anche un libro sull’amicizia che legava quei grandi tennisti d’altri tempi, atleti che, dopo una battaglia all’ultimo sangue sul campo si bevevano un paio di birre insieme, un po’ come il “terzo tempo” nel rugby. Uomini e atmosfere oggi impensabili. Fra i tanti ritratti che Laver ci offre dei campioni suoi contemporanei, meritano attenzione quelli dedicati a Ken Rosewall, Lew Hoad, Pancho Gonzales, John Newcombe, Roy Emerson, Tony Roche, nomi senz’altro familiari a quelli che, come me, sono nati negli anni ’60.
Gli anni ’70 videro l’inizio del declino di Laver, anche se continuò a esprimersi su grandi livelli almeno fino al 1973, anno in cui conquistò la sua ultima Coppa Davis. A fine carriera ebbe anche la ventura di scontrarsi con la nuova generazione, quella, appunto, dei Borg, Connors, Nastase, Ashe, di cui tutti ci regala un ritratto, a volte positivo a volte no, ma anche quando non è positivo (come nel caso di Connors e Nastase) è sempre espresso con rispetto e con la consapevolezza di stare parlando, comunque, di grandi campioni. Rod Laver, un uomo semplice, un campione.
Carlo Cocconi
Leggi tutte le recensioni della Piccola Biblioteca di Ubitennis!