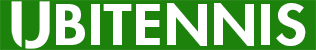Rassegna stampa
Matteo Berrettini: “Sono nato con un mito, Adriano Panatta” (Trani). La ferocia di Gardini, il migliore di tutti i tempi (Clerici)

Matteo Berrettini: “Sono nato con un mito, Adriano Panatta” (Ugo Trani, Messaggero)
«Adesso vado qualche giorno al mare». Matteo Berrettini, 22 anni, lascia Kitzbuhel e torna a casa. Atterra a Roma, la sua città che lo ha visto crescere ai Prati Fiscali e al liceo scientifico Archimede prima di traslocare ai Parioli dove il tennis ha messo da sempre più di una radice. E se ne va subito all’Argentario, in vacanza… [SEGUE]. Si è preso, senza perdere neanche un set, il torneo di Gstaad quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Nemmeno mamma Claudia e papà Luca. Con loro, appuntamento direttamente in Austria, lunedì sera, ventiquattr’ore dopo il 1° trionfo della carriera, battendo in finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut. «È stata una sorpresa pure per me: del resto non ero mai arrivato ai quarti, come potevo pensare di vincere?». Con quel servizio, sparato senza aver pietà di chi ha davanti, non pensa di poter spaventare chiunque? «Certo, fa la differenza nel tennis di oggi. Ma io sono all’inizio e non posso ancora fissare un obiettivo. È presto, anche se sono diventato il numero 54 del ranking. Conosco il mio potenziale. Non devo, però, correre troppo». Non insegue, dunque, il paragone con il romano più celebre della racchetta. Se le faccio solo il nome, Adriano, a chi pensa? «Panatta è stato uno dei più grandi tennisti italiani di tutti i tempi. La sua tecnica è impressionante. Mi fa piacere essere accostato, per alcune caratteristiche, a lui. E comunque non sento la pressione per il paragone: lo vedo lontanissimo…». Eppure lo ha avuto più vicino di quanto si possa pensare. «Ho giocato con Panatta in doppio, all’Aniene. Doveva prepararsi per un torneo Legends. Mi ha dato subito qualche consiglio». Quali? «Al primo scambio, si è fermato. E mi ha detto: “Il doppio si gioca solo serve&volley”. Me lo sono ricordato quando ho vinto, in coppia con Bracciali, a Gstaad». Panatta si è fermato lì? «No. Quando mi ha visto giocare, per la prima volta, a sedici anni, mi ha spiegato che con il mio fisico, usando la forza, avrei sicuramente servito a 220 chilometri all’ora. Non si è sbagliato: sono arrivato quasi a 230…». Non è però bastato per ripetersi subito a Kitzbuhel. «Ho pagato la fatica dei 5 match di Gstaad e dei successivi 2 in cui ho sempre giocato tre set. E le 7 ore di viaggio in auto dalla Svizzera all’Austria. La stanchezza è normale. Ma niente alibi: Jarry è stato più bravo nei punti decisivi. Siamo simili e so bene che cosa significhi». Stesso livello, o quasi, nel ranking con il cileno Jarry che è, nel gioco, contemporaneo come lei. Tra i campioni del circuito, invece, a chi si ispira? «Del Potro. Tra i big, è quello che seguo di più. Servizio e diritto, come me. Io spingo da dietro. I 196 centimetri mi aiutano. Cerco, però, più punti vicino alla rete. Ci sto lavorando con il mio coach Santopadre»… [SEGUE]. Meglio la terra rossa, il cemento o l’erba? «L’ordine è proprio questo. Il cemento, però, mi affascina. Questione di gioco, il mio». Solo il tennis nella sua vita? «Io mi alleno sette-otto ore al giorno, ogni mattina almeno tre-quattro. Da piccolo ho fatto judo e nuoto. A sette anni ho scelto il tennis. Anche in piscina potevo passare in agonistica, ma la passione per la racchetta è stato superiore. Poi il calcetto al circolo dei miei, Corte dei Conti, dove ho iniziato i corsi di tennis»… [SEGUE]. Qualche strappo alla regola? «La pasta e la pizza. Nei miei gusti, il salato più del dolce. Non seguo nessuna dieta, ma sto attento durante i tornei». Ha dedicato il primo successo ai suoi genitori. «Mi hanno sempre seguito in Italia e in Europa. In camper. Era l’unico modo per stare insieme. Vacanze e tornei, in posti bellissimi, all’aria aperta. Famiglia e tennis, il massimo».
La ferocia di Gardini, il migliore di tutti i tempi (Gianni Clerici, Repubblica Milano)
E siamo arrivati agli Anni Cinquanta, ai tempi in cui il giovane cronista Clerici tentò con alterna fortuna l’arte della racchetta, vincendo due volte il titolo junior in coppia con quell’autentico fenomeno che fu Fausto Gardini. È stato certamente, Fausto, il maggior tennista milanese di tutti i tempi. Era un ragazzo tanto magro, Gardini, che qualcuno trovò modo di scrivere che pareva uno scheletro magro. Era anche brutto, talmente brutto che finiva per apparire stravagante, e simpatico, fuori dal campo. Nei limiti di un court in terra rossa, Fausto si trasformava, le sue pupille si dilatavano e fissavano l’avversario quasi fosse un nemico da distruggere, i suoi gesti acquistavano lo scatto e la tensione dei posseduti, degli indemoniati. Doveva trovarsi, Gardini, al centro di una qualche congiura infernale, e i giornalisti con un minimo di letture non faticavano certo a citare il più celebre Fausto, quello di Goethe. Giocandogli contro, la barriera che lo innervava appariva addirittura palpabile: sulle palle importanti, “qualcos’altro” faceva lega con lui, e lo animava, lo difendeva. Vincergli un set diveniva un’impresa disperata, e anche pericolosa. Quando ebbi la fortuna di riuscirvi, la sua racchetta mi sibilò a una spanna dalla tempia, volando a infrangersi su un paletto: gli era sfuggita — si affrettò a spiegarmi premuroso — del tutto involontariamente. Fausto giocava un suo tennis straordinario, costruito sulle forze sottili ancor prima che su quelle muscolari. La sua capacità di soffrire era naturalmente enorme, la resistenza e il ricupero sorprendenti. A vederlo stremato e livido dopo partite vittoriose e cruente, chiunque avrebbe scommesso sul suo imminente ritiro. La mattina dopo ci si ritrovava di fronte un ragazzo teso e animato da una fiamma, pronto a ricominciare da capo, a battersi oltre i limiti della ragione. La tecnica di Gardini era modesta. Il suo diritto, un colpo terribile, eseguito con il braccio anchilosato e l’appoggio della spalla, era infinitamente più forte del rovescio, della volée malcerta, della seconda palla di servizio difensiva. Aveva un senso del tempo magnifico, Fausto, e si serviva di quel suo diritto anche per le volées a tre quarti di campo, e schiacciava bene quanto lobbava: mentre gli altissimi pallonetti si alzavano sopra il capo di avversari abbacinati dal sole e frastornati dal vociare del pubblico, Gardini si raccoglieva ben dietro la riga di fondo, in un atteggiamento a mezzo tra l’anacoreta e l’omicida: non si capiva se mormorasse preghiere o imprecazioni. Di ascendenza valtellinese e brianzola, Fausto fu l’idolo del peggior pubblico milanese, quello che dai popolari di San Siro si trasferì in massa per far tifo contro lo straniero ancor prima che per l’italiano. Nella piccola fossa del Porro Lambertenghi trasformato in bolgia, Fausto divenne imbattibile, e molte delle pagine più esaltanti, e insieme vergognose del nostro tennis, portano la sua firma sulfurea. Lui, Fausto, non se ne dava per inteso. L’unica, grande, indispensabile legge era quella della vittoria. E vinceva. Battè campioni come Washer, Brichant, Bergelin, Mottram, Nielsen, fu invulnerabile in tutte le Davis casalinghe, dall’esordio sino alla fine della carriera. Fuori casa, pur lottando sempre ferocemente, ebbe un crollo inatteso contro il Belgio nel 1953 e se non riuscì a strappare un punto ai grandi americani, disputò i suoi migliori match sull’erba nell’interzona, e cioè la semifinale unica, del 1952. Vinse un set a Tony Trabert e contro Vic Seixas condusse due set a uno e 5 a 2, davvero molto vicino alla grande vittoria, sotto gli occhi di un pubblico neutrale. Nei tornei dello Slam, Fausto non seppe andare oltre successi frammentari, anche se di prestigio, come quello su Mulloy a Wimbledon: sulla terra rossa, la fidata amica che usava costellare di croci propiziatorie, non superò i quarti di finale, a Roland Garros. Ci sarebbe certo arrivato più avanti, Fausto, non fosse stato bloccato netto da un curioso accidente. Nel contratto matrimoniale di una ricca ereditiera milanese, il futuro suocero elencò patti di ferro. Non poteva certo concedere, argomentò, la sua bambina a chi non svolgeva un autentico lavoro. Il terribile Gardini dovette quindi lasciare la racchetta, e si trasformò per cinque lunghi anni nel marito di sua moglie e nel genero del severo suocero. Il suo posto, nei cuori dei tifosi, venne preso dal romano Nicola Pietrangeli, dal meranese di Bologna Beppe Merlo, dal profugo istriano rifugiato a Milano Orlando Sirola. La provvidenziale dipartita del suocero consentì a Gardini un ritorno allo sport, un tentativo che sarebbe stato impossibile per chiunque altro. Non per Fausto. Faticò all’inizio, subì sconfitte umilianti, ma tenne duro, finché non riuscì nel ’61 a superare nuovamente Pietrangeli in una finale milanese dei Nazionali, un match dei suoi, trapunto da cadute, imprecazioni, esaltazione, e finale resurrezione, dopo 7 match point annullati. Terminò l’incontro, il vampiro, rotolandosi dannato, e ad ogni strato di terra che si appiccicava sui panni fradici crescevano i suoi diabolici poteri. Quella vittoria non fu sufficiente per convincere i dirigenti ad assicurargli un posto nella finale della Davis 1961, in Australia. Tentò ancora due volte, Gardini, il palcoscenico della Coppa, contro i tradizionali rivali di Svezia e Spagna. Ma era ormai un vecchio, povero diavolo. Fu battuto, addirittura deriso da uno svedese, Lundquist, che giunse a rimandargli per scherno un paio di palle fuori. Ritornò in ufficio, e chissà quante volte gli venne da pensare a quei cinque anni sciupati, passati nei mulini del terribile suocero a impolverarsi il doppiopetto grigio.