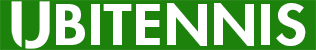Personaggi
Lindsay Davenport, la grinta e la dolcezza di una campionessa “normale”

TENNIS – Questo sabato avrà luogo la cerimonia di induzione nella Hall of Fame, assieme a John Barrett, Chantal Vandierendonck, Jane Brown Grimes e Nick Bollettieri, sarà la volta anche di Lindsay Davenport. Ripercorriamo la carriera e le emozioni di una campionessa “normale”.
Un parziale di otto punti a uno, nove fotogrammi che chiudono la finale degli Australian Open del 2000, Lindsay Davenport conquistava il terzo Slam della propria carriera e lo faceva senza perdere un solo set. Dall’altra parte della rete c’era Martina Hingis, che nonostante avesse recuperato da uno svantaggio di 5-1, con l’americana a due punti dal match, nulla ha potuto contro l’equilibrio e la serenità di un’avversaria convinta di poter vincere quel titolo. La sera prima della finale Lindsay guardava la semifinale maschile in TV, applicando al contempo del ghiaccio alla gamba dolente; ad un certo punto le telecamere inquadrarono Martina che si allenava su un campo secondario, cercando di affinare i propri colpi. Una cosa abituale per la svizzera, se non fosse che aveva appena perso una lunga e stancante finale in doppio… “Ho iniziato a ridere, allora sapevo che lei aveva bisogno di allenarsi un po’ più duramente o fare quel qualcosa in più, ma mi sorprese”. Chissà se nella mente di Martina c’era ancora il ricordo bruciante della finale persa a New York, o forse quel che più l’angustiava erano gli ultimi scontri diretti, tutti e tre persi con quella numero due che pareva poter disinnescare il suo gioco semplicemente “giocando”.
Lindsay era sempre la stessa ragazza dolce e grintosa, quella che nel ’98, a Flushing Meadows, scoppiò a piangere perché “non ho potuto far altro che piangere, per me è stato difficile anche sorridere. Era il momento più grande della mia carriera, di sicuro il più divertente. Sono cresciuta come un’americana per la quale gli US Open sono il torneo più importante, per me vincere nel mio paese è stato il momento migliore”. Una ragazza troppo semplice, che a differenza di Venus e Serena non aveva una personalità dirompente o la fascinosa complicatezza di Hingis, la teenager prodigio, o ancora il sex appeal di Kournikova, che pur non vincendo un titolo dominava le copertine; una ragazza che amava il tennis al di là di tutto il resto, della fama e della pressione della stampa, che si catalizzò su di lei quando, appena passata al professionismo, batté Gabriela Sabatini (tds n.3) a Delray Beach, ma tuttavia cordiale e sempre ben disposta: “Ho sempre amato giocare a tennis. Devo dire che non amavo le luci della ribalta o la stampa o qualsiasi cosa che viene con esso. Quindi per me [al momento del ritiro] scendere un po’ nell’oscurità è stato bello”.
Una carriera “giocata” e non “mediatica” la sua, che l’ha portata a vincere 55 titoli, fra cui i tre Slam sopraccitati (US Open 1998, Wimbledon 1999, Australian Open 2000) ed un Oro Olimpico, ad Atlanta nel ’96. L’attenzione su di sé non la portarono soltanto il suo talento e il suo tennis, ma anche un fisico imponente – al punto da farle affibbiare il nomignolo velenoso di “autocarro” – ed al contempo fragile, che contribuì ad alimentare un misto di dubbi ed incertezze dovuti ad una situazione familiare difficile, scatenata dal divorzio dei genitori. Un gioco, il suo, basato sulla solidità dei colpi, un servizio potente, un rovescio bimane incisivo e spesso decisivo, ma penalizzato, nella prima fase della carriera, proprio dalla mole di quel corpo, che arrivò a pesare anche 90kg e inficiava gli spostamenti, non solo laterali, ma anche in avanzamento, non permettendole di acquisire quella sicurezza a rete data da una maggiore reattività. Una sicurezza che troverà a partire da quella vittoria alle Olimpiadi, ai danni di Arantxa Sanchez Vicario, e che non mancherà nei momenti importanti: tre finali Slam giocate in tre anni consecutivi (1998-2000), tre vittorie senza perdere un set nell’arco di tutto il torneo.
Conseguentemente all’aver ritrovato la forma e la fiducia, il ’96 fu quindi l’anno della svolta per la carriera di Lindsay, non solo per l’Oro Olimpico e per il Masters WTA, ma anche per la prima vittoria Slam in doppio – in coppia con Mary Joe Fernandez (b. Gigi Fernandez/Natasha Zvereva) – arrivata sulla superficie a lei più difficile, quella dei French Open; senza dimenticare i quarti raggiunti in Australia per la terza volta consecutiva e la sconfitta di Steffi Graf nella semifinale di Los Angeles, torneo che vincerà battendo anche la tds n.2, Anke Huber. L’anno successivo arrivava un altro Major, questa volta la sua compagna era Novotna e lo scenario era quello di New York, dove 12 mesi dopo otterrà quello che per lei resta il ricordo e il trionfo più caro della sua carriera: la vittoria in singolare agli US Open, prima americana non naturalizzata a riportare, o meglio tenere, il titolo a casa in 16 anni. Il triennio dal ’98 al 2000 registra l’apice del suo tennis, con la vittoria in singolare di uno Slam in ciascun anno ed un altro successo in doppio – sempre in quel magico Wimbledon del ’99 – a cui si aggiunge il conseguimento della prima posizione mondiale già nell’ottobre del ’98; posizione che occuperà per ben quattro volte nell’arco della propria carriera (1998, 2001, 2004 e 2005).
Un percorso lungo 17 anni, che ha visto la vittoria di 753 match e 194 sconfitte e la partecipazione a 36 sfide di Fed Cup (33-3), facendo parte del team nelle ultime tre volte in cui gli Stati Uniti si sono aggiudicati la competizione a squadre. Un brutto infortunio al ginocchio alla fine del 2001 e la conseguente operazione per la ricostruzione della cartilagine, che ne hanno inceppato l’evolversi, lasciandola a digiuno di titoli per tutto il 2002, anche se raggiunse la semifinale nello Slam di casa. La pazienza e il desiderio di provare a vincere un altro Slam, un 2004 con un record di 63 match vinti e la riconquista della vetta del ranking. Di nuovo una finale Slam, in Australia (2005), dopo un’assenza che durava dallo US Open del 2000, ma persa in tre set contro Serena Williams. Due ritorni per passione, uno nel 2007 e l’altro in doppio nel 2010, entrambi a seguito della nascita dei primi due figli. La capacità di sorprendersi per i successi ottenuti, specialmente quel Wimbledon che mai avrebbe immaginato di vincere, incredula per l’essere riuscita a giocare così bene sull’erba. Tutto questo fa parte di Lindsay, la ragazzona di Palo Verde che come molte altre ha saputo costruire una carriera d’eccezione al di là dei profili da copertina e della vena commerciale che sempre più va radicandosi nello sport.
“Se si guarda a qualsiasi buon giocatore, che ha raggiunto la cima, uno dei migliori. Ognuno ha il proprio passato unico e la propria storia. Non c’è un modo giusto per fare di un giocatore un tennista professionista o per diventare il migliore al mondo. Per quanto mi riguarda, so che a tutti piace dire che è stata una delle storie più normali. È vero”.