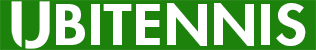Racconti
Robonole raccontato da Nole
Nole e RoboNole sono la stessa persona oppure no? Che cosa succede nella testa di Novak Djokovic quando domina qualunque avversario? E quando scopre il sapore della sconfitta?

La prima volta che lo incontrai, capii subito che razza di tipo era. “Tu sei il più forte e ancora non lo sai”, mi disse. E invece sì che lo sapevo, solo che non riuscivo ad aggiustare il puzzle e quei due là mi complicavano maledettamente le cose. Ma per lui non erano loro il problema, ero io. Mi fidai. Era così sicuro di sé, così fiducioso, così sfrontato: impossibile guardarlo negli occhi e non provare della riverenza. Quando mi guardò dritto negli occhi e aggiunse: “Io e te diventeremo i più forti di tutti” non potei far altro che dire: “Sì”.
Aveva ragione lui. Eravamo i più forti. Cominciammo a lavorare. Dall’alba al tramonto, a volte anche oltre, il tennis e il numero uno erano sopra ad ogni pensiero. Costruivo, mattone dopo mattone, il Novak Djokovic che avevo sempre sognato. Vincente, dominante, imbattibile. Quando cominciai a vincere con così tanta facilità, rimasi sorpreso. Non mi aspettavo che le vittorie fossero a portata di mano. Avevo dimenticato quanto fosse facile. Ma lui non era affatto sorpreso. Anzi, era sorpreso della mia sorpresa e me lo rimproverava: “Queste vittorie non sono l’eccezione, sono la normalità. Ti ci dovrai abituare”. E vittoria dopo vittoria, settimana dopo settimana, mi cominciai davvero ad abituare. Scendevo in campo e il mio avversario sapeva già che avrebbe perso. Anzi, sapeva già che io avrei vinto. E anche quei due là si dovettero adeguare. Furono cinque mesi che scivolarono via velocemente. Lui mi diceva cosa dovevo fare e io lo facevo. Era tutto così facile, così perfettamente chiaro e limpido che scendere in campo diventava rilassante.
Quello che lui non mi aveva spiegato – e che io avevo colpevolmente dimenticato – è che non si può vincere sempre, nemmeno se sei Novak Djokovic. Forse lui nemmeno concepiva questa opzione, tanto era accecato dalla voglia di primeggiare. Però accadde. E accadde in una maniera così violenta ed inspiegabile che per qualche giorno non riuscivo nemmeno a sentire cosa mi diceva. Fu quella la svolta del nostro rapporto: perché quell’anno continuai a vincere a ripetizione ed erano finalmente quegli altri due a dovermi guardare mentre mi specchiavo nei miei amati trofei, ma da settembre mi dovetti praticamente fermare perché il peso di quelle vittorie mi stava schiacciando pian piano. Non osavo dirglielo, ma vincere era stancante per il fisico e per la testa. Lui non avrebbe mai capito quello che provavo e perciò non mi rimase altra opzione che riprendere a vincere.
In Australia, dove tutto era cominciato, chiusi un cerchio lungo dodici mesi. Non erano stati dodici mesi di sole vittorie, naturalmente, ma quando guardai il mio avversario, mentre sedevamo stremati dopo la partita più lunga della nostra vita, vidi nei suoi occhi un’ombra di rassegnazione e me ne rallegrai perché quell’ombra, io, l’avevo messa nel dimenticatoio. Lui me l’aveva detto: “Quando comincerai a vincere, non vorrai più smettere. E se gli altri non si faranno da parte, sarai tu a prenderti quello spazio”. L’unico spazio che mi mancava, ormai, era quello rosso parigino. Quasi uno spazio vitale. Lui mi continuava a dire che Parigi sarebbe stata mia e che gli altri non avrebbero potuto farci nulla. Ma Parigi è una città infida. È una città affascinante e misteriosa, sfuggevole e maliziosa. Non l’ho mai capita, Parigi, e forse lei non ha mai capito me, gli dissi, dopo una sconfitta che non avevo messo in conto. “Tutte scuse!” mi disse lui, incazzatissimo come non l’avevo mai visto, fuori di sé per colpa di una variabile impazzita che lui non riesce a calcolare nell’equazione della sua mentalità: un avversario più forte. Io, con il cervello ancora cotto, non riuscivo nemmeno a rispondere e non avevo coraggio di dirgli perché avevo perso. Lo sapevo, ma lui non lo avrebbe mai capito.
Da allora, Parigi è stata al centro dei miei pensieri come nessun’altra città. Io e lui abbiamo lavorato con quel solo obiettivo in testa. Mi ripeteva che non avrei più sbagliato, che il mio tempo sarebbe arrivato e che finalmente avrei avuto quello che già mi apparteneva di diritto. Non ha mai contemplato l’errore, la debolezza e la rassegnazione. Ed è per questo che ogni volta che torno a Parigi sento che qualcosa mi opprime. È lui: la sua immensa voglia di vincere, il suo irresistibile bisogno di sopraffare l’avversario, l’irrinunciabile richiamo a completare una bacheca che si fa sempre più pesante, pesante quanto il dovere di vincere Parigi, opprimente quanto il rifiuto di fallire. L’ultima volta, a Parigi, è stata la più dolorosa. Per i primi giorni, lui ha cambiato tattica: se n’è rimasto in un angolo, roso dalla tensione e dalla consapevolezza che questa era la volta buona. Quando ho rimosso l’incubo che mi aveva fermato negli ultimi tre anni, però, non fu più possibile metterlo da parte. Da quel giorno fino alla finale, si insinuò nella mia testa come mai aveva fatto prima. Forse io ero più debole, fiaccato dal dovere di vincere, o forse lui era più forte, rinvigorito dalla fine delle maledizione. Fatto sta che per me fu impossibile liberarmene. E poi lo sappiamo benissimo entrambi che senza di lui non riuscirei a vincere.
Dopo aver vinto il primo set, come l’anno scorso, il frastuono di RoboNole diventa assordante. Lo sa che siamo vicini all’obiettivo ed è fuori di sé. La vittoria lo dopa come nessun altro stimolante riuscirebbe a fare. I suoi occhi si dilatano, il respiro diventa più pesante, i muscoli si gonfiano. Comincia a ricordarmi incessantemente che cosa stiamo raggiungendo e che cosa abbiamo fatto per ottenerlo. Provo a tapparmi le orecchie e a chiudere gli occhi, pensando solo a colpire la palla più forte, sempre più forte. Quello che ho dimenticato, però, è che c’è un altro tennista dall’altra parte della rete. E mentre io provo a schiacciare sull’acceleratore per non sentire il peso delle mie responsabilità, il mio avversario gioca sempre più sciolto. Il dubbio, che in queste due settimane non mi ha nemmeno sfiorato, comincia a fare capolino. Conosco quella sensazione perché qui a Parigi è diventata la compagna delle mie sconfitte, eppure non riesco a sconfiggerla. RoboNole urla sempre più forte, così come i colpi di Stan diventano sempre più veloci. Sembra un brutto sogno ed è invece realtà, come tutte le altre volte. Provo a ribellarmi, faccio di tutto per annullare quella sgradevole sensazione di ineluttabilità, eppure alla fine, come l’anno scorso e quello prima ancora, perdo. Lui è una furia, schiuma di rabbia come poche ore prima schiumava per una vittoria che gli sembrava di toccare e che è invece si è volatilizzata di nuovo. Ma io non lo sento.
Di quel giorno non mi è restata l’amarezza. Perché io, Nole, mi sono goduto quell’interminabile applauso che Parigi mi ha tributato. L’ho ripagata nell’unico modo che mi era possibile in quel momento, sorridendo mentre piangevo, rialzandomi invece di crollare. Mi sono goduto quell’ombra di successo perché so che la sconfitta non è un disonore e sebbene anche questa volta non abbia il trofeo con me, porto con me il calore di Parigi. Se anche RoboNole imparerà ad apprezzare la dolcezza di una sconfitta, la prossima volta vinceremo. Insieme.