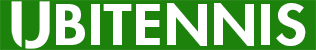Rubriche
Auguri Juan Martin. E non facciamo che ci perdiamo di vista
Oggi la “torre di Tandil” Juan Martin del Potro compie 28 anni. Una carriera che sembrava finita, ma per fortuna quest’anno si sono giocate le Olimpiadi

Il 2016 verrà ricordato come l’anno della chiusura del cerchio per Nole, capace finalmente di conquistare lo Slam che continuava ogni volta a sfuggirgli. Anche per essere stata la prima stagione a fare davvero i conti con le assenze di Federer: è andato in scena il primo Major del millennio senza l’elvetico, che chiuderà l’anno senza titoli come mai accaduto dopo il 2000. Un po’ di magone ce l’ha strappato anche Juan Martin del Potro, rientrato in campo a febbraio in quel di Delray Beach con il faccione triste di chi spera che ogni palla gli capiti sul lato del diritto. Una sequela infinita di rovesci tagliati, teneri, lontani parenti dello schiocco – seppur non paragonabile a quello del dritto – a cui ci aveva abituato prima dell’infortunio.
Le sofferenze dell’argentino sono emerse chiaramente ad ogni cambio campo. Più volte è stato sorpreso dalle telecamere a tenersi il polso sinistro per qualche secondo in preda alla preoccupazione di non riuscire a concludere la partita. Attraverso Indian Wells e Miami ogni scambio ha trasudato affanno, con “delPo” quasi sempre inchiodato dall’avversario nell’angolo di campo dal quale gli era quasi impossibile uscire vincitore. Un accanimento che faceva venir voglia di entrare in campo, sottrarre la pallina al gioco e risparmiare al gigante sudamericano un trattamento certo ingeneroso per uno col suo curriculum. La terra di Madrid e Stoccarda, paradossalmente, ha regalato al campione argentino qualche speranza in più. Nel 1000 spagnolo è arrivata addirittura l’affermazione su un Thiem pur svuotato di energie dal tour de force sulla terra battuta.
A Wimbledon la svolta. Non si batte Stan Wawrinka sul centrale se non c’è l’intenzione di spingersi oltre lo status di ex campione decaduto. L’immediata sconfitta contro Pouille è però il chiaro segnale che la lunga distanza non si può ancora vincere. A Rio invece si gioca al meglio dei tre, c’è il cemento e non siamo neanche troppo lontani da casa. La finale sarebbe più lunghetta ma tanto c’è subito Djokovic, figurarsi. Succede però che alla fine della partita è proprio il serbo che versa lacrime e cerca l’abbraccio del suo avversario. Juan Martin ha vinto, e vincerà anche contro Sousa e Daniel, contro Bautista Agut e Nadal. Uno non ci pensa, ma alla fine deve giocare almeno tre set contro Andy Murray. E poco dopo averli persi questi tre set si guarda indietro e scopre che per un soffio non è stato in grado di imporgli di giocare il quinto, a uno che sembrava pronto a mettere in crisi il regno di Djokovic. Del Potro è tornato, il diritto a tratti sembra persino più esplosivo del 2009, il rovescio ha fatto di necessità virtù. E con Murray mica è finita.
Prima però c’è la rivincita di Wawrinka, che a New York ferma delPo ai quarti di finale e poi veleggia sornione verso la conquista del titolo. “Palito” non ha voluto mettere i bastoni tra le ruote all’unico altro tennista in grado di aprire una breccia nel muro dei Fab Four. O forse stava conservando le energie per uno scopo più grande della semplice soddisfazione personale, aveva in mente di regalare una gioia all’intera Argentina. E conta poco che di mezzo ci sia ancora Murray, anzi, forse è il dettaglio che restituisce al campione il vigore che sembrava impossibile ritrovare sullo scivoloso terreno dei cinque set. Cinque parziali che devono essere giocati tutti, fino in fondo, e si chiudono con l’ace della liberazione. La maschera dello sforzo ben visibile sul volto di Juan Martin si alterna al sollievo, il sollievo dopo 24 ore si tramuta in gioia. Esattamente quando Mayer si veste da eroe e trascina i gauchos in finale.
Adesso, caro gigante, questa finale la devi giocare perché lo devi un po’ a tutti. Magari acciaccato e sofferente, ma tanto ci sei abituato, è la tua storia. E alla fine, qualsiasi risultato decreterà il campo, mi raccomando non sparire. Da queste parti ci sei utile. Non fare, anzi non facciamo, che ci perdiamo di vista. Auguri Juan Martin.