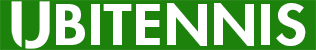Rubriche
Andy Murray numero uno. Questione di etichetta
Perdente, non all’altezza, nato sbagliato, inadeguato. Scozzese. Adesso Andy Murray può mostrare l’unica etichetta che davvero gli appartiene

Etichetta. Che parola ridicola. Proprio da un punto di vista fonetico, fa ridere. Etichetta. Una di quelle che non ce la fai a non ripetere in continuazione, e dopo dieci volte perdono ogni significato: rimangono solo lettere e suoni. Etichetta di cosa, poi? Etichetta del prezzo? Non è mai stata una questione di soldi, non scherziamo. Anche quando a vent’anni poteva già permettersi qualsiasi lusso, quando al suo angolo sedevano i coach più blasonati o i nomi più discussi. Non è certo andato avanti per denaro, non era quello che lo ha spinto a reggere sulle proprie spalle il peso di una nazione intera, per non parlare di una bandiera unificata. A sopportare l’epiteto di provinciale nelle sconfitte, a sostenere la gloria da londinese per le vittorie. Non erano certo pounds, dollari o euro la benzina che l’ha nutrito fino ai due ori olimpici, al titolo di baronetto, al doppio Wimbledon. Etichetta intesa forse come educazione? Dài, seriamente. Uno che smoccola in dialetto scozzese ad ogni cambio campo anche quando sopra di un set e due break. E i monologhi di turpiloquio con il proprio box, e lo scambio di opinioni con Rosol a Monaco, e la mamma da difendere con un giovanissimo del Potro. Che etichetta può mai essere questa.
Eppure gliene hanno incollate di pesanti. Quella di eterno secondo, quando per carità bravo, ma gli altri sono altra roba e la bacheca si riempiva di piatti d’argento e foto serie, in attesa che si alzasse quello che aveva vinto il trofeo vero. Quando non bastava, ovviamente, fare incetta di finali e piazzamenti, di titoli minori e teste di serie numero uno in tabelloni mediocri. Quella di nato sbagliato di fatto, perché se avesse giocato trent’anni fa altro che GOAT, avrebbe dominato come mai nella storia. Quella di quarto moschettiere, nell’epoca dei soliti tre, quando il suo nome appariva come quello più debole e le testate recitavano sempre: “Federer dal lato di Nadal, sarà battaglia. A Djokovic va meglio, pesca Murray”. Quella di incompiuto e maleducato, quando la presenza della madre sembrava offuscare la sua identità, fino al taglio quasi definitivo del cordone ombelicale grazie alla solidità costruita, poi incrinata, con Ivan Lendl. Nel complesso, l’etichetta di perdente, un vorrei ma non posso, una Ferrari in giardino. E lui sembrava non fare nulla per togliersela di dosso, non c’era chiave adatta per uscire dalla stanza dorata in cui si era cacciato, e a volte pareva quasi non interessarsene. Ma le lacrime a Wimbledon 2012, quando ancora una volta aveva vinto il primo set e conteso ad altissimi livelli il secondo a Roger Federer, furono forse l’accenno di quello che sarebbe poi stato un deciso colpo di coda che gli permettesse di prendere in mano la sua vita, la sua carriera. E di fatto, staccarsi l’etichetta dalle spalle. Fu una sorta di liberazione, di sfogo, di delusione mista a consapevolezza di poter arrivare dove nessuno gli prospettava sarebbe mai arrivato.
L’etichetta vera, l’unica, quella che più può fare rima con il nome di Andy Murray, è quella di predestinato. Quando nel 2005, a diciotto anni, si inerpica fino al terzo turno di Wimbledon, quasi abbagliato dai riflettori che gli si parano davanti, nel tempio di quel tennis e di quel pubblico che disperatamente era alla ricerca di un altro rappresentante per il post Henman. Ma al terzo turno perse, e tornò ad essere un giovane scozzese, non proprio qualsiasi ma insomma. A fine anno la prima finale a Bangkok, persa contro il mostruoso Federer di quel periodo, che nonostante la vittoria in due set a fine gara dichiarò senza dubbi che “rivedremo presto Andy su palcoscenici più importanti”. Il trionfo in casa dopo mille anni da Fred Perry, la Davis consegnata alla sua Scozia giocando di fatto da solo se non con l’aiuto del fratello. L’atteggiamento di chi non è mai soddisfatto, spesso travisato o sfociato in indolenza e pantomima, ma originalmente un desiderio continuo di volersi migliorare e spingersi al limite. Come se stesse sempre lì a guardarsi la schiena, con il collo piegato in modo innaturale e le braccia a cingersi da sé, nel tentativo troppo vano di arrivare con le dita nell’unico punto delle spalle che non riesce a raggiungere e che è anche l’unico in cui tutte le etichette gli sono state applicate.
Ci è arrivato, alla fine, quasi delicatamente, con l’aiuto di uno specchio o di una persona a lui cara. Una seconda parte di 2016 dominata, pur con tutti i problemi di Djokovic che probabilmente, anzi certamente, non gli interesseranno. Ad una ad una, tutte le etichette sono state cancellate, smacchiate, erose: forse con l’aiuto del suo granitico team di preparatori e fisio, di sua moglie Kim che pur di stargli accanto si è beccata anche una mezza denuncia per oscenità pronunciate in pubblico. La mano rigida ma amorevole di mamma Judy, quella forte, mancina e affettuosa del fratello Jamie. Tutte lavate via, le etichette di questi anni. Per arrivare ad attaccarsi, da solo perché da solo se l’è guadagnata, quasi scritta, sul petto, l’unica etichetta che in questo momento gli appartiene per davvero. Quella di numero uno.