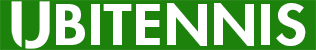Rassegna stampa
Basilea dolce casa. Federer fatica ma non perde mai. Bertens e Stephens, a voi la semifinale (Crivelli). Wozniacki choc: ”Soffro di artrite reumatoide” (Secolo XIX). Elogio del tie-break, che aumenta lo spettacolo e uccide la noia (Medina). Otto Next Gen per una wild card (Facchinetti)

Basilea dolce casa. Federer fatica ma non perde mai (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)
Cosa dolce casa: «E’ sempre un piacere giocare qui, solo Wimbledon con la sua storia e con quello che ha rappresentato per me può avvicinarsi». II legame speciale di Roger Federer con Basilea, la città dove è nato e dove ha vissuto fino a 14 anni prima di trasferirsi al centro federale di Ecublens, è testimoniato dalle otto vittorie nel torneo, dai 16 quarti di finale giocati e dalla serie positiva di 18 partite (non perde un match dal 2014), tenuta viva ieri con il successo su Simon. LUCI E OMBRE Insomma, di fronte a papà Robert e mamma Lynette è ancora aperta la caccia a un trofeo che quest’anno manca ormai da Stoccarda a giugno e che sarebbe il numero 99 in carriera, anche se la versione casalinga del Divino fin qui non è stata appassionante se non per l’affetto enorme della gente. Nella nona sfida in carriera contro il francese, 32 del mondo, Roger resta in campo 2 ore e 34 minuti e se ritrova parzialmente il servizio (15 ace e il 71% di punti con la prima, ma anche 5 break subiti), balbetta nei colpi da fondo, in particolare quelli giocati per fare il punto diretto (alla fine saranno ben 60 i gratuiti). E’ vero che per sua stessa ammissione negli ultimi tre mesi è stato tormentato da guai alla mano destra molto abilmente celati, e dunque la routine quotidiana ne ha risentito: la semifinale con Tsitsipas o Medvedev, due fra i giocatori più caldi del momento, sarà rivelatrice delle condizioni attuali dello svizzero, iscritto anche a Bercy (c’erano dubbi, peraltro non ancora dissipati, sulla partecipazione parigina) e sicuramente focalizzato sul Masters di fine anno, una sorta di torneo del giudizio tra lui, Nadal e Djokovic, tornati a dominare come ai bei tempi. ARIA DI FINALS A Londra ci sarà sicuramente Zverev, al solito molto più convincente nelle partite due su tre e chirurgico nel prendersi la vendetta, anche con un punto arrivato dopo 40 colpi, sullo spagnolo Bautista, che nel 2013 lo batté nella sua prima partita sul circuito Atp, a Amburgo, da wild card sedicenne. Per la cronaca, i soli tedeschi a vincere a Basilea sono stati Becker e Stich (93 e `94). In proiezione Atp Finals, però pesa soprattutto Vienna, dove nei quarti erano in corsa quattro pretendenti agli ultimi tre posti rimasti (che poi sono quattro perché Del Potro rinuncerà) e si affrontavano tra di loro. Grande dimostrazione di forza di Nishikori, forse alla miglior partita della stagione contro Thiem, piegato in appena 69 minuti e con appena 10 gratuiti concessi. Con la vittoria il giapponese scavalca Isner al nono posto della Race stagionale, in pratica l’ultimo biglietto utile. Assai vicino al viaggio verso la 02 Arena è anche il sudafricano Anderson, sicuro della qualificazione se vincerà il torneo austriaco. Aveva una sfida delicata con Coric, altro pretendente, ma il croato si è ritirato e adesso deve sperare in un miracolo sulla Senna.
Bertens e Stephens a voi la semifinale. È la solita lotteria (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)
Corne sempre, le Wta Finals sono il torneo più impronosticabile. Perché arrivano alla fine di una stagione massacrante e più delle gambe conta la forza mentale di andare oltre i limiti. E poi c’è il solito refrain del tennis femminile di adesso: tramontata l’era delle dominatrici, Serena Williams in testa, tra le top ten può vincere chiunque. Perciò alle semifinali di Singapore non approda nessuna delle vincitrici Slam del 2018 (a dire il vero la Halep è assente) e si rivede la Svitolina che dopo il trionfo di maggio a Roma ha collezionato appena un’altra semifinale (a Montreal). Oppure la Stephens, unica del quartetto campionessa di un Major (gli Us Open dell’anno scorso) ma reduce da tre eliminazioni al primo turno negli ultimi quattro tornei. Completano la rosa la Bertens, sorpresa relativa, perché è arrivata al Masters sull’abbrivio di un eccellente finale di stagione che le ha regalato la qualificazione proprio nell’ultima settimana e poi la picchiatrice Kvitova, in una delle quelle settimane in cui può diventare ingiocabile. Vinca la migliore.
Wozniacki choc: “Soffro di artrite reumatoide” (Secolo XIX)
Dall’Olimpo del tennis all’incubo di non poter più tenere una racchetta in mano. E il fulmine a ciel sereno che ha colpito la danese Caroline Wozniacki a cui è stata diagnosticata una forma di artrite reumatoide prima degli US Open. La 28enne danese, n° 3 al mondo ed ex n° 1, vincitrice dell’ultimo Australian Open, lo ha rivelato dopo la conclusione della sua stagione, sconfitta dall’ucraina Elina Svitolina nel round robin alle Wta Finals di Singapore. «All’inizio è stato uno choc, visto che ti senti come l’atleta più forte di tutte e all’improvviso ti trovi a dover convivere con questo problema. Devi solo essere positiva e affrontarlo, ci sono comunque modi in cui puoi stare meglio. E stato molto duro, ma sono orgogliosa di come sono stata positiva, non permettendo a tutto ciò di ostacolarmi». Wozniacki ha rivelato d’aver cominciato a sentirsi affaticata dopo Wimbledon, quando una mattina si è svegliata a Montreal incapace di sollevare le braccia sopra la testa, dovendo poi ritirarsi nel match d’esordio a Cincinnati. Gli esami hanno portato alla diagnosi di artrite reumatoide, malattia autoimmune che causa gonfiore delle articolazioni e affaticamento. La danese ha assunto farmaci e ricevuto cure. E si è detta convinta che non avrà un impatto significativo sulla sua carriera. «Ci sono molte persone che stanno combattendo con questa malattia e spero di poter rappresentare per loro qualcuno a cui possono guardare e dire “se può farlo lei, posso farlo anche io”. E, insieme, sostenerci a vicenda.
Elogio del tie-break, che aumenta lo spettacolo e uccide la noia (Giulia Medina, Il Foglio)
A Wimbledon stava calando la sera, l’orologio segnava le 19.20, era il 13 luglio di quest’anno, il sole era andato via da un po’. John Isner a un certo punto del quinto set, dopo sei ore di semifinale, si è rivolto alla giudice arbitro Marija Cicak e l’ha supplicata: “Mi scusi se mi permetto, non è che si potrebbe giocare un tie-break?”. Sembrava l’ultima preghiera di un condannato. Lei ha sorriso e non ha avuto nemmeno bisogno di rispondere. Il tennista statunitense si è alzato ed è tornato in campo rassegnato a ricevere il servizio di Kevin Anderson. Ancora una volta. A Isner era successa la stessa cosa otto anni prima, sempre a Londra, al secondo turno contro il francese Nicolas Mahut. Servizi vincenti contro servizi vincenti, più di cento ace a testa, una partita che non voleva saperne di finire. Quella volta vinse lui 6-4 3-6 6-7 7-6 70-68 dopo tre giorni e 183 game, in totale 11 ore e 5 minuti dentro al campo. L’ultimo set era durato più di 8 ore: il corridore britannico Mohamed Farah nello stesso tempo avrebbe potuto percorrere quattro maratone. Una targa sul campo numero 18 la ricorda come la partita professionistica più lunga della storia del tennis. Era stato bellissimo, era stato troppo. Quest’anno Isner ha perso 6-7, 7-6, 7-6, 4-6, 26-24 dopo un quinto set durato due ore e 55 minuti (la finale tra Djokovie e Anderson, premiazione compresa, in totale è durata dieci minuti in meno). E finita tra gli applausi e gli sbadigli del pubblico che, gentilmente come al solito, non ne poteva più di vedere tutti quegli ace. John McEnroe, ai microfoni della Bbc, commentò: “Non è giusto, è stata una tortura, un inutile massacro, è ora che cambi qualcosa anche qui dentro”. “Come ti senti?” chiesero a Isner i giornalisti a fine match. “È terribile”, rispose lui, e non aveva nient’altro da aggiungere. Sei ore buttate nel niente. Dopo tutti quei vincenti, palle salvate, vantaggi, break e contro break, se mai c’era stata una ragione per cui aveva amato il tennis, se l’era dimenticata. Dalla parte dei vincitori, la sensazione era più o meno la stessa. Kevin Anderson aveva appena raggiunto la sua seconda finale Slam in carriera e non riusciva a trovare la forza per sorriderne. “Le mie gambe hanno la stessa consistenza della gelatina, posso assicurarvi che non c’è niente di bello nel vincere partite del genere”. Aveva vinto, la sua schiena non se n’era accorta, urlava, gliel’avrebbe fatta pagare; i piedi erano diventati un campo di battaglia. Due giorni dopo avrebbe incontrato Djokovic su quello stesso campo, il solo pensiero gli faceva venire la nausea. Dopo le polemiche nate da quella partita, l’organizzazione di Wimbledon ha deciso di ascoltare le richieste dei giocatori. Dal prossimo anno, sul 12 pari del quinto set verrà introdotto il tie-break (come già succede agli Us Open dal 6 pari). Nel regno del passato e della tradizione hanno deciso di fare un strappo all’etichetta per amore del gioco, del pubblico pagante e della sua pazienza limitata, e soprattutto per rispetto alla salute dei tennisti. La scelta del 12 pari, suggerita anche da Isner, è sembrata la migliore: prima di decidersi tutto in sette punti, i giocatori hanno la possibilità di giocare altri 12 giochi, che equivalgono a un altro set. L’ultima finale finita oltre il 12 pari nella storia dei Championship resterà quella giocata nel 2009 tra Andy Roddick e Roger Federer. Era il 5 luglio, Andy Roddick allora numero 6 del mondo, non ha mai perso il servizio per 37 game consecutivi. Ace, prime di servizio a una media che superava i 200 km/h, dritti vincenti scaraventati sulle righe di fondo, discese a rete, passanti e volée: quel pomeriggio l’americano buttò in campo tutto quello che aveva da offrire allo sport. Poteva bastare? Non proprio. Quando il tabellone del punteggio indicava 2 set pari, 8 pari e 40 pari, cos’altro bisognava dimostrare per capire che quella finale non meritava né vincitori né vinti? Ma qualcuno doveva alzare il trofeo. Roddick aveva l’erba del centrale anche in mezzo ai denti, da circa quattro ore il suo campo visivo era ossessionato da ciò che accadeva dall’altra parte della rete, una prospettiva di circa otto metri gli stava massacrando l’anima e il corpo. Come avrebbe potuto non odiare ciò che stava facendo? Non riusciva a smettere di giocare. È finita 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14 per il tennista svizzero, che conquistò il titolo per la sesta volta. Dopo aver stretto la mano all’avversario, Federer ha trovato la forza per saltare un paio di volte e poi si è dovuto aggrappare alla rete, non riusciva a stare in piedi. Roddick ha lanciato la racchetta per aria, ha abbassato la testa e non l’ha rialzata più. “Ci ho provato, ve lo giuro”. Lo avevano capito tutti, ma non era bastato. Il tie-break è stato introdotto per la prima volta agli Us Open nel 1970, Australian Open e Roland Garros lo adottarono rispettivamente nel 1971 e nel 1973. Wimbledon come al solito ci mise più tempo per adeguarsi alla modernità, a malincuore gli organizzatori lo inserirono nel regolamento nel 1979, a esclusione del quinto set. I critici e i reazionari si lamentarono, era una brutta rivoluzione, la morte del tennis e delle sue consuetudini. Ci fecero l’abitudine quasi subito, la nuova invenzione piacque a tutti. Il tie-break aumenta lo spettacolo e la dose di imprevedibilità. Nel tennis basta un punto per spostare gli equilibri, una partita spesso viene decisa da una manciata di secondi. È vero sempre, nel settimo game lo è di più. Sul 6 pari del quarto set non è più soltanto tennis quello che succede dentro il campo. I giocatori si portano dietro tutti i loro fantasmi, il respiro che si strozza in gola, la paura di sbagliare, la fiducia in se stessi che non è mai illimitata. Si portano dietro ciò che rimane del corpo, la capacità di resistere, di stringere i denti e di pensare, ingannandosi, “ancora un punto, poi un altro, tra poco sarà tutto finito”. L’avversario diventa l’ultimo dei problemi. John McEnroe e Björn Borg, nella finale del 1980, hanno giocato cinque set prima di abbandonare il campo. Il quarto parziale si è deciso al tie-break, il secondo della storia di una finale a Wimbledon, il più importante. L’americano entra sul Centrale indossando una fascia rossa sulla fronte, più passa il tempo più diventa pallido in viso, gli occhi scavati. Fa serve and volley da due ore e 40 minuti e l’arbitro lo condanna a continuare. Il tredicesimo game dura 34 punti, finisce 16-14 per McEnroe. Dentro a quei 22 minuti e 18 secondi è contenuto tutto il tennis fino ad allora conosciuto. Meglio di così, a quei tempi, non si poteva giocare. McEnroe, le sue mani sui fianchi e poi subito dopo davanti agli occhi per non guardare il suo passante fuori di niente ma comunque fuori, ha dovuto salvare 4 match point dello svedese. Quando Borg sbaglia, lui non esulta, non ne ha proprio motivo, al massimo tira un sospiro di sollievo: lo spettacolo può continuare, l’agonia anche. Sul 7-6 lo svedese numero uno al mondo cade sull’erba, sbaglia volée e match point. Quel che resta del suo avversario è ancora vivo, ancora in piedi. McEnroe odia il tennis, Wimbledon, l’erba rovinata dal sole e dalle sue scarpe, odia la rete e le linee di fondo campo. Odia anche Borg e fa bene, vince il tie-break ma non ha tempo di pensarci perché il set decisivo è di Borg che con un punteggio di 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6 vince il titolo per la quinta volta consecutiva. “Cosa ti ricordi di questo tie-break?”, hanno chiesto alla schiacciatrice Miriam Sylla in un’intervista a Repubblica dopo la semifinale vinta contro la Cina ai Mondiali di pallavolo. “Niente. Assolutamente niente. Non mi ricordo nemmeno di averlo giocato”, ha confessato lei. Roger Federer è sempre stato contrario all’introduzione del tie-break nel set finale di Wimbledon. “Il tennis non è una partita ai calci di rigore, non si può decidere chi vince e chi perde in maniera cosi impietosa e ingiusta”. Si sbaglia, soprattutto lui che è il tennista con più vittorie all’attivo. Il tie-break finale non è uno scandalo, non è solo fortuna e non sono calci di rigore. E anche se fosse il risultato non cambia, lui dovrebbe saperlo: nello sport vince sempre il più bravo.
Otto Next Gen per una wild card (Andrea Facchinetti, Il Giorno)
Il quadro dei partecipanti alla Next Gen Atp Finals 2018 in programma a Milano Fiera-Rho dal 6 al 10 novembre si è ufficialmente delineato con la qualificazione dello spagnolo Jaime Munar che va a fare compagnia a Stefanos Tsitsipas (Gre), Denis Shapovalov (Can), Alex De Minaur (Aus), Francis Tiafoe (Usa), Taylor Fritz (Usa) e Andrey Rublev (Rus). A completare il mosaico del torneo riservato ai migliori under 21 del circuito internazionale manca solo una casella, riservata ad un italiano che uscirà dal torneo di qualificazione al via venerdì 2 novembre sui campi indoor dello Sporting Milano 3, la cui lista ufficiale è stata presentata nel circolo alle porte di Milano. Il ruolo di favorito spetta al romano Gian Marco Moroni, numero 228 Atp, seguito a ruota dal pugliese Andrea Pellegrino, dai laziali Riccardo Balzerani e Liam Caruana (nella foto). Nel ruolo di outsider si calano invece il novarese Giovanni Fonio, il romagnolo Enrico Dalla Valle, del napoletano Raul Brancaccio e il romano Jacopo Berrettini. Due le novità rispetto al 2017. La prima è la superficie, che sarà la stessa utilizzata a Rho per i due gironi e le fasi finali del torneo principale, la seconda è la regola che impone ai giocatori di prendersi da soli l’asciugamano, senza il supporto dei raccattapalle.