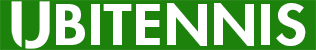Personaggi
L’isolamento letterario di Andrea Petkovic, eccezione alla regola di David Foster Wallace
Andrea ha creato un club del libro e sembra voler sconfessare il celebre saggio di Wallace, che disse di Michael Joyce (tracciando il ritratto del tennista-prototipo) ‘è un uomo completo, sebbene in modo grottescamente limitato’

L’obbligo di stare a casa imposto dalle contingenze della pandemia di COVID-19 – miliardi di persone sono in isolamento, e figurarsi che ora si è aggiunta anche l’India – si è vestito di alcune implicazioni che vent’anni fa non avremmo neanche potuto sospettare, e dieci anni fa (nonostante i primi segnali) ci sarebbero comunque sembrate difficili da raggiungere.
Di questo isolamento, stiamo documentando tutto. Eravamo 90 milioni al mese su Instagram sette anni fa, meno degli abitanti dell’Egitto, oggi siamo un miliardo: se gli utenti mensili di Instagram fossero un paese, sarebbero il terzo più popolato del mondo dopo Cina e India. C’è di più: se gli utenti attivi di Facebook, Youtube e WhatsApp (dati statista.com) avessero un territorio e dei confini, sarebbero i tre stati più abitati del mondo. Facebook e Youtube sfondano il tetto dei due miliardi di utenti, per darvi un’idea.
In un momento in cui sembra quasi ci sia concesso di fare soltanto quello e abbiamo moltissimo tempo per farlo, la nostra attività sui social dice di noi molto più di quello che crediamo. Rivela la nostra resistenza alla noia, le armi con cui combattiamo la disperazione, persino la capacità di tradurre questa sciagura in opportunità. Qui entrano in gioco gli atleti, un esercito di fibre muscolari ben allenate il cui tasso di disoccupazione, al momento, sfiora il 100% – salvo eccezioni perlopiù calcistiche: si gioca in Bielorussia, Birmania, Nicaragua e si fanno amichevoli in Svezia. I tennisti non fanno eccezione, sono tutti a casa.
Li stiamo vedendo: Djokovic fa Capitan Uncino coi figli, Nadal dimentica di sbarbarsi e si diverte in cucina (senza piano a induzione, fanno notare i modernisti), Sinner si inventa un modo simpatico di fare beneficenza mentre gli altri italiani (Travaglia e Sonego su tutti) tengono fede ai principi costituzionali impastando e panificando. Fognini no, si taglia i capelli e lancia una delle challenge che oggi vanno tanto di moda. Sono gli intrattenitori-raccontatori, una fronda che ha trovato in Kristie Ahn (27 anni, ottavi all’ultimo US Open, rimembrate?) un autentico spirito guida: fenomeno assoluto dell’intrattenimento virtuale, se volete approcciarvi a Tik Tok in modo discreto seguite lei.
C’è anche chi esagera. Stan Wawrinka ormai viaggia al ritmo di due dirette Instagram al giorno, chiama a rapporto quell’altro perdigiorno di Paire e si scambiano frammenti di taedium vitae che viene da sperare possano tornare a giocare presto, altrimenti quando li recuperi più questi. Ci sono gli introspettivi – Tsitsipas, Serena, anche Berrettini – che invocano un senso di responsabilità mondiale per sconfiggere la pandemia, quelli che tirano fuori le fotografie di quando erano bambini, quelli che si amano da pazzi e non lo nascondono: siate onesti, non vorreste tutti voi un idillio come quello di Marcos Baghdatis e sua moglie Karolina?

E poi c’è Andrea Petkovic. Laddove gli altri si raccontano, lei prova a istruire; mentre gli altri passano il tempo, lei ci coinvolge nel suo. Certo ci mette anche a parte del suo workout, recita la scena di un film chiedendoci di indovinare quale sia (è Gary Oldman in Leon, un film francese che oltre a lanciare Jean Reno ha inaugurato la carriera di quell’insana portatrice di grazia che è Natalie Portman) e svolge persino servizio pubblico facendo il debunking a Bernard Tomic, che aveva detto di avere tutti i sintomi del coronavirus: “Gli ho scritto e mi ha detto di aver mentito e che non sa neanche perché l’ha fatto: è tutto normale, è Tomic“. E chi crede che quest’attività non sia necessaria, pensi al fatto che una piccola fetta d’Italia ha creduto all’istante che un servizio televisivo del 2015 potesse spiegare l’origine in laboratorio di un virus del 2020.
Ecco, oltre a fare queste cose Andrea – laureata in scienze politiche e laureanda in filosofia e letteratura, oltre che conduttrice televisiva su ZDF – ha anche creato un club del libro su Instagram, il Racquet Book Club, per inaugurare il quale ha scelto quattro titoli da mettere ai voti: il preferito dai suoi follower sarebbe diventato oggetto di discussione e lettura collettiva. Ha vinto con largo margine String Theory di David Foster Wallace, una raccolta di cinque saggi tennistici che come il disco di una rockstar mutua il nome dal singolo più riuscito, che in questo caso è l’omonimo affresco di Michael Joyce (ex n.64 del mondo, forse più famoso per aver allenato e condotto al successo Sharapova) commissionato a Wallace dalla rivista ‘Esquire’ nel 1996. Lo potete leggere qui, in lingua originale, ma lo trovate anche tradotto nella raccolta ‘Tennis, tv, trigonometria, tornado (e altre cose divertenti che non farò mai più)’. Amazon va un po’ a singhiozzo con le consegne, ma con l’e-book andate sul sicuro.
È uno scritto di una bellezza stordente. Oltre a contenere descrizioni memorabili di alcuni tennisti – citiamo quella di Richard Krajicek, che secondo DFW ‘si lancia verso la rete come se questa gli dovesse dei soldi‘ – è la miglior cosa che possa capitarvi di leggere per capire cos’è un tennista al di fuori del tennis, ovvero quali possibilità in termini di interessi, curiosità nei confronti del mondo e sviluppo culturale rimangano a chi sia costretto a dedicare a quest’attività maniacale metà delle ore di veglia dai dodici anni fino al giorno del ritiro. Ed è esattamente il tema che emerge da questo isolamento forzato, dove i tennisti vengono spogliati della loro principale attività e ci vengono consegnati per quello che sono – e sono sempre stati: esseri umani, con passioni e tempo libero da riempire.
Esseri umani ai quali abbiamo sempre chiesto, in modo a volte ingeneroso, di stupirci in conferenza stampa, di non essere banali, di offrirci un punto di vista sensato in risposta a ogni nostro quesito nonostante fossero reduci da battaglie di tutt’altro tipo e occupassero le loro giornate a cercare ossessivamente di trovare un modo per vincerne il più possibile, mica a sfogliare manuali di sociologia. Wallace si è imbattuto in questo equivoco trascorrendo una mezza estate con Joyce, e lo ha descritto così:
“Fate caso al modo in cui i ‘ritratti personali dietro le quinte’ degli atleti si sforzano il più possibile di trovare prove di un’esistenza completa, di interessi e attività al di fuori dello sport. Ignoriamo ciò che è ovvio, che la maggior parte di questo sforzo è una farsa. È una farsa perché la realtà di un atleta di alto livello oggi richiede un impegno precoce e totale per eccellere in un settore. Una concentrazione ascetica. Il sacrificio di tutti gli altri aspetti della vita umana in funzione di quello scelto e perseguito. Il ‘permesso’ di vivere in un mondo che, come quello di un bambino, è molto piccolo“.

E poi ancora, tracciando con precisione assoluta i contorni della figura di Joyce:
“In quello che Michael Joyce dice, trovi raramente un qualche tipo di angolazione o di punto di vista; per lo più, riporta semplicemente quello che vede, come una macchina fotografica. Non potresti neanche chiamarla sincerità, perché non è che sembri mai passargli per la testa di cercare di essere sincero o insincero. Per un po’ ho pensato che il candore un po’ mellifluo di Joyce fosse una conseguenza della sua scarsa intelligenza. Questo giudizio era in parte influenzato dal fatto che Joyce non è andato al college ed è stato solo marginalmente interessato alle materie di studio durante le superiori (cose che so perché me le ha dette lui da subito). Quello che ho scoperto, man mano che il torneo andava avanti, è stato che certe volte riesco ad essere abbastanza snob e testa di cazzo, e che la schiettezza non ostentata di Michael Joyce non è un segno di stupidità ma di qualcos’altro“. Ovvero, di quella dedizione ascetica sopra descritta.
Wallace concluse il saggio dicendo che per Joyce, a ventidue anni, era già tardi ‘per qualsiasi cosa’ che non fosse quel già citato qualcos’altro. “Joyce, in altre parole, è un uomo completo, sebbene in modo grottescamente limitato“.
Parole che il diretto interessato non aveva ben compreso in prima istanza, a reportage appena uscito, ma che a distanza di tempo avrebbe perfino apprezzato: “Anni dopo, quando uscì il libro che lo conteneva, ero più vecchio e più maturo” ha raccontato Joyce. “Ho cominciato a guardare a quella ‘cosa’ in maniera differente: era un saggio stupefacente. Finalmente, riuscii a vedere il genio nella sua scrittura. Poi Wallace divenne una leggenda della narrativa e oggi è incredibile pensare di essere, in qualche maniera, legato per sempre a lui”. E allora forse Wallace, pur fastidiosamente lucido in ogni sua esternazione, non aveva del tutto ragione sul fatto che per Joyce fosse tardi per qualsiasi cosa. Non lo è stato per comprendere se stesso attraverso le parole di un estraneo, seppure illustre.
Se però accettiamo il pensiero di Wallace come regola, e ci sono pochi motivi per non farlo, sappiamo anche come considerare Andrea Petkovic – che ha stimolato questa riflessione: un’eccezione. Quanto replicabile? Difficile dirlo, senza trovarsi nella posizione di chi colpisce rovesci per una vita e poi a un certo punto si ritrova costretto in casa, con le racchette in un armadio e i muscoli impigriti da un’attività fisica soltanto domestica.