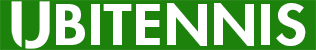Rassegna stampa
Laver: “La mia racchetta e batto Federer” (Piccardi). Berrettini, evoluzione della specie azzurra (Semeraro). Berrettini, arriva subito l’esame Simon (Scanagatta). Santopadre: “A volte pensa troppo. Ma nel 2019 sarà al top” (Crivelli). Le prime sfide in Pagano e la divina Suzanne Lenglen (Clerici)

Intervista a Rod Laver: “La mia racchetta e batto Federer” (Gaia Piccardi,Corriere della sera)
[……..] Nato a Rockhampton, nel Queensland australiano, quasi 8o anni fa (li compie il 9 agosto, sotto il segno del Leone, e questo spiega molte cose), terzo di quattro figli di un mandriano, Rodney George Laver detto Rod è, probabilmente, il più grande tennista di tutti i tempi. Undici titoli Major, 5 Coppe Davis ma soprattutto due Slam (’62 e ’69: l’anno prossimo ne ricorrerà il cinquantenario), quelli veri, cioè i quattro grandi tornei inanellati nello stesso anno solare, roba che nemmeno il maestro onnivoro Roger Federer è mai riuscito a digerire. Come ci si sente ad essere il migliore, Rocket? «Invecchio a vista d’occhio, sono superato dagli eventi ma felice di essere vivo e di poter assistere alla più straordinaria rivalità della storia dello sport, quella tra Federer e Nadal» risponde la tartaruga sotto una peluria biondiccia, figurina minuscola dentro una sedia che pare un transatlantico. Ha le mani adunche per l’artrite, l’apparecchio acustico, il naso irrimediabilmente scorticato dall’impietoso sole australiano benché da anni risieda a Carlsbad, in California, nella villa sul mare in cui nel 2012 e rimasto vedovo dell’amata moglie Mary, madre di Rick, l’unico figlio della coppia. È sopravvissuto alle due ere geologiche del tennis — amatoriale e professionistico —, a un ictus, a un mancinismo ante litteram, alla sua stessa leggenda. Si è inventato la stagione perfetta, l’ultima su questo piano di un bipede dotato di racchetta, nell’era Open: «Eccome, se mi ricordo quel 1969. Lo spagnolo Gimeno in finale a Melbourne e poi tre connazionali di fila: Rosewall a Parigi, Newcombe a Wimbledon, Roche a New York. Mi chiedo se un tennista avrà mai più un anno così. Ne dubito». Non c’è mai superbia, nelle parole di Laver… [SEGUE]. Senza Rocket e il suo polso sinistro forgiato dai maniscalchi dell’Olimpo non sarebbero esistite le volée sublimi di McEnroe, i razzi al servizio dei grandi battitori, il drive metallico di Jimmy Connors, l’aggressività nevrotica e mancina di Rafa Nadal, attuale numero uno del mondo. Rod sorride scrutando l’orizzonte di fragole e panna. «Vede, cara signorina, ai miei tempi era tutto diverso: racchette, campi, fisicità degli atleti, gioco, montepremi… Però le confesso che mi sono goduto ogni secondo. Alla fine della giornata, lo scopo era lo stesso: battere gli avversari per assicurarsi un trofeo. Nella mia carriera sono riuscito a vincere qualche torneino ma secondo me il miglior tennista della storia è Roger Federer. Il modo in cui gioca, oddio, mi dà i brividi. La sua concentrazione, l’approccio al match, quello stile inimitabile… A quasi 37 anni (li compie un giorno prima di me!) è incredibile il livello a cui sa ancora elevarsi». Eppure, da queste parti, tutti si inchinano a Rod. Commentatori, grandi ex, coach, idoli pagani. Non ce n’è uno che passi oltre senza omaggiare Mister Laver, abbeverandosi per un istante al suo carisma. Gli anni buttati da amatore, che spreco signor mito: «Ma no, va bene così. Ho viaggiato in tournée con Rosewall, Hoad e Gonzales. Quando sono entrato nel tour, nel ’68, ero un giocatore più completo». Quel serve and volley divino chi l’ha ereditato? «Nessuno. I campi erano pessimi, la palla rimbalzava da schifo. Se la colpisco al volo mi faccio un favore, mi sono detto. Avevo ragione». Tra il miglior Laver e il miglior Federer chi vincerebbe? «Date a Roger una racchetta di legno e vediamo cosa ne tira fuori…» (risata vezzosa, senza esagerare). L’Italia le manca? «Oh, Nicky Pietrangeli a Roma, tra dolce vita e partite al Foro Italico, era un padrone di casa fantastico: che spaghetti indimenticabili…». Il ricordo più bello in assoluto? «Wimbledon ’62, la premiazione con Elisabetta II in guanti bianchi, colbacco e triplo filo di perle sul campo centrale. Qualche parola fugace, ma indimenticabile…»… [SEGUE].
Berrettini, evoluzione della specie azzurra (Stefano Semeraro, Corriere dello sport)
«One of a kind», dicono gli inglesi: un pezzo unico, uno che fa categoria a sé. Matteo Berrettini a 22 anni non solo è uno fra i più giovani azzurri di sempre a vincere un titolo, e uno dei pochi nella storia Open ad agguantare sia singolo sia doppio nello stesso torneo, ma rappresenta anche una tipologia più unica che rara nel nostro tennis. Intanto per l’altezza: 1,93. Poi per il tipo di gioco: completo ma moderno, imperniato su diritto aggressivo e servizio percussivo, i pilastri del “big game” che il leggendario Jack Kramer predicava già negli mini ’40. Orlando Sirola sfiorava i due metri, ma da fondo era una scommessa. Ornar Camporese è alto 1 e 88, come il suo compagno di doppio a cavallo fra anni ’80 e ’90 Diego Nargiso, il diritto (e il servizione) lo martellava forse ancora di più, ma non aveva la mobilità di “Beretto”, mentre Diego era soprattutto un giocatore serve&volley. Potito Starace tocca l’1 e 87, ma con il servizio puntava molto sulla continuità e ha scorrazzato soprattutto sul rosso. Matteo invece mette insieme maturità – anche se mescolata qua e là a qualche crisi autopunitiva da eccesso di perfezionismo e uno stile di gioco perfettamente intonato ai tempi, universale e multitasking. Oggi anche a livello mondiale vanno i fisici da cestista, alla Sascha Zverev (1,98) alla Marin Cilic (1,98) o alla Nick Kyrgios (1,93) asciutti, elastici, potenti e allungati; e, del resto, una delle semifinali di Wimbledon ha raggiunto come altezza complessiva i 4 metri e 11: i 2 metri e 3 di Kevin Anderson più i 2 e 8 di John Isner. Proprio Long John e l’Anderson visto contro Federer ai Championships, sono l’esempio di come però per eccellere l’altezza vada accompagnata ad una mobilità più che sufficiente e a una “fase difensiva”, come direbbero gli esperti di calcio, comunque valida… [SEGUE]. Berrettini per il momento ha una mano un filo meno fatata, ma sa comunque estrarre back avvelenati dal rovescio – che ora colpisce comunque con più sicurezza anche in top e piatto – smorzate di grande bottega e, soprattutto, giocate quasi sempre con i tempi giusti; e una tigna nei recuperi che in finale contro Bautista Agut ha fatto la differenza. Il tutto innestato su un telaio decisamente deluxe, adattabile a terra e cemento, capace di esprimere al servizio velocità oltre i 220 l’ora e una percentuale stagionale di 75 punti vinti con la prima palla. Il tennista del Terzo Millennio. E questa volta è un prodotto Made in Italy.
Intervista a Vincenzo Santopadre: “A volte pensa troppo. Ma nel 2019 sarà al top” (Riccardo Crivelli, Gazzetta dello sport)
Il nuovo mondo di Matteo Berrettini riparte da Kiztbuehel, dove oggi ritroverà il francese Simon che lo ha battuto a Wimbledon. Un altro passo sotto l’occhio vigile di coach Vincenzo Santopadre, l’uomo che insieme a Umberto Rianna sta costruendo un campione. Vincenzo, aveva previsto la piena maturazione di Matteo a 24 anni. Ne ha due di meno: non è stato buon profeta… «Meglio così! In realtà anche se adesso la classifica è da giocatore vero, quest’anno gli deve servire per fare esperienza e capire quali dettagli vanno migliorati per crescere ancora. Sarà la prossima stagione a misurare il valore di Matteo a questi livelli. Non dimentichiamoci che prima di gennaio non aveva ancora vinto una partita ATP». Dove può migliorare? «In tutti e quattro gli aspetti che fanno un giocatore completo: quello tattico, di lettura delle varie situazioni; quello tecnico, ad esempio la seconda palla che deve diventare più incisiva, il rovescio lungolinea e il gioco a rete; quello fisico, se consideriamo che fa doppi allenamenti solo da quest’anno; quello mentale, di reazione immediata ai quesiti che la partita sta ponendo». Però se c’è una dote che colpisce di Matteo è proprio la solidità mentale. «È vero: soprattutto, Matteo è un ragazzo che sa ascoltare e non spreca nulla del tempo che dedica al tennis, si applica anche negli ultimi cinque minuti dell’allenamento. Ma ovviamente gli mancano partite di grande livello con continuità, per questo ha molti margini anche nella tenuta mentale». Lei lo prese a 14 anni: che ragazzo trovò? «Con una buona propensione a colpire di dritto e voglia di apprendere, ma fisicamente davvero indietro. Poi è cresciuto molto in altezza e questo lo ha reso vulnerabile agli infortuni, per questo non ho mai spinto la preparazione. E poi come tutti i ragazzini faceva un po’ il bulletto in campo, ma io su quello sono intransigente: all’inizio l’ho un po’ forzato»… [SEGUE]. Lo troviamo un difetto a Matteo? «È disordinatissimo! Seriamente, a volte è troppo razionale e pensa troppo. Perciò a maggio, di fronte a una stagione così intensa, ha un po’ perso l’equilibrio mentale. In romanesco gli ho detto “Scialla”, stai sereno e prenditi un po’ di vacanza. È anche la ragione per cui ho saltato gli ultimi due tornei, non volevo caricarlo troppo. Qualche volta, deve imparare a prendere le cose più alla leggera». Come vive i successi degli altri italiani? «Deve viverli come uno stimolo e non come una rivalità ansiogena. Il tennis è uno sport individuale, ma è fondamentale avere amici fuori dal campo con cui fare gruppo: serve appunto a creare quella leggerezza di cui parlavo prima. Gli spagnoli vanno a cena tra di loro, è un esempio illuminante».
Berrettini, arriva subito l’esame Simon (Ubaldo Scanagatta, Quotidiano nazionale)
Un entusiasmo dilagante in tutta la penisola, per il primo titolo vinto a Gstaad da Matteo Berrettini, dopo dieci set dominati su cinque avversari (tra cui un top 50 e un top 20), senza mai cedere il servizio in 49 turni, per i 17 ace della finale sull’esperto Bautista Agut, per i sei ace in un solo tiebreak, quando i punti contano il doppio e chi li fa deve essere per forza solido di nervi e testa, oltre che di braccio. Dopo 40 anni di penombra competitiva, se non proprio di buio, il tennis italiano torna a sorridere grazie a questi giovani, Berrettini e Cecchinato, che in due mesi ci hanno regalato inattesi exploit. Non sono come gli altri. E per Berrettini sono finiti i viaggi in camper, con papà autista e mamma a sfornellare fra un torneo e l’altro. “Devo tutto a loro” riconosce da bravo figlio. Fognini resta il nostro n.1 (n.15 ATP), e forse quello con maggior talento naturale, ma a 31 anni difficilmente potrà liberarsi della propria discontinuità. Chi ha più margini di progresso fra il n.22 ATP “Ceck” di 25 anni e 10 mesi “esploso” un po’ tardi — era n.109 a gennaio – e il “Berretto” di 22 e 3 mesi, oggi n.54, che due anni fa a causa di un infortunio aveva perso 6 mesi ed era sceso a n.883? Berrettini è atteso oggi alle 15 a Kitzbuhel da un avversario difficile come Gilles Simon, ex n.6 ATP, e a 33 anni n.40, dal quale ha perso a Wimbledon. Dura, durissima. E sui prossimi tornei sul cemento? Anche Cecchinato serve molto bene, un po’ meno però di Berrettini. Però ha un rovescio stupendo, si muove meglio, forse ha più fisico. Pero sul cemento non si è quasi mai esibito. Temeva di giocarci male. Anche a Berrettini serve il tempo che gli dà la terra rossa per girare attorno alla palla e bombardare di dritto. Ma entrambi potrebbero avere, grazie al servizio, più armi che non il “piccolo” Fognini. Stanno entrambi facendo passi da gigante. Mia opinione? Oggi forse è più completo Cecchinato. Domani vedo più Berrettini. Son comunque rose e fiori… azzurri.
Le prime sfide in Pagano e la divina Suzanne Lenglen (Gianni Clerici, Repubblica)
A Wimbledon, così come a Newport, nel Rhode Island, esistono musei del tennis, con le loro brave biblioteche. Da noi non c’è niente, esiste soltanto la volonterosa Maria Canella, che sta tentando di digitalizzare testi che dovrebbero apparire in un presunto museo del Tennis, collocato al Tennis Ambrosiano, e solo fotografico. Una collezione che sollevò l’entusiasmo del bibliotecario di Wimbledon, il povero Alan Little, si trova peraltro a casa del cronista, nota soltanto ai super aficionados, che vengono di tanto in tanto a consultare un testo di una vecchia lista. Mentre la collezione del mensile inglese Lawn Tennis inizia nel 1896, il nostro Tennis Italiano entra in tipografia soltanto nel 1929. Oltre che in direzione di quotidiani distratti o male informati, la ricerca si orienta quindi verso la tradizione orale, con tutte le certezze, ma anche il fascino, di una storia narrata ai pronipoti. Tra i vecchi informatori, un ruolo privilegiato ha svolto Rosetta Gagliardi. È stata, Rosetta, una sorta di istituzione della prima metà secolo. Campionessa d’Italia, nel 1919, andò sposa a un neozelandese di casa a Milano, George Prouse, che divenne uno dei principali costruttori di racchette nazionali, le celebri Maxima. Ebbero un figlio, i Prouse, Johnny, che riuscì nell’impresa di diventare campione junior in Italia, e al tempo stesso di Gran Bretagna. Giunto tanto avanti, Johnny si impose in un altro gioco, si trasformò in uno dei più brillanti insegnanti del Politecnico. Rosetta si diceva soddisfattissima di quel suo unico figlio, che aveva preferito gli studi al tennis. Sul visetto arguto, gli occhi brillavano nel raccontare favole tennistiche di tempi che si allontanavano… Al di fuori di qualche campo privato, in villa, la prima sede del tennis milanese sorse su un terreno affittato dal Comune, in via Mario Pagano, un ritaglio del parco fronte alla chiesa del Corpus Domini. Era il 1883. Il presidente, il conte Felice Scheibler, sorvegliò personalmente la costruzione di cinque campi in terra e di uno chalet alla svizzera, un solo piano con un piccolo soggiorno e due spogliatoi minimi. L’affluenza dei soci non richiedeva, in realtà, spazi come quelli del Castello Sforzesco, dove Ludovico il Moro aveva giocato a “rachetta” nella Sala della balla. La prima coppa in argento, offerta dal conte Scheibler, vide la partecipazione di soli cinque tennisti. Nel 1883 la vinse il barone Davide Leonino su Tom Antongini, che prese la rivincita nei due anni successivi. Antongini era uomo di lettere, tipo vanitoso se mai ce ne fu uno, come dimostrarono i suoi diari, le amabili avventure di un sedicente zio Gustavo. Sarebbe stato, tra le sue molte attività, segretario di Gabriele d’Annunzio, che frequentava il club, ma non lasciò traccia di sé nei tornei sociali. Nel 1884 era intanto nata l’Associazione Italiana di Lawn Tennis, che fece disputare il campionato 1897 proprio a Milano. Con viva delusione degli spettatori i tennisti indigeni furono sconfitti dal romano Lionello Hirschel De Minerbi che aveva un solo rivale in Italia nel concittadino Gino De Martino, un tipo capace di tuffarsi nel Tevere in sella alla bicicletta, a Capodanno. Nel 1898 i nostri eroi milanesi furono duramente sconfitti dal primo straniero giunto al club, Patrick Neville, un uomo d’affari inglese. Tutta la Milano elegante ripetè per qualche giorno la frase del povero Leonino, che aveva raccattato pochi game nella finale: “El’ha batu, e el sta chi du ann!”. Il vincitore del 1903, Alberto Pirelli, fu costretto a sloggiare insieme agli altri soci da una “giunta radicale “, che si rifiutò di rinnovare l’affitto. Gli aristocratici tennisti dovettero dapprima accamparsi attorno a soli tre campetti in via Alberto da Giussano, e trasferirsi poi a un tiro dal campanile della Cagnola, in uno squarcio agreste così ricordato dal conte Alberto Bonacossa nel suo manuale: «Gli smashes finiscono nel vicino campo di insalata». Da quell’esilio arcadico, il circolo fu tratto dal nuovo presidente, il conte Castelbarco, forse più facoltoso, certo più munifico del past-president Davide Leonino. Castelbarco non perdeva occasione per imbandire tavole nella nuova sede in via Domodossola, intorno a cinque campi, due dei quali dotati di out internazionale e riservati alle gare. «C’era addirittura una doccia per gli uomini, mentre noi signore dovevamo accontentarci di un lavabo, con la scusa della pudicizia» ricordava la mia giudiziosa informatrice che, con le consocie, si sarebbe presto trasformata in dama caritatevole, impegnatissima nel confezionare calzerotti e maglioni per i tennisti impegnati al fronte. Sulle pareti della piccola club-house venivano appuntate cartoline scherzose, magari in rima: «È più facile sparar sul Malborghetto / che colpire di smash un pallonetto». Alla fine, cinque soci non sarebbe tornati. Ad uno di loro, l’aviatore Gilberto Porro Lambertenghi, sarebbe stato in seguito dedicato il campo centrale del Tennis Club Milano, voluto da Alberto Bonacossa, presenza determinante nella vicenda del tennis milanese. Pattinatore, scalatore, alpinista, cacciatore, ballerino sfrenato e infine tennista, il conte Alberto era mosso da grande ambizione, ma anche da un vivo spirito conviviale: rivolto, beninteso, alla classe dirigente. Già dal 1914, il Conte si era buttato su un’idea fondamentale perla diffusione del gioco, la creazione di un manuale che sostituisse quello tradotto dall’inglese per i tipi di Hoepli nel 1898. Insieme al marchese Porro Lambertenghi, il conte Alberto vi annotava pensieri di estremo buon senso, difendendo lo sport diletto. «Il tennis non è, come volgarmente si crede, un semplice gioco da signorine. Abbiamo praticato gli sport più duri, e senza tema di errare il tennis non la cede a nessun confratello…. il corpo e la mente sono spesso messi a durissima prova!». Il Conte si diffondeva sulla necessità di sprovincializzare il nostro tennis, di attirare campioni stranieri per darla sveglia ai nostri «pochi dei quali, di buona volontà, han cominciato a distinguersi nella vicina Svizzera». Le idee di Bonacossa avrebbero trovato corpo nella costruzione del club che oggi porta il suo nome, in via Generale Arimondi. «Per la primavera del 1923 la nuova sede progettata dall’ingegner Giovanni Muzio verrà aperta» annunciava con giusto orgoglio il conte Alberto. «La vecchia sede, troppo angusta e rumorosa, con i suoi campi preparati in polvere di strada (ormai universalmente bandita) non potevano prestarsi ad alcuna trasformazione. I nuovi campi, in numero da otto a dieci, verranno seguiti dal più noto specialista europeo appositamente chiamato… Un campo tribuna permetterà di organizzare incontri importantissimi…». Il club sarebbe stato puntualmente inaugurato nel 1923, con un match Italia-Belgio. Il campo centrale avrebbe dovuto attendere il 1929, e con i suoi tremila posti avrebbe svettato sugli altri, su Torino, Genova, Roma. Nell’attesa, Bonacossa avrebbe ospitato i grandi del gioco, prima fra tutti la divina Suzanne Lenglen, nel 1926. Suzanne fu probabilmente la più grande tennista mai esistita, e certo la prima grande star del gioco fra le due guerre. Gli spettatori milanesi ebbero difficoltà a credere a quanto affermava la Gazzetta dello Sport, che l’attivissimo conte Alberto aveva acquistata nel 1928. «Nei giorni precedenti il torneo di Wimbledon, le carrozze tramviarie inalberano un cartellone di reclame recitante la scritta Suzanne has arrived, Susanna è arrivata». Eccessi simili, a Milano, li avevano provocati solo le grandissime cantanti! La visita della Lenglen non provocò sommosse popolari, ma attrasse comunque al circolo il pubblico che, a Sant’Ambroeus, si ritrovava nel foyer della Scala. C’erano, tra gli altri, a rappresentare i reali, il Duca di Bergamo e il Duca d’Aosta, spesso compagno di doppio di Bonacossa.