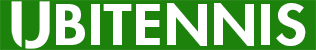evidenza
Gianni Clerici e quel bar sospeso tra tennis e tempo
Omaggio al più grande scrittore che il tennis abbia mai avuto, e che mai avrà

Clicca qui per i commenti di Ubaldo Scanagatta alle finali del Roland Garros 2022
Gianni Clerici è morto ed io l’ho cercato a lungo quel foglietto di carta. Non l’ho trovato. Non è sopravvissuto ad almeno tre traslochi: quelli che, scatolone dopo scatolone, mi hanno separato dalla gioventù. Lo conservavo in un foglio di plastica insieme al biglietto di un concerto degli Emerson Lake & Palmer. Era l’estate del 1996: bizzarro a dirlo, ma quel concerto si svolse al Foro Italico.
È andato perduto e ne ricordo solo alcune frasi, le più ispirate. Lo avrò letto decine di volte, ma non l’ho mai studiato né mai mandato a memoria. Quando hai vent’anni, i tuoi vent’anni sembra che non ti possano mai sfuggire: figurati se ne prendi un pezzo e lo metti sotto cellophane perché duri ancor di più.
Quel foglietto era un ritaglio di giornale, de La Repubblica. Un articolo delle pagine sportive, un fianco destro di una pagina attorno al numero 30. Il pezzo dell’inviato al Roland Garros che raccontava di un incontro tra Stefan Edberg e Michael Chang, svoltosi il 1 giugno del 1996, sette anni dopo un’incredibile finale e pochi mesi prima del ritiro del leggendario svedese. Il mio svedese, quello che ha avuto le chiavi della mia felicità da adolescente prima di passarle a una lei che non le avrebbe mai usate.
Ma quel foglietto, oltre a riportare il risultato della sorprendente vittoria di Edberg, portava anche la firma di Gianni Clerici, ed io non lo conservavo per il tennista, dei due quello ancora in attività. In fin dei conti cos’era quel match? Un terzo turno di un torneo in cui il mio beniamino avrebbe perso due giorni dopo. Perché conservare le gioie andate così presto a male?
Perché leggendo e rileggendo quelle parole non contemplavo più il capolavoro tennistico e contemplavo uno, dei tanti, capolavori del celebre dott. Divago. Quello che ho amato di più, più persino dei suoi libri. Quando avevo tra le mani quel ritaglio, smettevo di contemplare una partita che era già passata e mi fermavo a contemplare la descrizione di un amore. Anzi di due amori: uno per il tennis ed uno per il tempo, che lento o celere, ci porta fino in fondo.
Lo conservavo per Clerici, il quale oltre a passare anche lui quel terzo turno, avrebbe superato ogni tipo di finale, fino ad issarsi in una Hall of Fame cui dedicò l’unico momento di imbarazzo e timidezza che ho mai potuto scorgere sul suo viso. Conservavo quell’articolo perché capivo che anche parlando di caucciù, di mattone, grafite e sudore, si può e si deve parlare di storie. Le storie le fanno gli uomini, e le raccontano gli uomini. Senza eroi non ci sono storie, e senza bardi non ci sono eroi.
Ora che Clerici non c’è più, e che probabilmente riposa insieme a quel ritaglio di giornale, mi sembra di aver smarrito la sua unica eredità.
Siamo però nei tempi di internet. Con due click e pochi passi di tastiera, in cinque minuti quell’articolo è sotto i miei occhi. Vorrei tanto che fosse anche sotto gli occhi di chi mi legge.
Vederlo online, tratto da un archivio, non ha nulla del grigio di giornale che va ingiallendosi. Manca la foto di Edberg che sollevava un mezzo pugno in trionfo. Ma il 2 giugno del 1996, tra l’Italia che preparava gli europei di calcio e la mucca pazza che apriva la strada al coronavirus, Gianni Clerici scriveva queste parole.
“Nella sua lunga e sentimentale tournée che precede un annunciatissimo ritiro, Stefan Edberg è riuscito nell’impresa di battere Michelino Chang”.
Stefan, lo ha chiamato Stefan. Non Stefanello, come lo aveva chiamato per gli ultimi dieci anni. Chang, lui era Michelino. Edberg, no. Anni passati a vezzeggiare il suo prediletto dell’epoca, ed ora, d’improvviso, Edberg era cresciuto, si era riappropriato del suo nome. Chang no, Stefan sì, e da sempre mi chiedo il perché.
Clerici, ricordando la storica finale del 1989:
“Aveva battuto, in cinque set omerici, quell’ altro acrobata di Boris Becker, e si trovava di fronte il più inatteso degli avversari. Un cinesino di passaporto americano appena diciassettenne, un omino alto meno di un metro e settanta, assistito in tribuna dalla mamma e, a credergli, da Geova su nell’ alto delle nubi. Questo Pollicino si era liberato di un gigante come Ivan Lendl mandandolo in furore, irridendolo con servizi dal basso e altre birichinate tipiche dell’età”.
Clerici non era Gianni Brera, al quale molti lo associavano e che alcuni giudicarono suo erede. Il linguaggio di Clerici era leggero, favolistico, non pagava alcun pegno a Gadda, né voleva stupire. Non sentivi il sapore della grappa o del whisky di malto nella sua voce. Il racconto di Clerici si adagiava sul vento e sulle nuvole che minacciavano pioggia e sospensione del gioco, non su di un panno verde circondato da nuvole di Gauloises. Clerici, poi, non era popolare, non raccontava il tennis con la pretesa di essere compreso da tutti. Non era didascalico ed alle volte gli bastava l’impressione. Raccontava il gioco, anche quando raccontava altro. Divagava e da questo ne trasse un soprannome, eppure tutto faceva parte del gioco: pur potendo apparire che la partita del giorno prima non l’avesse neppure veduta, tutte quelle barchette di pensieri in qualche modo tornavano al match, al gioco.
Clerici, parlandoti e scrivendo come lui faceva, in un’epoca in cui i social non esistevano, ti faceva credere che quel bar che da tempo cercavi, quello che iniziavi a pensare non esistesse, ti avrebbe accolto, e fatto parlare delle cose che volevi sentire ed ora quel bar è sospeso in mezzo al cielo. Gianni Clerici ti riusciva a far entrare in un circo fatto di memorie, di personaggi bizzarri e surreali. Tutto era rifratto in uno specchio magico da attraversare, e quando giungevi alla tana del Bianconiglio, finalmente ti potevi epurare di tutta quella assurda modernità. Proiettato in un girotondo dal quale non volevi uscire, tenevi per mano la sue storie: Jaroslav Drobny, il Barone Von Cramm, Tilden e la Lenglen, in un campo centrale coltivato a foglie di tè.
Stefan, e non Stefanello, contro Chang era sotto nel punteggio quel 1 giugno 1996.
“Ma da quel momento, che pareva giusto l’inizio di una dignitosa sconfitta, Edberg sembrava trovare ispirazione. Diventavano, i suoi servizi, sempre più precisi, penetranti. Si trasformavano, le volée di rovescio, nell’antico specchio magico atto a folgorare lampi di luce iridescente. Su un buonissimo Chang si rovesciavano ondate crescenti di creatività, ancor prima che palle imprendibili”.
Io non ho mai conosciuto di persona Gianni Clerici. Non ho una foto con lui mentre sorrido come un deficiente. Se avessi una foto con lui, in quella foto io sorriderei come un deficiente. Ricordo di averlo però visto a Wimbledon nel 2010, lo Scriba. Chino su di un computer attraverso una pettegola finestra della sala stampa. Mentre alle mie spalle si giocava, mentre il campo 1 scrosciava di applausi per due chiunque, io restavo fisso ad ammirarlo, a fare il voyeur come mi aveva insegnato a fare lui. Così mi trovai a spiegare alla mia spaesata e futura moglie, che del tennis nulla sapeva, il mio incanto. Ed impiegai, per raccontarle Clerici, più tempo di quello impiegato a spiegarle chi fosse Federer, chi fosse Nadal, cosa fosse Wimbledon, che ci facessimo là e un giorno cosa avremmo fatto insieme.
Credo di averle detto che nessuno saprà mai scrivere di tennis come ha saputo fare Gianni Clerici. Perché quando Clerici scriveva di tennis, lo faceva respirandolo, attraverso branchie invisibili che filtravano i gesti, una scossa elettrica, in un brivido ininterrotto che parte dal rumore della pallina ed arriva alle dita che spingono i tasti di un computer. Scriveva con naturalezza quel che era o era stato, come si racconta la storia buffa di un amico imbranato o quella contrita di un figlio somaro.
Edberg vinse la partita contro Chang. Tutto terminò, così.
“Non solo era presto un set pari, Edberg, ma addirittura dilagava nel terzo, dopo che il povero Chang era stato assistito dal fisioterapista per un dolorino ad una costola fluttuante. Ci domandavamo, con Tommasi, entrambi increduli, fino a quando sarebbe continuata quella musica celeste. Avrebbe fatto tutto il possibile, Changhettino, per sabotare quella grande dimostrazione, avrebbe addirittura tentato di sgraffignare un par di punti. Ma non c’ era proprio modo, contro uno Edberg eguale all’Edberg di una volta, miracolosamente ventitreenne, inebriato da un misterioso elisir. Il desiderio di chi, come lo scriba, lo ama davvero, sarebbe di ricordarlo in questa sua luce di gloria, senza vederlo mai più sul campo”.
Sono senza cappello da alcune ore. Leggo una fine scritta da Gianni Clerici e rileggo quella che ho scritto io, indegnamente. Tanti parlano di tennis e nessuno lo sa fare come Clerici. Tanti si cimentano a parlare di tempo, e Gianni Clerici li batte ancora. Finalmente capisco che tutte quelle parole, quel desiderio di fine mai sopita che si prova dinanzi al sublime, non erano affatto casuali. Strappare la bellezza dalle cose vive, fotografarla un attimo, riporla in un cellophane e smarrirla dopo tanto tempo. Anche quel trattamento riservato a Stefan Edberg, non era altro che una forma di rispettoso addio, e sarebbe bello saperlo scrivere come faceva lui.
Stefan Edberg, non più Stefanello, perché quando si arriva alla fine del tempo, meritiamo tutti un omaggio, che sia un nome da adulto finalmente pronunciato piano, un bacio sulla fronte o un ti voglio bene gridato talmente forte da rompere il cuscino.
Nella luce, Gianni Clerici, senza leggerti mai più.