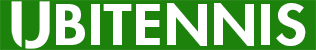Editoriali del Direttore
ATP Finals: dal primo Masters che ho seguito, 1975 Stoccolma e Panatta, a oggi. Quante cose sono cambiate alle ATP Finals
Il direttore Ubaldo Scanagatta ne ha seguite 33. Gli anni del Madison Square Garden, prima che tutto diventasse Tennis Show come il basket NBA. Connors dà del vigliacco a Lendl, Boris Becker da tennista a coach di Rune, palle bianche e gialle

Questo articolo è stato pubblicato martedì 14 novembre sul sito di quotidiano/net nell’area tennis del QS/Quotidiano Sportivo che “copre” la pagina sportiva web de Il Resto del Carlino-La Nazione-Il Giorno, testate per le quali da mezzo secolo collabora il nostro direttore Ubaldo Scanagatta
Il mio primo Masters l’ho visto a Stoccolma nel 1975. Quello in cui giocò Adriano Panatta. Adriano aveva vinto poche settimane prima il torneo di Stoccolma battendo Jimmy Connors n.1 del mondo, quindi era attesissimo. Ma non giocò tanto bene.
Ma qui non devo scrivere di quell’edizione – l’ho già fatto più volte – perché poi dal ‘76 all’82 si giocarono a Houston e io invece cominciai a seguirle con continuità dacché, nel 1983, si spostarono al Madison Square Garden di New York.
Delle successive 40 ne ho viste 33 se non erro, assistendo a tanti cambiamenti, di formula, di nomi, di atmosfera, di tutto.
Pensate che solo il nome è stato cambiato cinque volte. Il quinto, dal 2017, è ATP Finals. E’ successo soltanto perché chi aveva ideato il brand Masters, e il tournament director del Madison Ray Benton non ha mai voluto cedere il copyright di quel conio certamente felice –“Masters” i Maestri – ai prezzi cui l’ATP era disposta a pagarli.
Ma tanti, certo delle generazioni meno giovani, anche fra i colleghi lo chiamano ancora Masters. Il torneo dei Maestri. Che sono diventati 8, dopo che a Tokyo e Barcellona era nato come un torneo per sei e anche per sette, fino a che si è capito che per fare due gironi di 4 tennisti ciascuno, era necessario poter contare su 8 tennisti anche in epoche in cui ha cominciato ad aver sempre più peso sportivo, oltre che mediatico e commerciale, centrare il traguardo di chi può vantarsi d’essere un top-ten.
Non ero a Tokyo nel 1970, a Metropolitan Gymnasium, la prima edizione nella quale mi è stato detto che nello stadio non c’era riscaldamento e faceva un freddo cane, al punto che agli spettatori vennero date delle coperte per seguire una formula completamente diversa, 6 giocatori e un unico girone all’italiana, motivo per cui alla fine non ci fu neppure una finale. Lo vinse Stan Smith perché aveva vinto le stesse partite di Laver 4 su 5, ma il primo posto gli fu attribuito perché gli valse la vittoria nel confronto diretto.
Certo le cose sono cambiate parecchio da allora. A Stoccolma Panatta perse tre incontri su tre con Nastase, Ashe e Orantes nella Kungliga Halle, un posto dove si giocava su delle mattonelle grigie velocissime (Boltex) e tutto pareva grigio come quelle. E quindi anche parecchio triste. C’era una capienza di 6 mila spettatori, un terzo di quelli che poteva ospitare, sulle sue poltroncine rosse che mi sono rimaste così impresse per contrasto, il mitico Madison Square Garden che io, prima del 1983, avevo visto soltanto in tv per qualche leggendario scontro di boxe fra pesi massimi.
Prima di capire quale fosse la formula più giusta perché si evitassero incontri privi di senso agonistico, sorta di esibizione fra giocatori già qualificati per le semifinali o già eliminati, ci vollero anni e anni.
Fece cambiare formula una ripetuta serie di situazioni poco… sportive. La gente mormorava su incontri che parevano se non combinati però poco attraenti perché giocati a situazioni acquisite per sé o per altri. La pietra dello scandalo fu la partita farsa giocata dal Lendl e Connors. Era l’anno 1980: Lendl la perse praticamente apposta da Connors per arrivare secondo nel proprio girone. E Jimbo gli dette apertamente del vigliacco, “Chicken!”, parola che non va tradotta letteralmente come “pollo”, ma appunto come vigliacco. Se Ivan il calcolatore fosse arrivato primo avrebbe dovuto incontrare in semifinale Borg che avendo perso un match da Gene Mayer era secondo nell’altro gruppo. Preferì, astutamente e privo di scrupoli, affrontare Mayer. E lo sconfisse, per poi perdere in finale con Borg come aveva previsto.
Quello scandalo ebbe come conseguenza che dall’82 all’85 si giocò con tabelloni rispettosi della tradizionale eliminazione diretta del tennis, con 12 e 16 giocatori…e chi perdeva andava a casa. Come è sempre accaduto nel tennis.
Ma chi organizzava scoprì facilmente che era molto più facile vendere biglietti quando esisteva una formula che ti consentiva di vedere almeno tre volte i tuoi giocatori preferiti.
E così si tornò ai 2 gironi per 8 magnifici protagonisti. Già al Madison Square Garden, prima che la rassegna di fine anno si spostasse in Germania seguendo l’onda Becker e Stick – anche perché il tennis americano non aveva più sei, sette o anche otto tennisti fra i primi 10 del mondo – era comparsa la musica assordante ai cambi campo. E con quella gli annunci pubblicitari, con i campi di campo che allungavano il minutaggio una volta inesistente per consentire alle tv di passare i loro messaggi sponsorizzati. Così se prima i giocatori nemmeno si sedevano ai cambi campo e una finale poteva durare poco più di un’oretta se a senso unico, comparvero prima le sedie, poi le panchine, naturalmente sponsorizzate, e lì vicino le ghiacciaie, i seggi dell’arbitro con i nomi delle marche più strane, i paletti ricoperti di pubblicità, i nomi di brand anche sui tappeti sintetici (Supreme…e altri).
Non si era ancora ai livelli di quel che sarebbe diventato uno show NBA, ma se il tennis americano fosse rimasto in auge, ci saremmo arrivati prima.
Le edizioni tedesche degli anni 90, fra Francoforte e Hannover, fecero un passo indietro in termini di spettacolarizzazione, di show business. Boris Becker aveva vinto Wimbledon 1985 con le palle bianche e Wimbledon 1986 con le prime palle gialle, che divennero pian piano d’obbligo anche in tutti gli altri tornei, anche perché non si confondessero con le scritte bianche sugli striscioni di fondocampo. Non ricordo quando apparvero sulla scena Nike e Adidas a battersi per una leadership mondiale per l’abbigliamento, magliette, pantaloncini e scarpe, ma certo piano piano spazzarono via quasi tutte le marche italiane, Fila, Tacchini, Ellesse, Lafont, Diadora, che avevano “marcato” il territorio.
Ma la strada, anche se per un decennio contrassegnato da sedi “vagabonde” per quanto riguarda i Masters fra il 2000 e il 2009 (Lisbona, Sydney, Shanghai, Houston), oramai era tracciata. A Shanghai lo stadio QI Zhong, con 14mila posti a sedere, un tetto retrattile “a petalo di magnolie” e mega fuochi d’artificio a celebrare il “Maestro” vincitore impressero una prima svolta, finché le “Atp World Tour Finals” trasferitesi nella avveniristica 02 Arena di North Greenwich a Londra, fino ad allora teatro di grandissimi concerti rock, non contaminarono musica spettacolo tennistico. Comparvero le scritte breakpoint setpoint, matchpoint precedute e accompagnati da rulli di tamburo, rumorosi ingressi in campo di star con racchetta che entravano nel clamore suscitato da altoparlanti con assordanti decibel da discoteca, luci psichedeliche e via dicendo. Roba che il mio grande Maestro – lui sì nessun infrazione al copyright – Gianni Clerici trovava assolutamente insopportabile. Ma mi sa che fosse una questione generazionale.
Ma anche un giovane NextGen, Carlitos Alcaraz, oggi è rimasto impressionato dall’accompagnamento da rockstar che c’è stato al suo stesso ingresso in campo: “mai vista una cosa simile, impressionante”. E perfino i doppisti, che ben pochi conoscono anche fra gli appassionati, vengono trattati come fossero i Rolling Stones.
Roma, grazie a Cino Marchese che da responsabile IMG di Mrck McCormack si inventò il Villaggio VIP negli anni 90, ha segnato un nuova era – o area…commerciale? – per coinvolgere sempre più sponsor, e oggi non ci sono più tornei senza ..villaggi. Anche se questi sono cambiati, perché ora sono meno elitari, meno esclusivi, ma anzi aperti al maggior numero di persone, adulti, ragazzi e ragazzini e nelle cosiddette fan-zone sempre più grandi – come qui a Torino che è una delle più grandi e ben fatte che io abbia mai visto – c’è di tutto, giochi di tutti i tipi, video, giochi di luce, aree ristorazioni con tutto il food che si può desiderare, non solo campetti di padel, pickleball, minitennis. Per quasi tutto naturalmente è meglio essere connessi, cellulari, bluetooth, app, e chi più ne ha più ne metta.
Tutto viene allestito perché chi viene a vedere due sole partite di tennis, una di doppio e un’altra di singolare per sessione, si fermi possibilmente anche tutto il giorno. Magari all’inizio gli si offre di assistere a un ballo di grande impatto coreografico di danzatori professionisti, oppure in un’altra area ci sono giovani artisti che hanno una loro vetrina per esibirsi come se fossero all’X Factor…Mentre sul campo centrale luci fisse inquadrano il team di supporto al giocatore, coach, fisio, manager, genitori, fidanzate…tutto ripreso in permanenza all’interno di un gigantesco occhio di bue che resta illuminato durante tutto il match, così che se Becker si alza in piedi per incoraggiare Holger Rune contro Djokovic non c’è chi non lo scorga e non c’è appassionato serbo che non si senta autorizzato a gridargli del traditore…come se non fosse stato Djokovic a volersene separare. Ma quella che li ispira è la stessa logica dei social, dei leoni da tastiera tanto cara a Umberto Eco. Tutto quanto fa spettacolo e suscita reazioni social va bene. I ragazzini delle scuole tennis che urlano di tutto a favore di questo o quello, vengono capiti e guadati con compiacenza da chi osserva: “Beh dai, è la crescente popolarità del tennis, va bene così”. E probabilmente hanno pure ragione.
E alla fine la partita per cui si è comprato con largo anticipo e a caro, carissimo prezzo il biglietto, con i biglietti che appaiono e scompaiono magicamente sui siti internet anche quando c’è scritto da giorni “sold out” finisce per diventare una sorta di grande contorno a tutt’altro. Giocano il n.2 del mondo Alcaraz contro il n.8 Zverev, ok, …ma se sul campo d’allenamento allestito all’interno del PalaAlpi arriva a giocare Sinner, tutti via,si corre lì a perdifiato dimenticando il setpoint in corso, per scattare una foto, magari catturare un autografo o perfino un selfie. Selfie? Ma solo pochi anni fa c’era qualcuno che aveva mai sentito pronunciare la parola selfie? Oggi non c’è bambino che non la conosca.
Va bene così. E’ il nuovo tennis. E la Sinnermania, con Jannik che tappezza tutto il centro di Torino nelle vesti più varie, sui murales, sui bus, ovunque quando sorseggia un caffè, quando ascolta un cellulare immerso in una vasca piena di palle, quando controlla la propria carta di credito della banca prediletta o perfino quando guarda che ore sono mentre porta una borsa non da tennis sul campo. In fondo la Sinnermania tutti ci coinvolge, tutti rallegra, dopo 40 anni in cui il tennis è stato uno sport minore e tutti gli appassionati si indignavano a sentirselo dire. Il buio tecnico e cosmico non c’è più. Il rinascimento del tennis italiano, Hanno ripreso a vincere anche le donne, finale di Bilie Jean King, mica discorsi. Ci sono invece tante, tantissime luci. Abbaglianti, a volte stordenti, ma in fondo non è proprio bello che sia finalmente così? Perfino se tocca sopportare coloro che non resistono all’idea di comunicarti che è anche merito loro. L’Italia è stata sempre un Paese popolata da gente desiderosa di salire a tutti i costi sul carro dei vincitori.