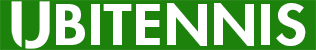Senza categoria
Everyday America: vita di un tennista, Brendan Evans
La storia di Brendan Evans è una storia di successo. Non è però la storia di successo che ci si immaginava per lui quindici anni fa, quando la Nike lo mise sotto contratto per più di 1 milione di dollari

Everyday America: viaggio nel Sistema USA
Quindici anni fa Brendan era la grande speranza americana che avrebbe dovuto affiancare Roddick nella sua seconda parte di carriera. Era il quindicenne classificato più in alto tra i junior, aveva vinto l’Eddie Herr International e il torneo junior di doppio a Wimbledon raggiungendo contemporaneamente anche la semifinale in singolo. Era persino uno dei protagonisti di Top Spin 2, il gioco X-box che tanto spopolava negli anni 2000. La fama ne precedeva il nome ed anche il gioco. Gli Stati Uniti del resto erano affamati di altri campioni, l’era di Sampras e Agassi si avvicinava precipitosamente al crepuscolo e il solo Roddick non sembrava in grado di poterne emulare le gesta. La storia di Brendan Evans è una storia di successo che passa prima dal fallimento più grande che potesse immaginare. Sì, perché Evans quelle aspettative riposte in lui dalla Nike, da sé stesso, dalla famiglia e dall’ambiente e dai tifosi non le rispetterà mai. Non riuscirà mai ad entrare nei top 100, supererà il primo turno in uno Slam una sola volta e si ritirerà nel 2010, a ventiquattro anni. La storia di Brendan Evans è una storia di successo proprio perché passa prima dal fallimento più grande. È di successo perché è una storia di rinascita e di riscoperta personale. È una storia di successo perché è una storia di coraggio. Ed è una storia di successo tipicamente americana.
Quando mi sono messo al lavoro per tentare di comprendere il sistema sportivo e scolastico statunitense non cercavo numeri o statistiche. O meglio, non cercavo solo quelle. Le cifre aiutano, per carità; supportano tesi, rendono più chiare le idee, permettono un’analisi più approfondita. Eppure restano solamente cifre. E dietro le cifre di un sistema sportivo e scolastico ci sono ragazzi e famiglie e storie di sconfitte che, nascoste dai riflettori di chi raggiunge la fama, spiegano il sistema meglio di quanto non possano fare numeri e statistiche, meglio di quanto non possano fare i successi di quello 0.1% che arriva alla vetta. Ecco, la storia di Brendan Evans, laureatosi a pieni voti in finanza all’Università della Virginia ed ora analista nella più grande banca d’investimento al mondo, Goldman Sachs, per un salario che nel mondo del tennis sono in pochi a ricevere, con una competizione ed una percentuale di assunzione simile alla probabilità di diventare uno tra i primi cento giocatori di uno sport, ha subito attratto la mia attenzione. Quando ricercavo infatti il rapporto tra tennis universitario e tennis professionistico, in mezzo alle vittorie di John Isner e Kevin Anderson spuntava spesso il suo nome. Il nome di un ragazzo che il salto al professionismo l’aveva fatto a 15 anni e che la scelta di fare quel salto la rimpiangeva ad ogni intervista. Il ragazzo simbolo della Lost Generation (mi perdoni Hemingway) tennistica americana degli anni duemila.
Il percorso travagliato di Brendan Evans ha attratto la mia attenzione perché non è stato difficile per me immergermi nei suoi dubbi e nelle sue paure e renderle i miei dubbi e le mie paure. Vivere sempre lontano da casa, spesso spostarsi tra continenti, cominciare ed interrompere rapporti personali e non avere la maturità necessaria per capire appieno e per metabolizzare esperienze, luoghi, cambiamenti. E poi le incertezze sul futuro, le aspettative personali e gli obiettivi che con il tempo mutano. Certo, non ho mai firmato contratti milionari da adolescente né ho visto scritti su di me articoli e analisi e neppure ho forse afferrato con certezza quale sarà la mia strada, eppure riesco in qualche modo a mettermi in relazione. E sarà forse per queste difficoltà e paure che apprezzo ancora di più i Federer, i Nadal, i Djokovic, le Williams, che sono riusciti ad affrontarle ed a vincerle durante tutto il percorso di crescita. La storia di Brendan mi premeva quindi approfondirla e questa volta non solo per meglio comprendere il sistema americano. No, la storia di Brendan mi interessava anche dal punto di vista umano. Racconta della difficoltà dell’essere tennista, della solitudine che si affronta e dell’equilibrio precario tra gloria e anonimato. Sono riuscito quindi a contattarlo e intervistarlo ed è stata una conversazione piacevole. Brendan è una persona eloquente, guarda con grande freddezza e razionalità alla sua esperienza da tennista ed interrompere il suo flusso mi è stata impresa ardua. Riesco a dare quattro-cinque input in un flusso di coscienza che spazia dalle sue esperienze di vita alle mille difficoltà d’essere un tennista, dal coraggio di lasciare a quello di ricominciare, dai montepremi sbilanciati agli errori della USTA.
Signor Evans, prima di tutto mi faccia iniziare dicendo quanto sia felice di intervistarla. Ho trovato la sua storia interessante dalla prima volta che ho avuto modo di leggerla. Lei è stato tra i migliori junior della sua generazione, ha avuto le attenzioni di aziende, media, appassionati. Poi qualcosa non è andato e…
Guardi, per capire quello che successe poi è meglio forse che parta da quanto avvenne prima. Quando ho iniziato a giocare ero già grande, relativamente agli altri. Avevo nove anni ma guardavo il tennis da quando ero in culla e avevo un’idea dell’impostazione dei colpi dei migliori. Emularli mi è venuto quindi naturale appena ho preso una racchetta, non avevo bisogno poi di tante istruzioni. Un mese dopo ho infatti giocato il mio primo torneo e raggiunto la finale. Mi piaceva che fosse uno sport individuale, si sposava perfettamente con la mia competitività. A undici anni ero il numero uno degli Stati Uniti, e così fino ai diciotto. A dodici avevo deciso che avrei fatto il tennista: ne parlai con i miei genitori e con mia madre decidemmo di spostarci in Florida dove avremmo potuto allenarci. Mi allenavo anche otto ore al giorno. A 15 anni diventai finalmente professionista: avevo appena vinto un Grade 2 in Marocco e l’Eddie Herr, ed ero riuscito ad entrare in tabellone agli US Open junior. Persi, avendo un match point, contro il numero 2 del tabellone.
E lì immagino inizino i primi corteggiamenti degli sponsor e delle aziende
Sì; lì diventai professionista. Firmai con IMG e un contratto da più di un milione di dollari con la Nike. Credevano tanto nel mio gioco, ero già alto 1 metro e 85, pesavo 80 chili, sembravo avviato ad essere la next big thing. Guardi che però non è stato mica semplice accettare, io già ci pensavo all’università e a sviluppare il mio gioco lì. L’offerta era però troppo allettante da lasciare andare, quei tipi di contratti non ci sono poi tutti i giorni. In fondo all’università ci sarei potuto anche andare dopo. Ad ogni modo, dov’ero? Ah sì, la carriera da junior avanzava a meraviglia, diventai numero 2 al mondo, vinsi tornei importanti ovunque ed in poco ci si aspettava che a 19 anni diventassi già un top ten. Il passaggio al professionismo fu difficile però; nei Futures e nei Challengers facevo fatica, come fa fatica del resto qualsiasi ragazzino di quell’età. Si iniziò però con le sconfitte a sentire qualche mugolio, pian piano sempre più forte, la pressione aumentava sempre di più. Sentivo ovunque dire: “ma perché non è già tra i cento?”. Avevo un gioco particolarmente aggressivo, mi serviva più tempo per maturare e quella pressione a sedici, diciassette anni era troppa per me. Credo onestamente col senno di poi di aver perso almeno tre anni di crescita e anche quando ero numero 2 tra gli juniores non sentivo di stare sviluppando il gioco per competere tra i grandi. Così a vincere i Challenger ci sono arrivato ai 22-23 anni, quattro dopo di quanto pensassi e volessi. Mi faceva stare male, soffrivo il fatto di non essere competitivo ai massimi livelli. Provavo a buttarmi sui miei altri interessi; leggevo tanto e di tutto. Letteratura, politica, business. Ero l’unico nel circuito a leggere prima di ogni partita. Poi, proprio quando avevo vinto un paio di Challenger e pensavo d’essere finalmente sulla via della risalita arrivarono gli unici due infortuni della mia vita. Il primo contro Soderling in Asia: un dolore lancinante alla schiena. Niente che potessi risolvere, purtroppo, secondo i dottori ci avrei imparato a dover convivere. Al rientro un altro infortunio, questa volta alla caviglia. Mesi difficili, persi dodici partite di fila e la classifica precipitò. Fino a Wimbledon, dove mi qualificai e arrivai al secondo turno, avanti 2 set a 1 su Montañes e con la possibilità di giocare contro Djokovic al terzo. Quella partita l’avrei potuta, forse dovuta vincere. Ero più forte su erba, ma persi. Fu la sconfitta più devastante della mia carriera: ore negli spogliatoi a guardare gli armadietti. Sa, ovviamente sono una persona molto competitiva; ogni sconfitta è dura. Quella però fu diversa: era l’occasione di giocare sul centrale a Wimbledon, di raggiungere il terzo turno, di rifarmi dopo gli infortuni e la discesa in classifica. Decisi però di rigiocare subito. Provai le quali a Newport e persi e persi anche in due Futures canadesi, ai quarti da prima testa di serie. Fu lì che chiamai mia madre e lei mi disse: “Basta, torna a casa. Studia per l’SAT (una specie di esame d’ammissione per le università americane) ed iscriviti al college”. Rimasi sorpreso, avevo 24 anni. Era tardi per iniziare l’università. E poi dovevo volare a Sacramento per un Challenger. Ma non lo feci, tornai a casa e dopo due settimane e tante conversazioni con la mia famiglia presi la decisione: avevo finito con il tennis.
Sembra onestamente una decisione affrettata, quasi improvvisa. La rimpiange?
Non l’ho mai rimpianta. Neanche per un solo giorno. È incredibile quanto la mia vita sia cambiata per il meglio in ogni verso: mentalmente, fisicamente. La vita del tennista è una vita difficile. Navigare tra la centesima e la duecentesima posizione, e perdere soldi ad ogni sconfitta e non sapere cosa fare una volta arrivati i trent’anni ed il ritiro. Tanti miei amici anche fra i primi venti o cinquanta affrontano gli stessi problemi. È tosta.
Ma scusi, lei il tennis l’ha mai amato? O ci era solo bravo?
Sì, l’ho amato e l’ho amato a lungo. Amavo il fatto che fosse uno sport individuale e che il lavoro che mettessi in allenamento venisse poi ripagato in campo e che ci fosse tattica e strategia. E poi sì, mi veniva naturale e ci ero bravo. Tuttavia ad un certo punto me ne sono allontanato, già prima degli infortuni. Essere un giocatore da Challenger mi devastava, le sconfitte mi devastavano ed iniziavo a vederlo come un lavoro. Certo era il mio lavoro, ma iniziavo ad avvertirlo come un lavoro, sempre. Divenne allora sempre più dura ed ebbi la conferma d’aver perso l’amore per il gioco quando dopo le sconfitte invece di arrabbiarmi, restavo a pensare per ore: “Ma cosa sto facendo della mia vita?”. Ho giocato un paio d’anni con questo stato d’animo, i più difficili della mia vita. Mia madre mi dice tuttora: “Ogni volta che ti sentivo al telefono sembravi la persona più triste al mondo e da madre che ti ama era insopportabile. Volevo aiutarti, trovare modi per non farti sentire inutile e triste. Dovevo tirarti fuori dal tennis.”
Il tennis però non è uno sport difficile esclusivamente per il dover affrontare la sconfitta da soli. Il tennis è uno sport per vagabondi in fondo. Si perde il senso di casa e da giovani, giovanissimi si gira come trottole impazzite da un capo all’altro del mondo. Spesso è un messaggio che è difficile da far comprendere, si pensa quasi sia piacevole, io lo trovo però a tratti estremamente alienante e… tosto, per quanto un’opportunità di crescita enorme.
Oh beh è davvero difficile. Dai quattordici ai ventiquattro anni non sono mai stato in un posto più di due, tre settimane. Non ho mai disfatto la valigia. Ero in Marocco, Uzbekistan, da solo a 15 anni. A volte rimasto senza contanti, una volta addirittura mandato in cella per questo. Sì, non avvertivo un senso di casa, casa erano le valigie del resto. Mi ha fatto, però, essere una persona molto indipendente. Ancora oggi lo sono. Sia chiaro, sono un estroverso. Mi piace essere socievole, eppure ho bisogno ogni giorno di essere solo per un po’. Ecco questo me l’ha insegnato il tennis, viaggiare e pensare. Lo dico spesso ai miei colleghi qui, ma non mi pare capiscano davvero. E poi la vita da tennista mi ha fatto scoprire il mondo, e prima ancora me stesso e la mia cultura. Gli americani non viaggiano troppo, sono chiusi in una bolla ma dovrebbero vedere come ci considerano fuori. Sì, gli Stati Uniti sono una grande nazione, ma ci sono culture fantastiche e posti meravigliosi anche fuori da qui.
Sta coprendo molti temi che avrei voluto chiederle e allora provo ad andare più sul personale: si è mai sentito solo in questo vagabondare?
Non ne parlo quasi mai a dire il vero, però più che nel girare mi sento solo quando provo a raccontare. È come se vivessi due vite parallele. I miei amici tennisti poco si mischiano con i miei amici nella finanza o universitari. E gli uni non capiscono gli altri. E se i miei compagni di scuola e ora colleghi di lavoro faticano a capire il mio passato da tennista e quello che ha rappresentato e propongono pure di farmi conoscere il figlio dell’amico che gioca al liceo ed è “bravino”, i miei amici tennisti capiscono poco la mia carriera attuale e le sfide che affronto qui. Sono molto attaccato alla mia famiglia, che mi ha seguito in tutto il percorso e conosce tutte le mie… vite. Per il resto ho pochi amici con cui mi sento davvero vicino perché a volte, e spero di non risultare arrogante, trovo difficile che mi capiscano. Ci sono in realtà un paio di tennisti che lavorano in finanza.
So di Mario Ancic a Credit Suisse.
Sì proprio lui. È un ragazzo fantastico. Ci sono due, tre giocatori nel circuito che tutti adorano, e lui era sicuramente uno di quelli. Credo che il tennis aiuti molto nel lavorare in un ambiente così stressante e competitivo come questo. Il tennis mi ha dato metodo, mi ha insegnato l’efficienza, a digerire le sconfitte e i fallimenti, a saper competere e ad avere l’etica del lavoro. È per questo che riesco a lavorare per così tante ore e del resto non sono una sorpresa per molti datori di lavoro.
Fa sembrare la transizione dall’essere un atleta professionista a tornare tra i banchi quasi semplice.
Per me la scuola è stato un divertimento. Non ho mai saltato una lezione, ho preso il massimo dei voti ed ho fatto tutto il possibile per potermi assicurare un buon lavoro. E gli ex atleti piacciono molto perché hanno un bagaglio di esperienze impossibile da trovare in chi segue percorsi più tradizionali. Il tennis mi ha insegnato anche ad andare d’accordo con i miei colleghi con otto anni in meno di me e con i miei professori di dieci anni più grandi di me. Con il tennis si è allo stesso momento con un ragazzo quindicenne e uno trentacinquenne, di nazioni diverse. Ti insegna a socializzare tutto sommato, nonostante sia uno sport individuale. Alla mia laurea c’erano venti professori, non succede mica spesso.
Mi parlava all’inizio della nostra conversazione della sua scelta di diventare professionista a 15 anni e di non andare all’università per sviluppare il suo gioco, come fece John Isner per esempio. A distanza di quindici anni, farebbe la stessa scelta?
Onestamente credo sia una scelta molto personale. Un ragazzo come Taylor Fritz è già pronto per il professionismo, è sviluppato fisicamente, ha il gioco adatto. Però ecco, un ragazzo di diciotto anni anche già intorno alla duecentesima posizione, anche a ridosso dei cento, forse farebbe bene a sfruttare l’esperienza universitaria, anche solo per un anno o due. John per esempio, uno dei miei amici più cari, era solo il numero 15 o 20 negli Stati Uniti dopo il liceo. Non si allenava tutti i giorni. L’università gli ha dato disciplina, è cresciuto sotto tutti i punti di vista grazie all’apporto delle strutture dei college.
L’ultimo punto che volevo analizzare della carriera di un tennista è quello finanziario. Spesso si viene trascinati dai guadagni dei top ten e non si vede il resto. Come vive un giocatore intorno alla centesima posizione?
È un problema, non nascondiamolo. Non hanno alzato i montepremi né di Futures né di Challenger, mentre quelli del circuito continuano a marciare spediti. Se hai un allenatore a carico devi essere fra i primi cento. Già il centocinquanta, centosessanta guadagna forse ventimila dollari l’anno. Il pil pro-capite statunitense è di cinquantatré mila dollari…
Le va se terminiamo con un’analisi del tennis americano? Qualche tempo fa uscì un articolo su Usatoday che si riferiva alla sua generazione come alla “lost generation”. Crede sia così e soprattutto, cosa non è andato per tutti questi anni?
Quando ero uno junior avevamo sei americani nella top ten giovanile. Non penso sia mai successo, né prima né tantomeno dopo. Eravamo talentuosi, ma non ce l’abbiamo fatta e le cause sono tante e diverse. La USTA ci spingeva a diventare professionisti. È buffo, non lo dicono, ma era così. Ci tenevano a far vedere che ci fosse uno stuolo di campioni in fasce pronto a dominare il tennis. Dicevano a giocatori che erano forse numero dieci nella nazione di diventare professionisti, quando le qualità non c’erano. Non voglio scaricare la colpa solo sulla federazione, ma non ci hanno aiutato. Quando giocavo, se eri fra i primi dieci della tua categoria nella tua nazione ti davano cinquemila dollari alla fine dell’anno come premio. Una somma ridicola. Ci coprivi un viaggio in California con l’allenatore per un torneo. I miei genitori non volevano crederci. Crescendo cambiarono tattica: ti invitavano nei loro centri e ti fornivano gli allenatori, modesti a dir la verità, gratis. Tutto il resto restava a carico nostro. Se legge i libri di Sampras, Agassi, se vede le storie di Querrey, Isner, nessuno di loro è un prodotto della federazione. Se ne lamentano tutti. Pat McEnroe in quell’articolo a cui fa riferimento dice che non ci allenavamo abbastanza. Mi cadono le braccia. Di nuovo, a costo di sembrare arrogante, ero fra i più dediti all’allenamento e, come me, molti miei compagni. Ma dopo tre, quattro sconfitte la federazione spariva. Non c’era quando ne avevamo bisogno. Ora hanno cambiato tono e dicono a tutti di andare all’università scaricando su di noi tutte le colpe della “lost generation”. Mi piacciono molto i vari Fritz, Donaldson, anche questo Opelka di cui mi parla. Spero arrivino in alto, fra i primi dieci. Ma difficilmente sarà un successo della federazione. Del resto, mettono a gestire conti milionari derivanti dagli US Open a gente che non ha mai avuto esperienza nel settore, né del tennis né imprenditoriale.”
Sarà forse che il mondo è paese. Grazie mille signor Evans e buona fortuna per tutto.