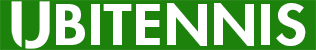Interviste
Marco Panichi: “Djokovic è speciale, sapevo sarebbe tornato numero 1”
Esclusiva con il noto preparatore atletico. L’addio a Nole: “Non gli eravamo d’aiuto. Forse gli ha dato la spinta”. Il ruolo del team: “Essenziale, ma serve equilibrio”

Tra i relatori dei corsi GPTCA e ISMCA tenutisi lo scorso novembre al Centro Pavesi di Milano, uno dei nomi più illustri è stato sicuramente quello di Marco Panichi. In quasi trent’anni di carriera il 54enne preparatore atletico romano ha seguito molti dei migliori tennisti italiani, partendo da Sanguinetti e Santangelo, passando per Fognini, Bolelli, Vinci e Knapp, fino a Giannessi e Donati oggi, per fare i nomi più importanti. E tanti campioni stranieri, come Smashnova, Hantuchova e Kuznetsova in campo femminile, Karlovic, Kohlschreiber e – ultimo in ordine cronologico, dato che Panichi lo ha seguito a cavallo tra il 2017 e il 2018 – il fuoriclasse serbo Novak Djokovic, in campo maschile.
Peraltro la presenza di Panichi all’evento formativo milanese è stata apprezzata dai partecipanti non solo per le sue relazioni (una sua sessione sul campo insieme ad Alberto Castellani e Pat Remondegui è proseguita ben oltre l’orario previsto, a tardo pomeriggio inoltrato, con i corsisti entusiasti che continuavano a chiedere esempi di esercizi), ma anche per i contributi durante le relazioni degli altri docenti, alle quali ha spesso assisto in mezzo ai partecipanti, riguardanti esempi o aneddoti tratti dalle sue tantissime esperienze professionali di alto livello. Alcune relative proprio alla sua recente collaborazione con Novak Djokovic. E ovviamente proprio da quest’ultima siamo partiti nell’intervista che Marco ci ha concesso in una pausa tra un corso e l’altro in una delle sale dell’impianto sportivo milanese.
La prima domanda è abbastanza scontata: Novak Djokovic è di nuovo al vertice del tennis mondiale, dopo cinque mesi incredibili: da luglio in poi, due Slam e due Masters 1000 in bacheca, 35 vittorie e solo 3 sconfitte. Tu che hai lavorato con lui nel periodo sicuramente più duro, quello dell’infortunio e dell’operazione, te lo aspettavi che ritornasse numero uno al mondo?
Sì, posso dire che me lo aspettavo. Perché penso che Novak Djokovic sia speciale in tante cose. Nel periodo che abbiamo lavorato assieme devo dire che c’era dentro di me questa quasi certezza, anche se si è trattato di un periodo in cui lui doveva prendere delle decisioni ed era un po’– passami il termine, ma è per capirci– in confusione. Ma solo perché era un momento di grande cambiamento – nella sua vita, nel suo staff – e secondo me non era centratissimo su quello che doveva fare. E mi piace pensare, anche se non ne potrò mai avere la certezza chiaramente, che quando ad un certo punto tutti noi tre dello staff – io per primo, Radek Stepanek e Andre Agassi – abbiamo deciso di interrompere la collaborazione, forse è stato proprio questo a dargli la spinta per rientrare un po’ su certi binari che poi l’hanno portato a tornare quello che è.
Quindi per te non si trattava solo un problema di impegni in Italia, come si era sentito dire, che non erano compatibili con l’impegno richiesto dalla collaborazione con Djokovic?
Molto semplicemente, io faccio questo lavoro ormai da trent’anni. E sbaglio a chiamarlo lavoro: per me è una passione. E il mio lavoro è proporre delle cose, a seconda chiaramente del giocatore e della situazione che ho di fronte, che credo e spero lo possano aiutare. In quel momento, tutti e tre noi dello staff ci siamo resi conto che quello che potevamo proporre non era di aiuto a Nole. Semplicemente questo. Che, ripeto, in quel momento – rispettabilissime tutte le sue decisioni – non era in grado forse di prendere le decisioni giuste. O almeno noi pensavamo questo. Questo è il vero motivo. Poi, è chiaro, io avevo anche altri impegni con altri giocatori in Italia, ma non è stato per quello. Certo, con lui era praticamente un lavoro 24 ore su 24, ma nonostante questo era una bellissima esperienza.
Proprio collegandomi a quanto mi hai appena detto e alla tua grande esperienza, ci puoi dire se hai riscontrato delle differenze nel lavorare con un top player piuttosto che con giocatori che stazionano più indietro nel ranking?
Posso dirti che non si tratta di una questione di classifica. Non è che lavorare con un top player ti richieda di più rispetto ad altro giocatore. Dipende dal giocatore. Nole richiedeva veramente moltissimo impegno e forse anche per questo, molto probabilmente, lui è un top player. Per lui, per quello che è il suo concetto di allenamento, qualsiasi cosa dovesse fare – che comprende tutti gli aspetti che stiamo trattando in questi giorni nei corsi, dal mentale all’alimentazione, ad esempio – era così importante da occuparlo ventiquattr’ore su ventiquattro. Ovviamente non in senso letterale, intendo dire che se ne occupava per tutto l’arco della sua giornata “lavorativa”. Altri giocatori fanno lo stesso pur non essendo dei top player e probabilmente questo li porterà a diventarlo in un secondo momento. Ma non voglio dire che sia l’unico modo per diventare un top. Ci sono persone che invece lavorano e ragionano in modo diverso, che hanno bisogno dei loro spazi, di far decantare un po’ le cose che hanno elaborato prima di tornare competitivi al 100%. Per cui, per quella che è la mia esperienza, posso dirti che da questo punto di vista i top player sono tutti differenti uno dall’altro. Non è la classifica, ma il modo di essere. Che probabilmente influenzerà la classifica.
In un tuo intervento durante il corso, hai evidenziato come non ci sia stata una caratteristica fisica-atletica di Djokovic che ti abbia colpito in particolare, ma la persona nel suo complesso. All’appassionato, che ha impresse nella mente le immagini dell’“uomo di gomma” Djokovic, può suonare un po’ strano.
Indubbiamente Nole ha delle qualità fuori dal normale, quella che tu citi è sicuramente una di queste. Ora, non è che solo quella qualità possa determinare uno strapotere fisico. Nole, come tutti gli altri top player che ho avuto la possibilità di allenare, è un atleta completo. Io dico sempre questa cosa, anche perché provengo dall’atletica leggera: il tennista di alto livello deve essere un po’ come il decatleta. Deve cioè saper fare bene tutto, deve avere degli aspetti fisici e dei parametri fisiologici che devono essere ottimali un po’ in tutto. Lo spiego in maniera un po’ semplicistica ma è per essere chiaro: non può essere solo troppo veloce perché andrebbe a discapito della resistenza, non può essere solo resistente perché deve essere anche veloce, non può essere solo agile ma deve disporre di una componente di forza abbastanza importante da poter poi esplodere sul colpo, poter fare cioè quello nell’immaginario collettivo è il “tirar forte”. Quindi Nole, come tutti i top player, rappresenta l’apice. Hanno a 360 gradi delle caratteristiche che li rendono unici. Quello che dicevo ieri è che non sono rimasto colpito perché ho allenato atleti che avevano una di queste caratteristiche così predominante, così fuori dall’ordinario, che magari ti colpiva. Ma il fatto che invece lui sia così completo in tutti i settori lo rende un super-atleta.
Tornando al tuo lavoro, far parte di un team molto numeroso come appunto in uno dei tuoi interventi hai sottolineato essere quello di Djokovic, con più di una dozzina di persone che gravitano attorno al fuoriclasse serbo, è più gratificante e stimolante o preferisci lavorare in team più piccoli?
Penso che come in tutte le cose ci voglia il giusto equilibrio. Premessa: oggi, soprattutto ad alto livello ma anche a livello giovanile, il team è essenziale. Ora, il perimetro entro il quale definire il team può essere abbastanza labile, perché vi potrebbero essere inclusi tanti aspetti. Per mia esperienza personale, il team deve essere composto da 3-4 persone, responsabili dei singoli settori. È il nucleo, lo zoccolo duro, anche itinerante perché bisogna dare un supporto a 360 gradi all’atleta. Poi intorno a questo gruppo gravitano altre figure, che possono entrare a farne parte ma non in maniera stabile, al quale i professionisti di ogni settore si rivolgono se ci sono situazioni particolari. Ad esempio, penso ad un nutrizionista: non è una figura itinerante ma sta diventando una figura molto importante. E poi normalmente c’è chi gestisce il team, che è fondamentale: talvolta lo fa il manager, talvolta il coach, o anche il preparatore se ha l’esperienza necessaria. Ma il team è ormai fondamentale, l’iper-specializzazione ti richiede di continuare a studiare e ad evolvere come professionista in ogni momento, e non hai il tempo per diventare anche qualcos’altro: un buon coach o un buon preparatore atletico. Ne va innanzitutto della credibilità nei confronti dell’atleta. Che va salvaguardato: lui deve sapere che se si rivolge ad un preparatore atletico, ad un coach o ad un fisioterapista, trova la massima professionalità in quel settore.
Tu adesso stai seguendo diversi di atleti, tra i quali Giannessi e Donati. Come stai impostando la programmazione dei tornei, crea qualche difficoltà dover incrociare pianificazioni ed esigenze diverse?
Non è una cosa difficilissima da questo punto di vista. Ad esempio, Giannessi e Donati hanno suppergiù la stessa classifica, quindi una programmazione dei tornei simile e di conseguenza possono dividersi le spese e il fatto che li segua un po’ di più a tempo pieno. Chiaramente se, come si spera, dovessero crescere e salire di classifica, in quel caso bisognerà trovare delle misure per seguirli nel miglior modo possibile. Come preparatore atletico sono sicuramente più libero di un coach nel lavorare con più persone: il coach è quello che deve essere lì a dirgli come giocare e vincere, mentre io faccio un lavoro un po’ più dietro le quinte. Io devo metterlo in condizione di fare quello che il coach chiede, che le sue caratteristiche tecniche vengano esaltate. Perciò diciamo che, chiaramente con la valigia sempre in mano e pronto a saltare da un posto all’altro, si può fare.
Hai allenato tanti tennisti. Con tanti successi e tante soddisfazioni a livello professionale. Riavvolgendo il nastro della tua carriera, quale tra le tante vittorie e le tante soddisfazioni è quella più grande per Marco Panichi?
Non è facile rispondere a questa domanda. Perché, certo, ci sono le soddisfazioni per i risultati raggiunti, i tornei vinti – penso ai quarti di Fabio a Parigi, le vittorie degli altri, la scalata in classifica di Philipp Kohlschreiber. Sono state veramente tante. Ma, ancora una volta, questi sono forse gli effetti del mio lavoro, quindi come arrivano anche si dimenticano. Quello che ti rimane tantissimo invece – e sembrerà scontato, ma per me è assolutamente la verità – è il rapporto che si crea con questi giocatori. Vederli crescere, dal punto di vista fisico – per quanto mi riguarda – ma soprattutto, come spesso è accaduto quando ho avuto la fortuna di stare con qualcuno di loro più di qualche anno, vedere la loro trasformazione da ragazzi a uomini, da ragazze a donne. Vedere l’evoluzione dell’individuo. Questa per me, che sono un appassionato nel trasmettere – e spero di riuscire a farlo sempre nel miglior modo possibile – forse è la cosa più importante di tutte. Ripeto, sembra una cosa scontata e non voglio neanche prendermi troppo sul serio, ma io penso che noi non siamo solo allenatori, ma educatori. Questa cosa, ripeto, la dico senza voler assolutamente essere arrogante e sapendo che non ho le possibilità di un educatore, ma dobbiamo assolutamente essere leali, essere corretti, provare a dare questi ragazzi l’esempio migliore. Poi magari spesso non ci riusciamo, siamo umani. In definitiva, e ti assicuro che è così, io voglio un giocatore felice più che un giocatore forte. Poi, ovviamente, l’ottimale è che sia felice e forte e lavoriamo per farlo diventare forte. Ma in una carriera di 10-15 anni, in un periodo delicato nello sviluppo di un individuo, dobbiamo assolutamente tenere conto di queste cose. Perché quando finisce il tennis inizia la vita vera. Ripeto, senza arrogarmi competenze che non ho, ma dobbiamo essere il più onesti possibile nel rapporto con i ragazzi.
Ultima cosa. I nostri lettori spesso sono anche amatori oltre che appassionati. Un consiglio, un tip, per chi si approccia al tennis in ambito amatoriale.
Andiamo su un mondo abbastanza vasto, ma la cosa che io vorrei dire – innanzitutto – è quella di rimanere sempre in un range di sicurezza. E con questo intendo dire di non strafare, non giocare ed impegnarsi oltre i limiti percepiti. Per fare questo bisogna fare un minimo di movimento, avere un minimo di preparazione, anche al di fuori di quello che può essere il divertimento della partita stessa. Mi spiego: uscire dall’ufficio, andare a giocare e poi tornare subito a casa, può andar bene una o due volte, ma se lo si fa costantemente è il caso di dedicare quella mezz’oretta prima e quella mezz’oretta dopo ad un buon riscaldamento e ad un buon defaticamento, che ci possono veramente salvare per tante cose.