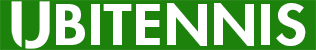Interviste
A lezione da Gianni Clerici, fra storie, divagazioni e autografi
Nel tennis non avremo un giocatore top 10 ma almeno abbiamo uno dei più grandi giornalisti di tutti i tempi. Scrittore e cronista, Gianni Clerici è la storia contemporanea di questo sport per quanto riguarda i racconti dai campi. Di lui sappiamo tutto: che è un dandy, che ama le divagazioni più delle storie e che è elegante e gentile. Chiacchiere in libertà con un uomo d’altri tempi che tutti vorremmo avere come zio

Agli Internazionali d’Italia di solito ci si abbronza, quest’anno a momenti ci si ustionava. Il maggio romano quest’anno è stato più caldo del solito, torrido per molti giorni. È per questo che Gianni Clerici, oltre al taccuino di ordinanza sul quale segna gli appunti per i suoi articoli, quando esce dalla sala stampa per dirigersi sui campi porta sempre con sé un cappello da baseball color bianco, con la visiera senza sponsor sopra. Clerici, di solito, staziona nella zona riservata ai giornalisti, e raggiunge la tribuna del centrale quando fiuta l’odore di un match interessante. Per la maggior parte degli inviati, specie quelli di lungo corso, coprire un torneo è tutto un seguire i match dietro i comodi monitor della sala stampa, utili a coprire più campi per poi fare il sunto puntuale per i giornali del giorno dopo, aggiungendo praticamente nulla a quello che chiunque appassionato che abbia seguito i match, in tv o dal vivo, non sappia già. Con Clerici però la scrittura sportiva è assurta spesso a narrativa. E lui lo sa bene.
La nostra chiacchierata era stata fissata già prima del torneo romano. Quando lo avvistiamo nella zona della stampa a Roma, lui è circondato dal solito capannello femminile, genere sul quale continua ad avere un particolare ascendente. Stretta di mano, sorriso e saluti di rito: ci diamo appuntamento a un momento di tranquillità della settimana. “Pensa che ho già quattro interviste fissate”, ci fa mentre lo lasciamo nuovamente alle sue donne. Tutti vogliono ascoltare il suo parere, perché Gianni Clerici è un grande personaggio del tennis italiano. Se c’è McEnroe in Italia, da Fazio, si chiama Clerici a fargli una domanda, giusto per dirne una. Saranno stati i suoi libri, le sue telecronache, il suo dandismo: Clerici è un’icona del nostro tempo. E chi ha provato a conoscerlo al di là del tennis lo sa. Tutti i giorni, dopo avergli parlato sempre con il “tu” che è d’obbligo se vuoi rivolgergli la parola, abbiamo rimandato il nostro colloquio al giorno seguente. Alla fine è arrivata la domenica, l’ultima possibilità. Siamo in sala stampa e lui è sull’uscio che mangia un gelato. Ci invita a seguire al suo fianco, sul suo desk, la finale femminile, cui dedicherà “quattro righe delle mie quarantacinque che devo scrivere ogni giorno”. Così dice, mentre Sharapova e Suarez-Navarro giocano una partita che sembra appassionare gli altri giornalisti rintanati in sala stampa, all’ombra. Fuori, infatti, ci saranno almeno trentacinque gradi e allora meglio seguire questa partita in TV e assolarsi quando giocheranno i maschietti, Federer e Djokovic.
Ci sediamo di fronte al monitor e per prima cosa assolviamo una promessa fatta qualche giorno prima, ovvero il consigliargli, per l’acquisto, uno dei libri scritti da Francesco Pacifico, uno scrittore che lo ha intervistato qualche tempo fa e che deve averlo divertito e incuriosito, tanto che lo Scriba ha deciso di leggerlo. Gianni è molto attento quando parliamo. Appunta su carta il titolo del libro (“Storia della mia purezza”) e poi iniziamo a chiacchierare, fuori dal classico schema domanda-risposta.
“Aspetta che io sono molto disordinato. Dài, vediamo se riusciamo a farci questa chiacchierata. Mettiti comodo anche tu così puoi seguire la partita”. “Grazie Gianni, ma il tennis femminile non lo seguo molto, anche se apprezzo il rovescio della Navarro”.
Il vociare indistinto della sala stampa ha un volume più basso dei rantoli di Maria Sharapova, che mette a segno dei punti terrificanti in quanto a potenza. “Questa è implacabile. Secondo me è cattivissima”. Dovremmo chiederlo a Grigor, gli diciamo. “Lei è molto affascinante in un certo modo, è così statuaria”. E Suarez-Navarro? Che sia la nuova Arantxa Sanchez? “Mah, Arantxa fu protagonista di una finale drammatica qui a Roma, quindi non glielo auguro. Ma sai che ha avuto dei problemi con i fratelli recentemente? Storie di soldi rubati, con i genitori coinvolti. Storie spaventose. Almeno così mi ha riferito un collega spagnolo, perché non credergli?”.
Quel che ha reso famoso Clerici agli appassionati di tennis, prima degli esordi in TV da telecronista, è stata la sua maniera di raccontare questo sport, diversa dai canoni del giornalismo sportivo. Gianni iniziò ai tempi di Brera. “Beh, Brera ha studiato al collegio Ghisleri di Pavia, dove per entrare bisognava avere una media altissima. Gianni era figlio di mezzadri, non proprio contadini. Era l’unico ad aver studiato in una famiglia di contadini: uno dei due fratelli era sarto, l’altro scriveva di pesca su Il Giorno. I Brera erano persone dalle origini umili. Lui aveva imparato molto dallo straordinario Ghisleri. Poi aveva fatto il paracadutista; in seguito, per ragioni misteriose, la Gazzetta lo mandò a Parigi. Ma lui è stato anche il primo in Italia, per esempio, a tradurre Arthur de Gabineau. Non le sue teorie che passano per razziste (“Saggio sulle ineguaglianze delle razze umane” ndR), ma i suoi stupendi racconti. Gianni ha tradotto i grandi scrittori francesi di origine italiane, come Jean Giono. E come Francois Cavanna, che per me è un genio, uno che in Italia non l’han conosciuto perché c’è molta ignoranza. E Brera li ha conosciuti tutti, e me li ha passati, perché io ero più piccolino. Lui era del ’20, oggi avrebbe 95 anni mentre io sono del ’30. Da lui ho imparato molto, non so se ho imparato per il giornalismo sportivo però”.
Però siete in pochi, in pochissimi a scrivere in questa modo. Come mai? “Non so perché”. Forse perché avete studiato? “Mah, forse perché ci hanno lasciato fare, magari ci sono difficoltà per qualcuno che comincia a fare delle stranezze nello scrivere. Io nella mia vita – non la chiamo carriera perché non la considero tale in quanto le cose che ho fatto le ho fatte per non dover lavorare – ho trovato un paio di ostacoli un paio di volte, come li aveva trovati Brera. Gianni è stato addirittura licenziato dalla Gazzetta dello Sport perché aveva scritto non so più neanche cosa. Poi si riprese con Il Giorno. Diciamo che spesso te lo impediscono di scrivere in un modo un po’ insolito”.
Per uno che si cimenti, la regola è sempre la solita: leggere e studiare. Vero? “Sì”. Però ogni giorno in Italia vengono pubblicati 164 libri. “Ma va?”. Eh sì, quindi da dove si parte? “Dai classici. E poi si individua qualcuno che può insegnarci qualche cosa e poi si cerca di imparare. Sai, non so perché io ho fatto giornalismo, forse per sbaglio visto che avrei voluto fare tante cose. Vengo da una famiglia di imprenditori, il tennis mi ha aiutato a fuggire dalla imprenditorialità. Chissà se ho fatto bene”.
Intanto davanti al suo desk, che è il primo della sala stampa più vicina all’ingresso, e quindi la più importante secondo le gerarchie romane, la gente passa e gli rende omaggio. “Maestro, mi lasci essere un po’ ossequioso” gli fa un giornalista di Sky che interrompe la corsa verso la sua postazione, dove farà la diretta a breve. Gianni sorride, felice di questo affetto che tutti sembrano rivolgergli come tributo a chi ha fatto molto per questo sport, perlopiù con le parole, lette o ascoltate.
Quindi è uno scrittore prestato allo sport, come vuole la frase che più spesso è usata per descriverla, o no? “Ma sai questa è una presunta definizione di Italo Calvino. La ripeteva sempre un grandissimo giornalista specializzato soprattutto in ciclismo e scalate in montagna perché a Monza – che pronuncia con la z delicata – c’è un grande centro di alpinismo. Questi si chiamava Mario Fossati, il quale è stato molto bravo. Io ho seguito due Giri d’Italia con lui, che sapeva tutto. Era bravissimo. Pensa che lui fece anche l’alpino in Russia e, poverino, gli toccò un compito orribile. Quando morirono dieci suoi commilitoni, dovette annunciarne la morte ai genitori dei ragazzi, a Monza. Andò a dire alle mamme e al papà di queste dieci famiglie che il loro figlio era morto. Raccontai questa storia in un articolo per Repubblica in occasione dei suoi 90 anni”.
Lei ha iniziato a giocare ad Alassio, in un circolo dallo stile colonial. “L’Hanbury”, afferma quasi sobbalzando sulla sedia. Ricorda ancora il nome del suo maestro? “Mister Sweet! Ne ho parlato in una finta biografia che si chiama Gesti bianchi”.
Tennista di buon talento sempre sconfitto, lei si è definito fallito perché non ha mai vinto Wimbledon, dove peraltro ha giocato. “Ma sai, avevo delle crisi di natura umana, per le quali venni deriso anche da alcuni miei compagni di squadra all’epoca, fra i quali anche Fausto Gardini”. La conversazione divaga su racconti di tempi oramai andati, storie personali e stravaganti ambientate in posti e tempi immaginifici per i più, con donne, politica e rapporti personali nel mezzo. Insomma: le classiche divagazioni di Clerici che si ascoltano in maniera assorta, con la sua voce che scandisce bene le parole di queste storie spesso non riassumibili. La parte riportabile del suo fallimento tennistico riprende quando dice che “questi problemi me li sono trascinati dietro per molto tempo e temo ebbero impatto sul mio tennis. Ma fallii anche per una presa di diritto sbagliato”.
Di solito, quando si smettere di giocare si insegna. “Ho insegnato tennis per un anno intero a Como, dove trovai però un presidente di circolo che era un cretino. Essendo io di famiglia benestante, gli avevo chiesto di organizzare una scuola tennis. Lui disse di no, perché così avremmo occupato i tre campi coperti. Allora, grazie al mio papà, prenotai i tre campi coperti per tutto l’inverno e organizzammo la scuola, grazie al maestro Monetti, bravissimo. Lui fu semifinalista ai campionati junior, giocava bene. Nella nostra scuola avevamo anche un preparatore atletico e facevamo giocare, rigorosamente in maniera gratuita, tutti i bambini di quarta e quinta elementare, cui fornivamo racchette e pallette per giocare. Quello che dovrebbe fare la Federazione oggi. Poi mi sono stufato”.
Meglio scrivere? “Beh, meglio fare altro”. Poi è stato male, e smise definitivamente. “Giocai un torneo a Beirut, un grande torneo dove vinsi il doppio, specialità nella quale, nel frattempo, mi ero specializzato. Ho avuto una infezione virale che si rivelò peggio dell’itterizia, perché aveva origini non chiare. E questo mi costrinse a cambiare sangue due volte, oltre che a trascorrere tre mesi in ospedale. Per fortuna i medici, miei amici, mi lasciarono tornare a casa visto che in ospedale ero stato perlopiù in isolamento. A Beirut feci anche semifinale in singolare, un risultato dignitoso: oggi quel torneo sarebbe un 1000. E quindi smisi a 24 anni, prestissimo, soprattutto per quei tempi. Allora si è era junior fino ai diciotto anni ma, ad esempio, la famosa coppa Macomber, che si giocava a Montecarlo e che era un campionato europeo dei giovani, si giocava fino ai venti. Cose incredibili – dice mentre sorride – oggi che iniziano a giocare tutti a due anni. All’epoca diventavi un bravo tennista attorno ai ventidue, ventitré anni”.
Poi arriva la letteratura, i libri, la TV, non prima del “no” detto a Silvio Berlusconi. “Ero andato a casa sua due volte. Mi propose di dirigere sport e cultura delle sue tv. Io, che avevo fuggito l’ufficio di mio padre, dissi no. Sono stato fortunato a poterlo fare perché non ne avevo bisogno. Avessi avuto bisogno di arrivare a fine mese per pagare il salumiere avrei detto sì. Allora Berlusconi era ancora una brava persona, un self made man che non si era ancora distinto per le nefandezze del poi. Cominciai a fare tv un lunedì, quando commentai un dischetto sottratto abusivamente a Wimbledon, portato a Milano da un pilota dell’Alitalia. Feci la telecronaca del match con il maestro di tennis di Berlusconi, Romano Luzzi, poi diventato un ricchissimo uomo d’affari. Lui era di Perugia, che è sempre stato un centro di buona leva tennistica”. Dove c’è Castellani, tanto per dirne uno. “Sì, che ora dirige una grande scuola tennis messicana assieme a Voinea. Mi hanno anche invitato ad andare a trovarli”. Tireranno fuori qualcuno? “Forse sì”.
Come è stato commentare in TV all’inizio? “Mi sono trovato benissimo perché non ho mai pensato che fosse diverso dallo stare in tribuna stampa. Io ero abituato alle tribune stampa del calcio, dove si parla sempre. Perché io ho fatto calcio per una decina d’anni, prima che venissi aggredito dai tifosi. Quando entri in un giornale, per riuscire ad accedere al posto di redattore o di inviato, devi occuparti di calcio o della cronaca nera. Ho provato la nera per due articoli e poi ho detto: per piacere fatemi fare il calcio. Quindi ero abituato a questi dialoghi della tribuna. E poi anche nel tennis, in tribuna, abbiamo sempre chiacchierato”.
Un altro giornalista interrompe la nostra conversazione. Ha in mano una copia di “Wimbledon”, la raccolta degli articoli di Clerici da corrispondente londinese, e chiede allo Scriba di autografarla. Se c’è una cosa che un po’ lo delude alla richiesta di un autografo è quando gli si chiede di siglare uno dei suoi scritti sportivi. Porgetegli una copia di “Australia Felix” o di “Una notte con la Gioconda”, e vedrete Gianni illuminarsi in volto, ebbro di gioia per i romanzi di cui va fiero e che vorrebbe più letti dei suoi grandi successi, “500 anni di tennis” su tutti.
Quando il giornalista deposita la copia di “Wimbledon” sul desk, inizia un dialogo dei più classici:
“Vengo da Anghiari, il paese della battaglia”.
“Oh mamma, che impressione. Lasciamelo un momento che stiamo facendo una cosa”.
“Non lo vendere eh, io l’ho comprato”.
“Bene, Ti devo almeno 3 euro che è la mia royalty”.
Lo saluta con un “ciao” che tradisce quel tono leggermente snob, altoborghese. Ora però c’è un problema: Clerici ignora il nome di questo giornalista. Quindi, complice anche la figlia che lo cerca al telefono (“Ciao, sono il Clerici”, esordisce), sospendiamo la chiacchierata per scoprire l’identità del tipo. Non otteniamo risultati e quindi gli suggeriamo di propendere per una dedica impersonale, che citi il paese natio del giornalista. Clerici raccoglie la proposta e scrive: “A chi sopravvisse la battaglia di Anghiari…”, bollando come riciclo il suo libro (“sono tutti articoli”). “Basterà questa dedica?” ci chiede. Basterà.
Quanti romanzi dei suoi ha autografato quest’anno? “Venti o trenta”. E poi, con tono assertivo: “Sai, io non faccio parte della società massonica degli scrittori in Italia. Se tu non ne fai parte, come me, e se in più hai il marchio d’infamia di scrivere di sport, allora addio. ‘Wimbledon’, comunque, ha venduto 27mila copie; la mia media è di 5000, che è tantissimo in Italia”. Clerici però sta per tornare sul mercato dei libri con scritti originali. “Adesso pubblicherò per Mondadori una ‘eterografia’, chiamata così perché io parlo degli altri, ma temo ci sarà una lite sul titolo. Ho scritto, inoltre, un altro romanzo per Baldini-Castoldi, che ripubblica anche i miei vecchi romanzi, qualcuno dei quali merita. Il nuovo libro narrerà una storia straordinaria della quale si è interessato anche George Clooney, mio vicino di casa, che vuole farne un film. La storia narra di quello che succederà fra 30 anni: si dovrebbe chiamare fantascienza, ma invece è quello che accadrà fra tre decadi”.
Qualcuno oggi, in TV, avrebbe l’ardire di cantare “Bongo bongo”?
“Ma si è trattato di un equivoco”.
Come prego?
“Rino amava Sanremo. Sai che organizzava sempre una serata a casa sua con le scommesse su chi vinceva il festival? Io poi, insomma, conosco un po’ l’opera lirica. E un giorno, in attesa del collegamento, ci mettemmo a cantare. Da Milano ci dissero: ‘Attenzione: vi sentono!’. E noi siamo andati avanti ed è diventata un sigla. È stato divertente”.
Intanto Sharapova e Suarez-Navarro sono 5 a 5 nel secondo set. E quindi la finale femminile si allunga, con quella maschile che si giocherà, si spera, con un clima meno torrido. Gianni segna un momento chiave del punteggio, rigorosamente su carta, per riempire quelle quattro o cinque righe dell’indomani. Ci sarebbe da chiacchierare di tennis, scadere nelle solite considerazioni sulle quali Clerici si è espresso più volte. Federer, il più grande di tutti i tempi, i paragoni con il passato, la crisi di Nadal, il super Djokovic, oppure McEnroe e quanto fu audace nel suo “You cannot be serious” rivolto all’arbitro. Ma sarebbe tempo sprecato, e tutto un già sentito. “Il tennis è iniziato in Inghilterra nel 1870, sai quante ne avranno dette i fratelli Doherty? Uno era domatore di elefante credo, chissà quante ne avrà fatte”. Però gli chiediamo solo della partita finale del torneo maschile, Federer contro Djokovic, dopo che un anno fa definì omerico il duello fra Djokovic e Nadal.
“Questo duello è un po’ diverso, è la contemporaneità contro una riedizione del passato, come Federer. Roger è un giocatore da racchetta di legno, l’unico che potrebbe giocare con un legno, gli altri la manderebbero tutti in tribuna. Oggi vedremo la contemporaneità sfidare un ipotetico precedente storico”.
Iniziamo a divagare anche noi, visto che la finale femminile volge al termine e c’è da andare in tribuna stampa a prendere posto per la finale maschile. Rino Tommasi dice che era più forte di lei a tennis. “È vero: ho sempre perso contro di lui”. Non ci convince. Insistiamo: dice che lei era convinto di essere più forte di lui. “Rino è stato fortissimo. Non è però mai uscito dalla seconda categoria, non ha mai fatto tornei internazionali. Però scrivi pure che era più forte di me”, ci suggerisce mentre sorride sornione, forte del suo understatement. Passa qualche minuto e torna sulla vicenda: “Io ho vinto sei tornei internazionali, buttali via”, dice il Clerici romanizzato. “Dovremmo ricordarlo a Rino, che non può mentire così”, e sorride.
È passata un’ora buona, forse anche più. Il tono accomodante di Clerici ci accompagna nell’ultimo ricordo della nostra chiacchierata, che lo riporta indietro di molti anni quando partecipò al torneo di Mentone, dove in finale incontrò il francese Henri Cochet. “Lo incontrammo in doppio, io e il mio amico Bergamo, che era un buon giocatore meglio di me. Ho giocato con Cochet in gara e mi sono allenato a Parigi con Borotrà, per partecipare al primo campionato Junior di Francia. Quando in quel torneo battei un tennista francese, che poi si fece largo negli anni seguenti in una edizione del Roland Garros, dalle tribune scese in campo un signore ad abbracciarmi. “Lei diventerà un grande campione”, mi disse. Ma era omosessuale”. Risate. Lo ringraziamo e ci congediamo, non prima di rassicurarlo per l’ennesima volta sull’efficacia della dedica scritta poco prima sul libro. E lui: “Spero che il tipo non la legga davanti a me. Le dediche non si leggono mai in presenza del dedicante: è come guardare uno che fa la pipì”.