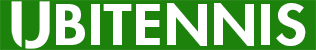evidenza
Ivan Ljubicic e l’elefante nella stanza
Il 45° compleanno dell’ex numero 3 del mondo Ivan Ljubicic: la fuga dalla guerra, la svolta italiana, la favola di Indian Wells, il rapporto con Roger Federer

“Ivan, tu mi devi convincere che sono più forte di Nadal”
Se questo biglietto di auguri avesse una copertina l’immagine sarebbe un elefante: ‘l’elefante nella stanza’ è infatti un’espressione mutuata dal mondo anglosassone utilizzata per indicare una verità scomoda, una difficoltà che preferiamo non affrontare, un problema che vogliamo evitare, rimuovendo o minimizzando ciò che ci turba o ci fa sentire a disagio.
Roger Federer decise di togliersi il paraocchi in un tranquillo pomeriggio londinese e di affrontare finalmente l’elefante della stanza della sua carriera. Per superare questo ostacolo mentale- ancora prima che tecnico- aveva però bisogno di una mano, aveva bisogno di un amico, aveva bisogno della persona giusta, e aveva deciso che quell’uomo era Ivan Ljubicic.
La storia di Ljubo (45 anni oggi), raccontata da Sky nel documentario “L’uomo salvato dal tennis”, è una storia di contraddizioni, di attese e di sospiri di sollievo, è una storia in cui il prezzo da pagare per il successo e per la serenità è il prezzo della malinconia.
Mentre guardavo il documentario ho subito pensato a Jacob Riis (giornalista e fotografo che visse a cavallo del 20° secolo) e alla sua celebre citazione del tagliapietre, diventata il mantra di uno degli esperimenti sportivi meglio riusciti di sempre, e mi riferisco alla franchigia NBA dei San Antonio Spurs: “Quando tutto sembra perduto vado a guardare un tagliapietre che colpisce il masso cento volte, senza neppure riuscire a scalfirlo. Eppure al centunesimo colpo la pietra si spacca in due, e io so che non è stato quel colpo, ma tutti quelli che sono venuti prima”.
L’ADOLESCENZA E LA GUERRA
II primo colpo della vita di Ivan Ljubicic è stato inevitabilmente un rovescio, col suo primo allenatore, Vojo Sukalo, che gli consigliò di giocarlo a una mano. Un’intuizione in netta contraddizione con l’evoluzione del gioco, già incanalata, fin negli anni ’90, verso la direzione bimane. Fu la prima piccola svolta tecnica della vita di Ljubo, che intorno alla sua elegante sbracciata monomane costruì la maggior parte dei punti da fondocampo della carriera. Il secondo colpo fu invece il più duro di tutti, e ci riferiamo alla catastrofe della guerra civile, che lo costrinse a scappare da casa all’età di 13 anni. Scappare da casa, come suona male questa espressione. Ivan era nato e cresciuto a Banja Luka e la Bosnia Erzegovina, come ci viene ricordato all’inizio del documentario, era una repubblica multietnica composta per il 44% da musulmani bosniaci, per il 32,5% da serbi ortodossi e per il 17% da cattolici croati. Il 3 Marzo del 1992 la Bosnia dichiarò la propria indipendenza dalla Jugoslavia e un mese dopo i serbi, contrari all’indipendenza, assediarono Sarajevo.
La situazione si fece sempre più tesa, specialmente per i bosniaci-croati, anche perché proprio Banja Luka era a tutti gli effetti l’enclave e ‘capitale’ serba in territorio bosniaco. Di conseguenza la famiglia Ljubicic, verso la fine dell’Aprile del 1992, fu costretta a fuggire. Raggiunsero in qualche modo Rijeka (Fiume), in Croazia, spaventati da due sentimenti opposti: da un lato la speranza di tornare presto a casa, dall’altro la consapevolezza che questa cosa non sarebbe mai accaduta. La Croazia nel corso del 1992 accolse oltre 330mila profughi, e alla fine della guerra (che si concluse nel dicembre del 1995 con l’accordo di Dayton) il numero totale degli sfollati superò i 2 milioni, mentre i morti furono 100mila. “Io penso di essere diventato un grande atleta grazie a tutte le difficoltà che ho dovuto superare, e non ‘nonostante’ tutte quelle difficoltà”. Un colpo dietro l’altro.
MONCALIERI E RICCARDO PIATTI, LA SVOLTA ITALIANA
La svolta decisiva della vita e della carriera di Ivan fu una svolta italiana: l’Italia quella gentile, quella migliore, quella dell’accoglienza e della competenza. Un circolo di Moncalieri (Torino), le Pleiadi, invitò una decina di ragazzi croati, la cui infanzia tennistica era stata travolta dalla guerra, ad allenarsi in Italia. (Un’iniziativa simile è stata riproposta da I Tennis Foundation in favore di 4 tenniste ucraine, con forte sostegno proprio da parte di Ljubicic: “Sono arrivato in Italia grazie a progetto simile, all’epoca mi mancavano i genitori perché non esistevano telefonini e videochiamate”). In questa piccola città piemontese Ljubo si ambientò velocemente, ritrovando la forza e l’entusiasmo per prendere la rincorsa verso il professionismo, un sogno che cominciò a diventare realtà dopo la finale di Wimbledon Juniores del 1996.
“E poi arrivò Riccardo”. E questo fu un colpo più importante degli altri.
Riccardo è ovviamente Riccardo Piatti, un allenatore che ai tempi aveva già portato tra i primi 20 giocatori del mondo Renzo Furlan e Cristiano Caratti, e che decise di puntare tutto su questo giovane uomo croato senza nemmeno un ranking ATP: “Come si dice in questi casi? Sarebbe riduttivo definirlo solamente un allenatore: Riccardo Piatti era un padre, un punto di riferimento, Riccardo era tutto, vivevo con lui, pendevo dalle sue labbra. Nel corso dei primi mesi, per non dire anni, è rimasto al mio fianco nonostante non potessi pagarlo. Aveva investito su di me, il nostro primo torneo insieme fu un satellite in Puglia”.
Ivan ha scalfito la pietra della sua carriera un colpo alla volta, si è sudato ogni tappa, soffrendo passo dopo passo, una settimana dietro l’altra: la convocazione in Davis, l’ingresso in top 100, il primo titolo ATP. Il documentario si ispira ad un’altra storia slava di grande impatto, quella dei cestisti Drazen Petrovic e Vlade Divac, raccontata nello splendido “Once Brothers” di ESPN: quella produzione americana cercava di addolcire la pillola di una vicenda cruda e drammatica con una patina a tratti fastidiosamente mielosa, mentre quello di Ljubo è un racconto più lineare, più secco, che inquadra in primo piano la serenità della passione e del lavoro.
Se non fosse per il sottofondo inquietante della guerra la sceneggiatura della vita del campione croato sarebbe perfino romantica: una sceneggiatura anacronistica, se guardata con gli occhi di oggi, che riassume al meglio il fascino senza tempo ma anche tutte le contraddizioni del tennis, lo sport globale per eccellenza. Il mondo tennistico del 2024 è infatti caratterizzato dalla mitomania di alcune accademie che di prestigioso hanno soltanto il nome e la vetrina: laboratori vuoti che vendono sogni a pagamento e che producono, nel migliore dei casi, tennisti-robot. Lo staff delle Pleiaidi di Moncalieri, un piccolo circolo di tennis di una piccola città, ha fatto invece una cosa molto più potente, in tutta la sua semplicità: ha accolto, aiutato e cresciuto un ragazzo ambizioso e spaventato.
IL NUMERO 3 E LA FAVOLA DI INDIAN WELLS
La carriera sportiva di Ljubicic decollò definitivamente nel momento in cui arrivarono i risultati con la sua nuova nazionale: la medaglia di bronzo in doppio alle Olimpiadi di Atene (2004, in coppia con Mario Ancic) e soprattutto il trionfo in Coppa Davis (2005): “Fu in quel frangente che venne davvero riconosciuto dai croati, per lui fu importantissimo” racconta Piatti. Ivan riusciva finalmente a mettere la lettera maiuscola alla parola casa, e il suo tennis prese il volo: “Le settimane in Davis erano le più divertenti dell’anno, all’esordio avevamo battuto gli Stati Uniti a Los Angeles, era la prima volta nella storia che venivano sconfitti in casa al primo turno”.
Ljubicic ha avuto uno dei servizi più incisivi della storia moderna del gioco (“Il movimento era simile al mio” dice Ivanisevic, “ma la sua seconda era migliore”) e intorno a quel colpo meraviglioso ha costruito un gioco asciutto e sornione: il rovescio a una mano, elegante e naturale, aveva bisogno di tempo e di un rimbalzo lento, a causa dell’apertura piuttosto ampia, il dritto era invece faticoso e un po’ sgangherato. Ljubo aveva infine una buona sensibilità nel tocco ma era soprattutto uno dei migliori del mondo a giocare i punti importanti: obbligava l’avversario a pensare, gli metteva pressione, chiamandolo ad esempio a rete con uno slice volontariamente corto.
Nel 2005 le sconfitte in finale furono addirittura sei, ma tutte prestigiose, tre delle quali con Federer: Doha, Rotterdam e Dubai, le ultime due nel giro di una settimana. E poi, per chiudere la stagione, due incubi indoor con Nadal e Berdych: Ljubo perse infatti entrambe le finali dei due Masters 1000 sul cemento di fine stagione al quinto e decisivo set. Con Nadal a Madrid (unico titolo sotto ad un tetto della carriera di Rafa) sprecò un vantaggio di due set, con Berdych a Bercy fu invece Ljubo a rimontare, prima di arrendersi in volata. Raggiunse infine, a coronamento del miglior momento della vita, nel Maggio del 2006, il best ranking di numero 3 del mondo, dopo un’altra finale persa, a Miami, in tre tie break, ovviamente contro Roger (e contro un nastro beffardo sul match point) mentre i successi più iconici di quel periodo furono invece probabilmente quelli di Vienna (2005 e 2006): due titoli consecutivi, due trofei portati a casa senza perdere nemmeno un set e soprattutto senza subire neanche un break. Neanche un break, in due anni.
E poi? E poi, quando la pietra sembrava non volesse più spezzarsi, la California.
Ivan, oramai 31enne e in chiara fase calante, vinse infatti l’edizione del 2010 del Masters 1000 di Indian Wells, l’unico torneo al mondo che può davvero fregiarsi dell’inutile titolo di “quinto slam”. Nel giro di pochi giorni sconfisse, uno dietro l’altro, tre dei migliori otto giocatori del mondo: negli ottavi Novak Djokovic (numero 2), in semifinale- addirittura in rimonta- Rafa Nadal (numero 3) e in finale Andy Roddick (numero 8).
“Ho sempre giocato bene a Indian Wells, perché mi piacevano le condizioni di gioco: in mezzo al deserto non c’è umidità, la palla penetra nell’aria asciutta, la situazione ideale per il mio servizio. Allo stesso tempo però la superficie, ruvida e lentissima, mi concedeva tutto il tempo di cui avevo bisogno per impostare la manovra da fondocampo”.
Chiuse il torneo con l’ennesimo servizio vincente, corse subito dalla moglie Aida, abbracciò Riccardo, alzò verso il cielo del deserto il trofeo più importante di tutta la vita e poi sorrise. Il sorriso di chi ci aveva sempre creduto, il sorriso di chi, ormai, non ci credeva più: “…Eppure al centunesimo colpo la pietra si spacca in due, e io so che non è stato quel colpo, ma tutti quelli che sono venuti prima”.
LA CARRIERA DA ALLENATORE E IL RAPPORTO CON FEDERER
Una volta annunciato il ritiro (Montecarlo 2012) Ivan indossò i panni della risorsa: dicono che per un tennista la transizione dall’adrenalina della competizione al vuoto del post-carriera sia un passaggio delicato ma, nel caso di Ljubo, dicono male. Lui affrontò quella svolta con la stessa naturalezza con la quale annullava le palle break: nel giro di poche settimane il pubblico italiano scoprì un commentatore- sempre per Sky Sport- competente e ironico (“L’umorismo bosniaco è molto diretto”, parola di Goran), uno di quelli che riesce a raccontarti la partita senza la presunzione di volertela spiegare, uno di quelli che rispetta lo scambio con il silenzio, preannunciandoti il futuro del match nelle pause tra un’azione e l’altra.
Nel frattempo studiava da manager (tra i suoi clienti illustri ricordiamo ad esempio Tomas Berdych e Matteo Berrettini) e, soprattutto, da allenatore: “Ho capito molto velocemente che era una cosa che mi apparteneva”, e non avevamo dubbi. La sua prima esperienza da coach fu con Milos Raonic e poi, verso la fine del 2015, arrivò la telefonata di Roger Federer. Lo svizzero, grazie al carisma e ai consigli di Ljubo, tornò a vincere uno slam dopo oltre quattro anni (Australian Open 2017 e 2018, Wimbledon 2017), sconfiggendo oltretutto per cinque volte di fila il rivale di una carriera, Rafa Nadal, e mettendo in mostra un rovescio mai così efficace: “Gli avevo proibito di giocare il back, che con Nadal diventava un suicidio tattico: doveva colpire solo rovesci piatti, in anticipo, senza cercare la forza ma la profondità. Lo scopo era quello di togliere il tempo a Rafa, ci eravamo ispirati a Fernando Gonzalez”.
La finale dell’Australian Open del 2017 rappresenta inevitabilmente il simbolo emotivo di quel periodo ma il manifesto più nitido dell’impatto tecnico e tattico di coach Ivan fu l’ottavo di finale di Indian Wells vinto da Federer qualche mese dopo: la lezione finì 6-2 6-3 in un’oretta scarsa di gioco e, dopo aver subito l’ultimo rovescio vincente all’incrocio delle righe, Nadal, mai visto così rassegnato, decise saggiamente di salvare sé stesso dall’agonia del challenge, masticò tutta l’amarezza che aveva addosso e se ne andò.
Il tutorial del nuovo rovescio del campione svizzero si sviluppò in vari episodi, ribaltando- tra Melbourne, Indian Wells, Miami e Shanghai- l’inerzia di una rivalità a senso unico, ma, nel corso della semifinale del Roland Garros del 2019 una bufera di vento consentì a Nadal, il marinaio più esperto del circuito ATP, di rimettere le cose al loro posto. Quel vento agevolò una facile vittoria (sulla carta comunque probabile ma non del tutto scontata) dello spagnolo ma soprattutto risvegliò i vecchi fantasmi nella testa del genio di Basilea, spaventato dalla possibile e imminente rivincita di Wimbledon. E infatti.
E infatti qualche settimana dopo quei fantasmi diventarono troppo concreti per essere ignorati e alla vigilia della semifinale dei Championship’s Roger, a quasi 38 anni, spalancò finalmente le porte del suo inconscio, come quando dopo un paio di bicchieri di vino troviamo il coraggio di guardare negli occhi le altre persone: “Ivan, tu mi devi convincere che sono più forte di Nadal”.
Ljubo e Federer affrontarono insieme l’elefante: “Io ero sotto shock”, racconta Ivan. “Tenete conto che Roger era reduce da sei vittorie nelle ultime sette partite con Rafa, non pensavo potesse temerlo ancora così tanto. Ci siamo seduti, abbiamo parlato per un’ora, e il giorno dopo ha vinto. Nessuno purtroppo si ricorda di quella partita, perché meno di 48 ore dopo perse la finale con Djokovic, sprecando due match point consecutivi. Ma penso sia stata una delle vittorie più significative della sua carriera e a fine match io, travolto dall’emozione, sono uscito dal Centrale, ho allungato la strada verso gli spogliatoi, ho trovato un angolo tutto per me e mi sono messo a piangere”.
Ivan, la persona giusta. Ivan, la risorsa: “Penso che senza di me non avrebbe vinto quell’incontro, è stata la più grande soddisfazione della mia carriera da allenatore”.
LE LACRIME E LE CREPE
Nel corso del documentario Ljubicic, sorretto dalla forza delle proprie lacrime, decide di fare i conti, colpo dopo colpo, col suo personale elefante, ritornando nei luoghi più significativi di una storia lunga quasi mezzo secolo, come in una specie di pellegrinaggio emotivo, a tratti angosciante, a tratti commovente. “Questa è la casa dove sono cresciuto, non tornavo qui da più di trent’anni”, e diventa francamente complesso aggiungere altre parole.
Ivan è nato il giorno della festa del papà e proprio grazie al padre si è appassionato agli scacchi: “Sì, è vero, ho insegnato di tutto ai miei figli, dagli scacchi al codice Morse, volevo assicurarmi che avessero una buona istruzione. Nella crescita personale ci dovrebbe essere anche lo sport”.
C’è però un aspetto che mi ha colpito più di tutti gli altri della storia e del documentario di Ljubo: gli uomini-chiave della sua vita e della sua carriera hanno tutti la stessa faccia. Il primo maestro, Vojo Sukalo, il presidente del Tennis Club Le Pleiadi, Carlo Bucciero, il coach storico, Riccardo Piatti, il capitano della squadra di Davis del 2005, Nikola Pilic, e, infine, proprio il padre Marko: occhi piccoli e faccia fiera, severa, segnata dalle rughe. Quelle rughe che, però, al posto di scalfire il volto, lo compattano, approfittando di una specie di curiosa illusione ottica.
Già, le crepe che rendono più forti: una buona sintesi, tutto sommato.