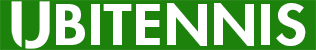Al femminile
Kerber vincitrice degli Australian Open contro Serena Williams. Come è stato possibile?
Le ragioni tecniche e psicologiche della partita agli Australian Open che ha determinato un successo storico per il tennis femminile. Ecco perché non è una definizione eccessiva

Lo Slam appena concluso ha proposto moltissimi spunti interessanti, tanto che nello spazio di un solo articolo non è possibile trattarli tutti. Per questa settimana mi dedico alla vincitrice, Angelique Kerber, e ai temi tecnici della finale, ma conto di tornare sugli altri argomenti prossimamente.
Gli ultimi Australian Open sono stati un crescendo: iniziati con tante eliminazioni eccellenti e match non particolarmente memorabili, si sono invece conclusi con una partita appassionante, in cui proprio il set conclusivo è stato il migliore dei tre giocati. Sotto questo aspetto il torneo di Melbourne è stata una di quelle storie di sport perfette per essere ricordate e raccontate, con il clou proprio al termine dell’evento.
Ma la finale di Melbourne ha coinciso anche con il clou della carriera di Angelique Kerber, che nella sua vita sportiva di fasi di crescita importanti ne ha vissute almeno due.
Il primo grande salto in avanti era avvenuto tra il 2011 (semifinalista agli US Open da sconosciuta numero 92 del mondo) e il 2012 (altra semifinale a Wimbledon).
Dopo quel biennio si era assestata in top ten grazie a tanti buoni piazzamenti, ad un paio di vittorie in tornei International e a diverse sconfitte in finale in tornei di livello Premier. Ma oltre pareva non fosse in grado di andare; anzi, all’inizio dell’anno scorso sembrava che la parabola di Angelique stesse cominciando la fase discendente, dopo una serie di sconfitte al primo o secondo turno. In febbraio era uscita dopo tre anni dalla top ten e si era separata dal coach Benjamin Ebrahimzadeh.
La crisi sembrava diventare sempre più profonda e il ranking peggiorava (numero 16 in aprile), ma improvvisamente in maggio era arrivata la svolta; dopo essere tornata a collaborare con il suo storico coach Torben Beltz aveva vinto la finale di Charleston contro Madison Keys. Nel prosieguo della stagione aveva vinto altri tre tornei Premier, su tutte le superfici possibili: dopo l’har-tru della Carolina del sud, la terra rossa di Stoccarda, l’erba di Birmingham e il cemento di Stanford; e sempre al terzo set dopo match combattutissimi.
Come ho già avuto occasione di scrivere, Kerber è una giocatrice piuttosto atipica sul piano tecnico: non soltanto perché mancina (che però utilizza la destra per scrivere), ma anche perché ama di più colpire in corsa che da ferma: ed effettivamente è meno fallosa quando affronta la palla dinamicamente rispetto a quando lo fa con i piedi ben piantati a terra. A questo si aggiunge la propensione ad esaltarsi nelle fasi difensive piuttosto che in quelle offensive.
Ma forse la caratteristica più anomala di Kerber è questa: molto solida su tutti i colpi di contenimento, quando invece vuole spingere non ha un lato più forte tra dritto e rovescio, quanto una combinazione tra le due parti.
Angelique infatti si trova meglio nell’esecuzione del dritto lungolinea e del rovescio incrociato. E visto che è mancina, questo significa che i suoi due migliori colpi di attacco finiscono per insistere verso la stessa zona di campo avversaria: l’angolo del dritto delle giocatrici destre.
Al contrario fatica di più a spingere il dritto incrociato e il rovescio lungolinea: quindi la geometria ci dice che non riesce ad essere ugualmente incisiva verso l’angolo opposto. E infatti in alcuni match, contro avversarie che non tengono conto di questa sua particolarità, arriva a totalizzare il 90% di vincenti indirizzati nella stessa zona di campo.
Con il passare degli anni sempre più giocatrici hanno compreso questa caratteristica di Kerber; e dunque quando si sono trovate a dover difendere in situazioni difficili hanno cominciato a coprire sistematicamente il lato del proprio dritto. Se a questo aggiungiamo che Angelique non possedeva un gran servizio (poco più che una rimessa in gioco) e nemmeno una risposta particolarmente incisiva, si capisce come faticasse ad andare oltre un certo limite di rendimento. Doveva quindi sperare di fare la differenza facendo leva soprattutto sulle qualità difensive e lo spirito battagliero.
Nel 2015 queste doti l’hanno portata a dare vita a molti match appassionanti, tanto che negli Stati Uniti l’avevano definita la migliore “supporting actress” del tennis femminile. In italiano traduciamo l’espressione (che viene utilizzata per i premi Oscar) come “attrice non protagonista”; e quello sembrava il livello massimo a cui Kerber potesse aspirare nel circuito: personaggio importante, ma di supporto e di livello inferiore rispetto alle stelle del tennis femminile, cioè le giocatrici in grado di vincere gli Slam. Invece il successo di Melbourne l’ha trasformata improvvisamente in “leading actress” (attrice protagonista).
Quando avevo scritto di lei un paio di anni fa, avevo suggerito che la sua storia sembrava perfetta per essere raccontata al cinema. E direi che il percorso nel torneo australiano sembra altrettanto perfetto come episodio finale della sceneggiatura. Con l’inizio thriller determinato dall’esordio contro Misaki Doi (6-7, 7-6, 6-3: ha corso il rischio di uscire al primo turno senza nemmeno vincere un set, salvata sul match point da una risposta fuori della sua avversaria), poi il momento del superamento dei propri limiti contro Vika Azarenka (che non aveva mai battuto in carriera), sino al trionfo conclusivo contro un’avversaria considerata quasi imbattibile come Serena Williams.
In realtà il successo australiano non è solo una storia con l’happy end, è soprattutto il frutto di un concreto e impegnativo lavoro di affinamento compiuto tra i 27 e i 28 anni (è nata il 18 gennaio 1988) su diversi aspetti del suo tennis, che potremmo definire la seconda fase di crescita dopo quella del periodo 2011-12.
Innanzitutto il progresso è stato fisico: l’anno scorso Angelique ha perso alcuni chili e questo ha reso ancora migliore la già notevole mobilità, facendo del suo gioco di contenimento uno dei più efficaci, se non il più efficace del circuito.
Poi, rendendosi conto che ormai troppe avversarie conoscevano e anticipavano le sue mosse, ha cominciato a ragionare tatticamente sull’effetto sorpresa: proponendo cioè attacchi verso l’angolo per lei peggiore, per cercare di minare le certezze in chi ormai l’aveva inquadrata come una giocatrice molto prevedibile nelle geometrie di palleggio.
Infine, durante l’ultima off-season, è riuscita a migliorare l’incisività al servizio, e nei primi match del 2016 ha cercato di accrescere l’aggressività in risposta. Contro Azarenka ha saputo mettere a segno alcuni ace in momenti importanti del match, e si è ripetuta poi contro Serena. Non si è trattato di moltissimi punti, ma rispetto a prima hanno significato comunque un progresso nel rendimento complessivo, e si sa che a volte bastano pochi quindici per spostare l’equilibrio di una partita.
Ci sono poi le palle corte: in finale le hanno procurato due punti fondamentali nel game più combattuto (poi vinto per salire 4-2 nel terzo set); in realtà sono una soluzione che è sempre stata presente nel suo repertorio. Per la verità di solito esegue un unico tipo di drop-shot (il rovescio lungolinea) e se ha colto impreparata Serena probabilmente è stato perché nel corso del match non lo aveva mai utilizzato prima. Del resto Angelique tende a proporlo nei momenti in cui sale la pressione e ha qualche dubbio sulle direzioni di gioco del palleggio da fondo.
Questo insieme di cose le ha consentito di raggiungere quello che a mio avviso rimane comunque un successo storico per il tennis femminile.
Perché storico? Si potrebbe pensare al fatto che Serena ha perso una finale Slam dopo cinque anni (Stosur, US Open 2011) e addirittura per la prima volta nella carriera una finale di Major al terzo set (8 vittorie su 8 prima di sabato scorso); ma la definizione sarebbe eccessiva.
In realtà questo successo è storico per una aspetto ancora più strutturale del tennis femminile: da più di dieci anni tutti gli Slam (senza eccezioni) erano stati vinti da giocatrici che prediligono il gioco offensivo, o quanto meno un tennis in cui l’aggressività e il mantenimento del controllo dello scambio sono prioritari. Mai una “difensivista” come Kerber era riuscita a prevalere in oltre quaranta edizioni di un Major femminile, e per trovare il successo di una giocatrice di contenimento direi che occorre risalire al 2004 (Roland Garros, Anastasia Myskina).
A mio avviso la ragione del predominio è questa: a differenza degli uomini, per le donne lo Slam è un torneo sempre disputato due set su tre, ma con in più il giorno di riposo tra un turno e l’altro; questo consente alle attaccanti, che praticano un gioco più rischioso e che richiede maggiore lucidità, di approdare più riposate e incisive nei turni finali rispetto ai normali tornei WTA. Nei tornei WTA invece, che prevedono cinque partite nell’arco di una sola settimana, nelle fasi finali la stanchezza influisce di più, e favorisce chi pratica un tennis meno rischioso e più conservativo.
Va detto che per raggiungere questo successo Angelique ha dovuto comunque migliorare la sua capacità offensiva, sia nei colpi di inizio gioco che durante lo scambio. Non è quindi un caso che contro Azarenka sia riuscita a mettere a segno più vincenti della sua avversaria (31 a 28), ottenendo cosi contro Vika il primo successo in carriera dopo sei sconfitte consecutive.
In finale la qualità difensive di Kerber hanno invece contribuito a evidenziare il limite maggiore della Serena attuale, che è strapotente ed esplosiva, ma che fatica a recuperare lo sforzo dopo gli scambi prolungati. E penso che in questo momento della carriera di Williams siano proprio le giocatrici che riescono ad allungare il palleggio quelle che hanno più possibilità di contrastarla.
Abituata a condurre un tennis da “sprinter”, basato cioè sull’uno-due e deciso dai colpi di inizio gioco, Serena soffre se la partita si allunga e si trasforma: non dico in una maratona, ma quantomeno in una gara di mezzofondo; situazioni che mettono in difficoltà una atleta che negli anni ha aumentato l’esplosività a scapito della resistenza. Ad esempio nel sesto game del terzo set della finale (quello più combattuto) ad un certo punto Serena ha dato l’impressione di trovarsi in debito di ossigeno, e di sicuro questo non l’ha aiutata a servire al meglio. E probabilmente non è un caso che dopo i due scambi vinti da Kerber con il drop-shot, Williams abbia commesso due doppi falli.
Consapevole di questo, nella finale di sabato Serena ha attuato una scelta tattica del tutto ragionevole: ha spesso cercato la rete per evitare di scambiare troppo a lungo da fondo; solo che poi ha commesso molti errori, anche su volèe non impossibili. In realtà da giovane a rete sapeva giocare piuttosto bene, ma nel corso degli anni ha progressivamente abbandonato lo schema attacco/volèe a favore del vincente definitivo da fondo, e penso che la desuetudine a concludere in avanti si sia fatta sentire.
A questo proposito ci sarebbero da aggiungere diverse altre cose sul tennis di Serena e su come si sia trasformato negli ultimi anni, ma per ragioni di spazio rimando ad una prossima occasione.
Riguardo al confronto di stili proposto dalle giocatrici in campo, direi che la finale di Melbourne si può avvicinare ad un altro grande match degli ultimi anni: la semifinale del Masters di Singapore del 2014, quando Serena finì per vincere solo al tiebreak del terzo set contro la migliore Caroline Wozniacki degli ultimi anni.
Anche allora aveva trovato un’avversaria in grado di allungare il palleggio, e di farle sistematicamente giocare il classico “colpo in più”, e che però non rinunciava al contrattacco per chiudere lo scambio. In questo modo Serena era stata portata al limite sul piano della resistenza fisica; al Masters aveva vinto per un soffio (2-6, 6-3, 7-6), mentre a Melbourne non ce l’ha fatta (4-6, 6-3, 4-6). Forse è accaduto perché nel frattempo sono passati 15 mesi, e alla sua età questo potrebbe contare, o forse perché a Singapore giocava con meno pressione che in Australia.
Lo dico perché nella finale lo scarso rendimento nel primo set (23 gratuiti) e la giornata non eccelsa al servizio di Serena, potrebbero avere la stessa ragione che ha inciso sulla sconfitta agli ultimi US Open: la pressione da Grande Slam.
Certo, a New York il traguardo era molto più vicino, ma in realtà se si parte fin dall’inizio della stagione con quell’obiettivo anche il primo Major è determinante. E visto che Mouratoglou aveva dichiarato che Serena poteva conquistare addirittura il Golden Slam (i quattro Slam più le Olimpiadi), allora si capisce che il tassello di Melbourne 2016 era indispensabile quanto quello di New York 2015.
E la mia personale interpretazione dell’ammirevole atteggiamento di Serena a fine match, estremamente sportivo e sorridente, è che in parte derivasse dal sollievo di essersi definitivamente tolta di dosso il peso del “maledetto” Grande Slam. Finalmente con la sconfitta in Australia non se ne parlerà più almeno per dodici mesi, e potrà giocare libera da stress supplementari, con la certezza che nessuna sconfitta potrà riproporre lo choc vissuto l’11 settembre 2015 contro Roberta Vinci.
Un’ultima curiosità: nel 1984 Martina Navratilova aveva fallito la rincorsa al grande Slam esattamente come Serena, cioè perdendo in semifinale dell’ultimo Slam stagionale dopo aver vinto il primo set (6-1, 3-6, 5-7 contro Helena Sukova). L’anno successivo aveva mancato la possibilità di inseguire nuovamente l’impresa perdendo in finale nel primo Slam stagionale: era stata sconfitta in tre set dopo aver vinto il secondo (3-6, 7-6, 5-7 da Chris Evert). Ancora una volta esattamente come Serena.