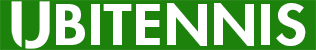Racconti
Storie di tennis: il lungo viale del tramonto di Andy Murray e la calda estate di Jimmy Connors
L’orgoglio dei campioni che non si arrendono al tempo. Da una parte Murray, fermato dal Covid, che è a Biella per giocare le quali di un challenger. Dall’altra la cavalcata di Jimmy Connors allo US Open 1991. Quando Jimbo entrò nella pelle delle pubblico

Nel film del 1962 “Una faccia piena di pugni” Anthony Quinn interpreta la struggente vicenda di un ex campione dei pesi massimi, Luis Macigno Rivera. L’età e le precarie condizioni fisiche gli impediscono di combattere ancora e lui – incapace di adattarsi a una vita lontana dai riflettori e assillato da problemi economici – decide quindi di ripiegare sul wrestling accettando di esibirsi per pochi dollari. L’indimenticabile immagine finale ce lo mostra mentre danza travestito da indiano su uno squallido ring di provincia davanti a pochi spettatori e agli occhi colmi di lacrime dell’unico amico rimasto al suo fianco.
Questa scena ha attraversato come un lampo la mente del non più giovane autore di questo articolo, mentre leggeva quello dedicato all’ultima disavventura in ordine di tempo di Andy Murray, che a causa del Covid-19 ha dovuto rinunciare all’Australian Open. Anche a causa dell’impossibilità di competere in Australia, qualche giorno dopo Andy ha deciso di confermare la sua presenza a Biella per il challenger che si disputerà in concomitanza con la seconda settimana dello Slam australiano, dal 15 al 21 febbraio. Ha poi addirittura deciso di raddoppiare la dose e chiedere una wild card per le qualificazioni (sì, avete capito bene!) del challenger di categoria inferiore che si gioca sempre a Biella la settimana precedente, a partire da lunedì 8 febbraio, poiché tutte le wild card per il tabellone principale erano già state assegnate.
Dal ritiro ai quarti del challenger di Mons (Belgio) nel 2005, quando aveva diciotto anni, Murray ha giocato appena altre tre partite nel circuito challenger – a Maiorca nel 2019, in piena convalescenza, dove è stato fermato agli ottavi dall’italiano Matteo Viola.
Murray non emulerà mai Macigno Rivera, ma il lungo calvario sportivo che questo atleta sta attraversando con stoica perseveranza, ci ha fatto sorgere una domanda: cosa significa per un campione ritirarsi? Cosa significa “…confrontarsi con Trionfo e Rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori…”, sentire una folla immensa cantare il tuo nome e leggerlo sulle prime pagine dei giornali e poi d’improvviso trovarsi seduti in poltrona, a guardare le gesta di atleti “che porco giuda potrei essere io qualche anno fa”?

Lo status di campioni ci è più distante di Saturno, ma crediamo che passare dalle luci della ribalta alla penombra dei ricordi non sia facile; se poi al disagio psicologico si aggiungono considerazioni di natura economica, compiere scelte che a uno spettatore imparziale parrebbero ovvie può diventare difficile. Per quale ragione – per esempio – il quasi quarantaduenne Ivo Karlovic dovrebbe rinunciare a guadagnare qualche centinaio di migliaia di euro all’anno giocando a tennis? Per dedicarsi alla pulizia delle orecchie delle giraffe? Fossimo nei suoi lunghi panni continueremmo a servire ace. Il tennista croato non costituisce un caso isolato nel tennis maschile; giocatori ben più illustri di lui hanno continuato a inseguire (non per puro divertimento) una pallina da tennis ben oltre il loro apogeo, altri hanno deciso di ributtarsi nella mischia anni dopo essersi ritirati.
I campioni più famosi appartenenti alla prima categoria sono Ken Rosewall e Jimmy Connors (forse ce n’è un altro più celebre di loro ma non lo citiamo per amore e scaramanzia); alla seconda Bjorn Borg e Thomas Muster. Ken “muscle” Rosewall disputò il suo ultimo incontro ufficiale a Melbourne in singolare il 20 ottobre 1980 a quasi 46 anni d’età; seppure lontano dai fasti dei giorni migliori, a quella veneranda età questo australiano con il rovescio preso in prestito dall’Onnipotente era ancora il numero 61 del mondo. Jimmy Connors giocò l’ultima partita ad Atlanta – un doppio – il 29 aprile 1996, all’età di 43 anni; in singolare occupava la posizione numero 413 al mondo.
Ma mentre Rosewall giocò un discreto numero di tornei sino alla fine della carriera, l’americano tra il 1993 e il 1996 ne disputò complessivamente soltanto undici. La sua ultima stagione a tempo pieno fu il 1992 in cui si presentò ai nastri di partenza di 17 eventi e il suo ultimo grande acuto sportivo avvenne l’anno precedente. Lo statunitense cominciò il 1991 alla posizione numero 936 della classifica e la risalì sino a giungere alla numero 174 alla fine di agosto. Un recupero notevole ma non sufficiente per entrare nel tabellone dell’ultimo major della stagione, lo US Open. Gli organizzatori decisero quindi di concedergli una wild card che a lui regalò un’estate indimenticabile e a noi una nuova puntata della serie “storie di tennis”.
LA CALDA ESTATE DI JIMBO
Il primo match di Connors fu programmato nella sessione notturna per permettere al maggior numero di persone di assistere a quella che poteva essere l’ultima rappresentazione di una carriera memorabile. Jimbo non era mai stato nelle grazie del pubblico newyorkese, ma ora che appariva come un leone in disarmo non c’era ragione per non fare il tifo per lui, e nonostante anche il suo primo avversario fosse un altro statunitense, Patrick McEnroe, la folla quella sera lo sostenne all’unanimità.
Patrick all’epoca aveva 25 anni, era il numero 35 del mondo e – pur essendo un giocatore infinitamente meno dotato di suo fratello John – era un tennista molto solido. “Quando vidi il nome del mio primo avversario pensai che fosse buffo trovarlo al primo turno. Poi mi resi conto che era Patrick e non John” dichiarò anni dopo Connors. Bastarono però appena due set, tre game e tre punti per far pensare agli organizzatori di aver sprecato una wild card. Connors era infatti sul punteggio di 4-6 6-7 0-3 e doveva annullare tre break point consecutivi. “Ero convinto – affermò McEnroe jr – che Jimmy fosse spacciato e che io avessi già vinto”.
“In quel momento – affermò Connors – volevo solo prolungare la partita a qualunque costo. Ma l’aver salvato il turno di servizio cambiò il mio stato d’animo. Il pubblico entrò nel match e mi sembrò di avere qualcuno al mio fianco che mi sospingeva verso la vittoria”. E vittoria fu dopo 4 ore e 20 minuti di battaglia terminata all’una e trenta del mattino. “Jimmy ha saputo sfruttare il favore del pubblico. Oggettivamente se fossi stato davanti al televisore sarei stato il suo primo sostenitore” commentò a mente fredda McEnroe.

Sulle ali dell’entusiasmo nei due turni successivi il nostro protagonista superò con disarmante facilità Schapers e il numero 11 del mondo Karel Novacek e fu così che si trovò ancora vivo e vegeto all’inizio della seconda settimana del torneo. Il suo avversario agli ottavi di finale era il ventiquattrenne statunitense Aaron Krickstein, alias ‘Aronne’ nelle cronache e negli articoli di Gianni Clerici.
Krickstein fu un prodigio di precocità. È a tutt’oggi il tennista più giovane ad avere raggiunto la top 100 e la top 10, rispettivamente a 16 anni e 2 mesi e a 17 anni e 11 giorni. La precocità fu probabilmente alla base degli innumerevoli problemi fisici che tormentarono questo giocatore sin dalla prima metà degli anni ’80 e che infine lo costrinsero al ritiro all’inizio del 1996 a 29 anni. Una via crucis che ricorda quella di un altro ragazzo prodigio coetaneo di Krickstein, del quale vi abbiamo tempo fa narrato le gesta: Kent “il diavolo” Carlsson.
Aronne era un regolarista/podista dotato di sopraffina intelligenza tattica con la quale era capace di disinnescare il gioco di qualunque avversario, come sapeva fare il suo amico e mentore Brad Gilbert. Ma la partita che lo attendeva quel giorno di settembre sotto il profilo ambientale e psicologico si giocava in una dimensione a lui sconosciuta; il caso volle anche che si disputasse il 2 settembre, giorno del compleanno di Connors che si presentò quindi in campo in uno stato di trance agonistica degna di un gladiatore romano.
Krickstein vinse il primo set e nel secondo – dopo aver recuperato in extremis al nono gioco il turno di battuta perso all’inizio del set – giunse al tie-break; sul punteggio di 7 pari Connors si portò a rete ed effettuò uno smash incrociato che finì sulla linea secondo il giudice di linea e fuori secondo il giudice di sedia che assegnò quindi il punto a Krickstein. Connors manifestò pacatamente al giudice il suo dissenso pronunciando – tra le altre – le seguenti parole: “Figlio di p…! Non hai il diritto di farmi questo! È il mio compleanno! Si vede nettamente il segno della palla sulla riga. Scendi dalla sedia! Forza scendi! Scendi”. Conseguenze disciplinari? Le stesse del match di semifinale del 1977 contro Barazzutti: nessuna.
Krickstein, evidentemente frastornato, perse quasi senza opporre resistenza i tre punti successivi e con essi il set. Riuscì a vincere il terzo parziale, perse il quarto e infine arrivò a due punti dalla vittoria con il servizio a disposizione sul punteggio di 5-3. “Pensavo che più il match durava e più ero favorito” dichiarò in seguito.
Si sbagliava. Connors gli tolse il servizio e poi vinse il gioco decisivo con il punteggio di sette punti a quattro. Prima di prodursi nello sprint decisivo, durante un cambio di campo Connors guardò dritto dentro la telecamera alle sue spalle e disse: “È per questo che la gente ha pagato il biglietto. È questo che sono venuti a cercare”. A caldo, sul campo pochi minuti dopo la vittoria al microfono dell’intervistatore affermò: “Vincere una partita 7-6 al quinto è ciò per cui vivo”.
Krickstein: “Ero diventato la preda e lui il cacciatore. Tutto lo stadio voleva che vincesse lui”. Guardando il volto di Aaron e quello di suo padre Herb nel corso del tie break finale si può forse intuire lo stato d’animo dei martiri cristiani al Colosseo.
Il quarto di finale contro l’olandese Paul Haarhuis fu programmato per la sessione notturna. Il fatto che Haarhuis avesse 15 anni meno di Connors e lo precedesse di 130 posizioni in classifica parevano dettagli ininfluenti per l’esito della partita. E tali si rivelarono. L’olandese – vinto il primo set – nel secondo si portò sul 5-4 con il servizio a favore ma si trovò a fronteggiare una palla break sul punteggio di 30-40. In quel preciso momento l’epica sportiva irruppe in campo: Connors “parò” con successo quattro smash consecutivi del suo avversario e infine conquistò il punto e il break con un passante di rovescio. Un punto oggettivamente sensazionale. Il boato del pubblico in risposta al gesto di esultanza di Connors “fu di un’intensità che non avevo mai sentito prima su un campo da tennis e non ho mai più sentito in seguito” affermò Haarhuis.
Il resto del match fu poco più che una formalità per Connors che conquistò in quattro set il diritto di disputare nuovamente una semifinale a New York a distanza di quattro anni dall’ultima.
La favola per Connors finì qui. Contro il ventunenne Jim Courier racimolò otto game in tre set, la standing ovation del pubblico al momento di lasciare il campo e 108 posizioni in più nel ranking.
Connors avrebbe disputato per l’ultima volta l’Open degli Stati Uniti l’anno successivo e perso al secondo turno contro Ivan Lendl. Il suo bilancio a New York è straordinario: detiene il record di partecipazioni in Era Open (22), di match giocati (115, record all time) e di match vinti (98, anche questo all time). Quanto ai risultati, tra il 1973 e il 1985 è sempre arrivato almeno ai quarti di finale del torneo e dodici volte consecutive è arrivato in semifinale, tra il ’74 e l’85. Sette finali raggiunte, cinque vinte e due perse. Chapeau.